Un’edizione speciale della rubrica questa che avete davanti: consigli, suggestioni di lettura tutti dedicati al Giorno della memoria che quest’anno arriva nel divampare crudo e crudele del mai finito confitto israelo-palestinese
Ritorna, dopo quasi un anno d’assenza, la rubrica Il lettore curioso. In mezzo c’è stato qualche problema di salute e, soprattutto, l’urgenza di concludere entro metà gennaio – missione compiuta – la stesura di un libro che uscirà in primavera. Di novità, e dei libri che negli ultimi mesi di lavoro ho dovuto accantonare, scriverò nella prossima rubrica. Qui, per il Giorno della memoria, trovate invece qualche libro dedicato al tema: appunti, recensioni che ho scritto nel corso degli anni. In un viaggio di tanto tempo fa, a Toledo, in fondo alla via che ospitava la casa-museo di El Greco vidi la vecchia sinagoga, abbandonata nel 1492 quando i ‘re cattolici’ espulsero dalla Spagna gli ebrei sefarditi. Posata accanto a un muro, all’ingresso, c’era la lapide funeraria dedicata a una ragazzina di dodici anni. C’era scritto, lo ricordo come se ce l’avessi davanti agli occhi: “Dona Fadueña descanse en gloria. Princesa gloriosa en lo interior”. Un popolo che dopo persecuzioni millenarie considera i suoi figli “principi gloriosi dentro di sé” merita rispetto e amore. Lo pensai allora, colpito e commosso, e continuo a pensarlo oggi. E penso, per quanto sostenga il diritto dei palestinesi ad avere un loro stato e non mi piaccia l’attuale governo di Israele, che quello di Hamas lo scorso ottobre sia stato un barbaro atto di genocidio. Nessun idiota che brucia bandiere o assalta stand israeliani riuscirà a farmi cambiare idea.
Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943, Sellerio, 1993
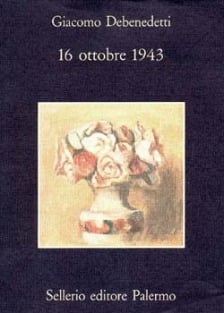
«Fino a poche settimane fa, ogni venerdì sera, all’accendersi della prima stella, si spalancavano tutte le grandi porte della Sinagoga, quelle verso la piazza del Tempio. Perché le grandi porte, invece delle bussole laterali e un po’ recondite come tutte le altre sere? Perché invece degli sparuti candelabri a sette bracci, quello sfavillare di tutte quante le luci, che traeva fiamme dagli ori, splendore dagli stucchi – gli stemmi di Davide, i nodi di Salomone, le Trombe del Giubileo – e sontuosi bagliori dal broccato della cortina appesa davanti all’Arca Santa, all’Arca del Patto col Signore? Perché ogni venerdì, all’accendersi della prima stella, si celebrava il ritorno del Sabbato. Non la macilenta salmodia del cantore sperduto sul lontano altare; ma dall’alto della cantoria, nella romba osannante dell’organo, il coro dei fanciulli gloriava un cantico di sacra tenerezza, l’inno dell’antico cabbalista, “Lehà Dodì Lichrà Calà”: Vieni, o amico, vieni incontro al Sabbato… Era il mistico invito ad accogliere il Sabbato che giunge, che giunge come una sposa. Giungeva invece nell’ex-Ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l’agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. È venuta da Trastevere di corsa. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere, e questa le ha detto che il marito, il carabiniere ha veduto un tedesco, e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi-famiglia ebrei, da portar via con tutte le famiglie». Giacomo Debenedetti (1901-1967), il massimo storico della letteratura e critico del nostro Novecento assieme a Gianfranco Contini, racconta la deportazione degli ebrei romani, è stato detto, con la classica nobiltà con cui Manzoni redasse la Storia della Colonna Infame, con cui Defoe scrisse della Peste di Londra. Fa la cronaca di una pestilenza morale. «Non possiamo fare a meno di ammirarne la straordinaria forza dello stile, trasparente come il vetro. Sembra che a parlare, nel racconto di Debenedetti, sia la stessa realtà. Le frasi si susseguono, alte, nitide, disadorne, severe, e su ciascuna di esse grava il peso d’una pietà immensa. Al modo dei rintocchi d’un orologio, suonano le parole che portano all’implacabile conclusione», ha scritto Natalia Ginzburg. Pietà e dolore. E un’apologia del ghetto romano sorpreso dai lupi come un gregge di agnelli. Gli ebrei creature diurne, anche se l’iconografia dell’antisemitismo li ha raffigurati a tramare nell’oscurità. Gli ebrei ingenui come bambini, a smentire una consolidata fama di diffidenza: e infatti credono di essere al sicuro dai nazisti perché soltanto un mese prima hanno pagato a Herbert Kappler una taglia di cinquanta chili d’oro. E infatti non prestano fede all’allarme lanciato da Celeste, la donna dai capelli scarmigliati.
Una bella pagina ricorda l’aiuto della città: «Ormai tutta Roma aveva saputo del sopruso tedesco, e se ne era commossa. Guardinghi, come temendo un rifiuto, come intimiditi di venire a offrir dell’oro ai ricchi ebrei, alcuni “ariani” si presentarono. Entravano impacciati in quel locale adiacente alla Sinagoga, non sapendo se dovessero togliersi il cappello o tenere il capo coperto, come notoriamente vuole l’uso rituale degli ebrei. Quasi umilmente domandavano se potevano anche loro… se sarebbe stato gradito… Purtroppo non lasciarono i nomi, che si vorrebbero ricordare per i momenti di sfiducia nei propri simili. Torna a mente, e par bella, una parola ripetuta anche da George Eliot: il latte dell’umana bontà».
Ai nazisti l’oro non basta. Viene razziata la Sinagoga, vengono rubati i codici preziosi della Biblioteca del Collegio Rabbinico, con un paleografo in divisa delle SS a capo dei ladri. Poi tocca alla popolazione. Sorpresa in un’alba livida, caricata a bordo dei camion, ammassata nel Collegio Militare, poi condotta a Roma-Tiburtino e stivata su carri bestiame.
«Né il Vaticano, né la Croce Rossa, né la Svizzera, né altri Stati neutrali sono riusciti ad avere notizie dei deportati. Si calcola che solo quelli del 16 ottobre ammontino a più di mille, ma certamente la cifra è inferiore al vero, perché molte famiglie furono portate via al completo, senza che lasciassero traccia di sé, né parenti o amici che ne potessero segnalare la scomparsa».
Scritta nel novembre 1944, a guerra non ancora conclusa, la cronaca della deportazione del Ghetto termina qui. Due mesi prima, nel settembre 1944, Giacomo Debenedetti aveva scritto invece Otto ebrei, un pamphlet pacato ma tagliente come una lama, definitivo come una condanna che non prevede appello. Lo spunto polemico era stato offerto dal processo a un commissario di PS, Raffaele Alianello, incaricato di verificare le liste degli uomini destinati alle Fosse Ardeatine e di radunarli per il massacro. Per difendersi, per costruirsi un attestato di benemerenza che attenuasse il suo ruolo di aiutante dei boia, Alianello aveva raccontato di aver fatto cancellare, tra i dieci nomi in soprannumero della lista, otto ebrei e due nomi scelti a caso.
Debenedetti è implacabile nello smascherare il voltagabbana: «Occorre dar subito, dare abilmente, tra le righe, la prova provata, palmare che, mentre i cattivi collaboravano coi ‘nazifascisti’, noi eravamo invece tra i buoni. Ma il problema, in fondo, è semplice. Quello che ieri era nero oggi è diventato bianco, e viceversa. Qual era, sul cartellino segnaletico del fascismo, il connotato più caratteristico? Quali le impronte digitali del fascismo? Diamine, la persecuzione degli ebrei. Quale, di conseguenza, il più incontrovertibile connotato dell’antifascismo? La protezione degli ebrei. I fascisti, quando comandavano loro, deploravano: peggio, punivano il pietismo verso gli ebrei. Mostriamo di esser stati pietisti, di avere avuto questo coraggio, e risulteremo senz’altro iscritti, iscritti d’ufficio, senz’ombra di contestazione, nei ranghi dell’antifascismo. Dài, giovinotto, attàccati agli ebrei, tutto fa brodo, anche la carne sbattezzata». La conclusione di Debenedetti è perentoria: la persecuzione continua. È diventata, se così si può dire, “congiura dell’amore”. Scrive il grande critico: «Un aperto e umanissimo scrittore ha bollato la mostruosità delle leggi razziali, osservando che esse colpivano “non le azioni responsabili delle creature umane, ma il delitto di essere nati”… Pace ai nostri morti. Ma i vivi, che non capirono e non capiscono il perché della persecuzione, è giusto che si allarmino oggi di un’indulgenza altrettanto regalata. Questo di chiudere tutti e due gli occhi, di creare eccezioni a vantaggio degli ebrei, non è un modo di riparare dei torti. Riparazione sarebbe rimettere gli ebrei in mezzo alla vita degli altri, nel circolo delle sorti umane, e non già appartarnerli, sia pure per motivi benigni. Questa è una antipersecuzione: dunque, fatta delle medesima sostanza psicologica e morale che materiava la persecuzione. Se prima negli ebrei si puniva l’ebreo, oggi al vedere la situazione, non già corretta, ma semplicemente capovolta con sì perfetta simmetria di antitesi, può nascere il dubbio che negli ebrei si perdoni l’ebreo. E il perdono richiama l’idea di una colpa, di un trascorso». (2011)
Edmund De Waal, Lettere a Camondo, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri, 2021

Il romanzo di una casa. Di un uomo e della sua famiglia, nella prospettiva accorciata della casa. Nel 1910 il conte Moïse de Camondo rade al suolo l’abitazione dei genitori, al 63 di rue de Monceau (nel ‘brutto’ quartiere ottocentesco di Monceau, residenza dell’alta borghesia ebraica, abitava anche Marcel Proust, e in rue de Courcelles e nel Parc Monceau prende le mosse, in anni recenti, Al pianoforte di Jean Echenoz). Prima ha messo all’asta o donato le loro quadrerie e i loro parafernalia ottomani ed ebraici. Perché i Camondo sono banchieri di origine costantinopolitana, transitati per l’Italia dove vengono nobilitati da Vittorio Emanuele II le cui guerre finanziano, e infine approdati in Francia. E tra il 1911 e il 1914 la fa ricostruire dall’architetto René Sergent, ispirandosi al Petit Trianon di Versailles. Neoclassicismo, culto del Settecento, immedesimazione nella Francia patria di adozione: i mobili preziosi (ce n’è uno ammirato da Stendhal, un tavolo alla Tronchin), le arti decorative, le decine di fondazioni culturali e benefiche che finanzia con munificenza. Il tentativo, generoso quanto (ex post) disperato, di integrarsi in una patria, di darsi una nuova identità. Moïse de Camondo muore nel 1935 e la sua abitazione donata allo stato francese diventa museo intitolato al figlio Nissim. Ha fatto in tempo a vedere fuggire la moglie Irène Cahen d’Anvers, ritratta bambina da Renoir, con lo spiantato conte Sampieri; a ricevere la notizia che Nissim al quale il palazzo e la sua collezione erano destinati, pilota francese nella Grande Guerra, è stato abbattuto dai tedeschi. Non farà in tempo a vedere la tragedia dell’occupazione nazista, della deportazione degli ebrei, tra i quali la figlia Béatrice sposa di Leon Reinach e inghiottita da Auschwitz assieme al marito e ai due figli. Edmund De Waal, già autore del memorabile Un’eredità di avorio e ambra e lontano parente dei Camondo, approfitta di un periodo di studio presso l’archivio della casa-museo parigina per intrecciare le vicende della sua famiglia con Moïse de Camondo e per riflettere, nelle lettere a lui indirizzate che formano questo libro, sul senso dell’identità e del tempo, sulla voglia del collezionista di serbare memoria e ‘riordinare’ il mondo (puntuali i rimandi a Walter Benjamin e al suo lavoro sui ‘passages’ parigini). E per imboccare affascinanti sentieri laterali: l’arte e il cibo (c’è un bell’aneddoto su una natura morta di Manet, un mazzetto di asparagi che Charles Ephrussi acquista direttamente dal cavalletto: il pittore chiede 800 franchi, Charles gliene spedisce mille e qualche giorno si vede recapitare a casa, in aggiunta, un secondo quadro con un asparago), sulla malinconia, sulle serrature, sulle porcellane. Sulle eredità: quello che ricevi, quello che lasci. Risuona, come un’eco persistente, la sorte di altre famiglie: gli Ephrussi, i Reinach del bellissimo romanzo di Filippo Tuena. (2021)
Edmund De Waal, Un’eredità d’avorio e ambra, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri, 2011

Una vetrinetta di netsuke giapponesi: 264 sculture minuscole, d’avorio o di legno. Scimmie e draghi, piovre e castagne, monaci e calderai, volpi e lupi. Nate nel XV secolo, applicazione virtuosistica del “piccolo è bello”, fino al ‘900 servivano per fermare la cintura del kimono e appenderci la borsa del tabacco o delle medicine, le chiavi o altro.
Dalla seconda metà dell’800, però, i netsuke diventano altro e vanno altrove: si trasformano in oggetti da collezione per il nascente ‘nipponismo’ e, dopo le prime incette a buon mercato, le quotazioni si impennano. La vetrinetta con i 264 netsuke è il pezzo forte delle collezioni parigine di Charles Ephrussi, storico dell’arte e collezionista, intellettuale raffinato e mecenate generoso che sovvenziona gli ingrati e antisemiti per grettezza e vigliaccheria – sono gli anni dell’affaire Dreyfus – Renoir e Degas, protegge il poeta Jules Laforgue, è amico di Proust e gli ispira lo Swann della Recherche.
Donati al cugino viennese Viktor in occasione delle sue nozze, i netsuke vivono la fine degli Asburgo e sfuggono ai nazisti, li nasconde in un materasso una domestica fedele dopo che gli Ephrussi viennesi sono scampati per un soffio all’annientamento. Da Vienna andranno in Giappone dalla pecora nera della famiglia, il mondano Iggie che è sfuggito al destino di banchiere diventando gay e disegnatore di moda, per farsi infine buon soldato americano e, suprema ironia della sorte, abilissimo uomo d’affari, ciò che il padre non è riuscito a essere. Da Tokyo arriveranno alla destinazione finale di Londra, lasciati in eredità al pronipote Edmund de Waal, ceramista, storico dell’arte e professore universitario, e in questo romanzo-memoir narratore sapiente.
Un secolo di storia, nelle peregrinazioni parallele, nelle ascese repentine e nelle brusche cadute dei netsuke e dei loro padroni. Nati a Odessa mercanti di grano, gli Ephrussi (come i Rothschild, i Camondo, i Reinach) emigrano a Vienna e a Parigi. Diventano banchieri, intellettuali, avvocati, artisti. Si integrano nell’impero di Francesco Giuseppe e nella Terza repubblica francese, patrocinano artisti e finiscono nei libri: la Russia che li ha persi li ricorda con Babel; Vienna che li ha costretti a scappare li fissa nella memoria grazie a un altro esule di genio, Joseph Roth; la Francia, lo abbiano detto, li consegna all’immortalità artistica con Proust.
Un’eredità d’avorio e ambra è però più della straordinaria saga familiare che pure è (e che, per fortuna, contempla il lieto fine in terra inglese). Più della deliziosa rievocazione di un secolo d’arte. Più di un viaggio che tocca mezzo mondo. È la celebrazione della modernità e della prima globalizzazione, che gli Ephrussi rappresentano: capaci di compiere in un paio di generazioni un mutamento che altri non sono capaci di compiere in secoli; più avanti della loro epoca, capaci di brillare in più lingue e di essere versatili, di finanziare imperi e di tenersi in corrispondenza con Rilke; apolidi loro malgrado, benché sempre desiderosi di essere cittadini leali e sudditi fedeli.
Nell’invidia e nell’odio che suscitano, tra i molto poveri e tra i molto ricchi della prima metà del ‘900, entrambi convinti che basti appartenere a un luogo per vedersi piovere addosso la manna, che “sangue e suolo” valgano più del bisogno e del talento, gli Ephrussi e gli altri esponenti della grande borghesia ebraica, fra le più colte e civili che questa classe abbia espresso, sono la cartina del tornasole dell’anima più buia e feroce del secolo breve. E i minuscoli, affascinanti netsuke, sempre in viaggio e sempre un po’ fuori luogo, sono il loro correlativo oggettivo. (2015)
Umberto Eco, Il cimitero di Praga, Bompiani, 2010
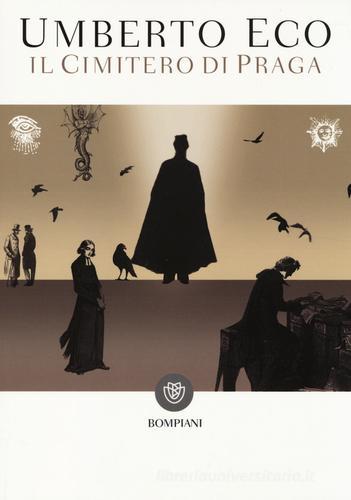
Ecco s’avanza uno strano ircocervo: un romanzo che incorpora ampi squarci della storia d’Europa da Napoleone alla fine dell’800, un saggio sull’antisemitismo e la costruzione dei falsi storici sotto forma di post-feuilleton coltissimo. Protagonista è Simonino Simonini, falsario e spia ossessionato dagli ebrei, che attraversa il secolo al soldo di tutte le bandiere commettendo le peggiori nequizie. Nato a Torino da un padre patriota che non vedrà quasi mai e cresciuto da un nonno bigotto e reazionario, Simonini ne erediterà gli odi (gli ebrei soprattutto, anche se arriverà fino all’età adulta senza averne conosciuto uno; ma anche il clero, i francesi, i tedeschi, le donne, in genere l’umanità) e gli amori (uno solo, la cucina, che offre il pretesto all’autore per fare una puntigliosa e soverchiante elencazione di ristoranti dell’epoca e di piatti per lo più sovraccarichi d’ingredienti e di molto laboriosa digestione).
L’arte del falsario Simonini la apprende a Torino, presso lo studio del notaio Rebaudengo che sarà il suo maestro e la sua prima vittima: testamenti per lo più, ma anche lettere e, su sollecitazione dei servizi segreti sabaudi, documenti dei più disparati. Il principio è uno solo: il documento non è falso, ma ‘ritrovato’. Non c’era finché il falsario non lo ha creato, ma avrebbe dovuto esserci. Anzi, come mai non c’era? Da falsario a spia, Simonini si infiltrerà fra i Mille al seguito di Dumas (e farà affondare la nave a bordo della quale Ippolito Nievo lascia la Sicilia) e in, seguito, emigrato a Parigi dove vivrà sotto le mentite spoglie di notaio e ‘brocanteur’, lavorerà per i francesi, i prussiani, i russi. E in proprio, facendo sovente il triplo e il quadruplo gioco.
Il curriculum di Simonini, personaggio-contenitore, uomo-cisterna o meglio ancora uomo-cloaca (chi legge il romanzo capirà perché) compendia mezzo secolo di spionaggio, di infamie e bassi servigi: la denuncia dei bombaroli che lui stesso induce a cospirare contro Napoleone III, l’aiuto agli uomini di Thiers contro i comunardi, l’ideazione di una fluviale produzione antimassonica, lettere tarocche di Victor Hugo, false prove che accusano il militare Alfred Dreyfus di spionaggio a favore dei tedeschi e nel 1894 lo fanno condannare all’ergastolo. Ma Dreyfus è ebreo e gli ebrei sono il principale, parossistico bersaglio di Simonini.
Al punto di fargli inventare, rubacchiando e adattando scene che Dumas e Sue avevano usato per Cagliostro e i gesuiti, l’idea di un complotto giudaico per dominare il mondo. La cospirazione sarebbe stata ideata da dodici rabbini nel cimitero di Praga, durante una riunione notturna. Questa invenzione grossolana si ingigantirà, la calunnia da venticello si farà ciclone, trasmigrando in versioni sempre più minuziose. Che finiranno di volta in volta nelle mani dello spionaggio prussiano, dei giornali cattolici, della stampa reazionaria, dei poligrafi che rovistano fra le immondizie e gli scarti della Biblioteca di Babele.
Fino a diventare ad opera dell’Ochrana, la polizia segreta dello zar che commissiona a Simonini l’ultima versione, il brogliaccio sul quale verranno costruiti i Protocolli dei Savi Anziani di Sion, il più infame falso storico della contemporaneità, che giustificherà i pogrom in Russia e avrà larga parte nell’ispirare il Mein kampf. Il nocciolo duro del libro sta qui: nella documentazione impeccabile e implacabile della revanche antisemita ottocentesca e dei vari filoni che vi confluiscono, dal cattolicesimo reazionario alle ideologie razzistiche, dal “socialismo degli imbecilli” (al quale Michele Battini ha dedicato di recente un bel saggio per Bollati Boringhieri) ai vari antimodernismi e irrazionalismi.
Assieme al falso storico che giustifica lo sterminio degli ebrei, Eco smonta le teorie del complotto, i meccanismi che producono dossier e falsificazioni. E se Simonino Simonini è un personaggio d’invenzione, veri e documentati sono tutti gli altri corifei dell’antisemitismo. Il gesuita Augustin Barruel (1741-1820), antilluminista e antigiacobino, al quale il nonno di Simonini – lui sì, personaggio storico – invia una lettera contro gli ebrei che ci è pervenuta. Il satanista – e amico dello scrittore Joris-Karl Huysmans, quello di A rebours – Joseph-Antoine Boullan (1824-1893). Il giornalista Edouard Adolphe Drummont (1844-1907), fondatore della Lega Antisemitica di Francia. L’impiegato postale, spia prussiana e romanziere da quattro soldi Hermann Goedsche (1815-1878) il cui Biarritz, nel 1868, è la prima opera narrativa a citare la riunione nel cimitero di Praga. L’avvocato e scrittore satirico Maurice Joly (1829-1878), il cui Dialogo all’Inferno fra Machiavelli e Montesquieu sarà una fonte dei Protocolli zaristi. Il fourierista, anglofobo e antisemita Alphonse Toussenel (1803-1885).
Il complotto è una fobia universale: «Io ho sempre conosciuto persone che temevano il complotto di un qualche nemico occulto, gli ebrei per il nonno, i massoni per i gesuiti, i gesuiti per mio padre garibaldino, i carbonari per i re di mezza Europa, il re fomentato dai preti per i miei compagni mazziniani, gli Illuminati di Baviera per le polizie di mezzo mondo, e via, chissà quanta altra gente c’è ancora a questo mondo che pensa di essere minacciata da una cospirazione. Ecco qua una forma da riempire a piacere, a ciascuno il suo complotto». Il complotto è in realtà un falso? Non importa, perché «la gente crede solo a quello che sa già, e questa era la bellezza della Forma Universale del Complotto». E anzi, per spie di professione come il sabaudo Bianco, «quando tutti i fatti appaiono del tutto spiegabili e verosimili, allora il racconto è falso». Perciò viva le cianfrusaglie, il rêpechage, il piccolo plagio: «Quando una spia vende qualcosa di inedito non deve fare altro che raccontare qualcosa che si potrebbe trovare in ogni mercatino di libri usati».
Il romanzo di Umberto Eco ha suscitato perplessità e consensi nella comunità ebraica italiana (tra i perplessi il rabbino Di Segni, tra i favorevoli Gad Lerner) ed è stato stroncato, con argomentazioni che non convincono, da Lucetta Scaraffia per l’Osservatore Romano. Secondo l’articolista del quotidiano vaticano il libro potrebbe suscitare, per la sua tematica, nuovi rigurgiti antisemiti. L’accusa è labile. Non ho voglia di fare polemiche e non mi piace l’anticlericalismo. Ma sospetto che la stroncatura di Lucetta Scaraffia nasconda una lunga coda di paglia. Perché alla Chiesa cattolica va la paternità dell’antisemitismo. E, anche nel Cimitero di Praga, sono purtroppo veri i gesuiti che tramano, come è vero il Leone XIII che riceve in udienza il cialtrone e mistificatore marsigliese Léo Taxil, il personaggio più incredibile di tutti nel romanzo di Eco, forse il più vero di tutti nei dettagli. Che, da pornografo anticlericale (Le amanti del Papa) si converte diventando crociato cattolico contro i massoni e gli ebrei che governano occultamente la massoneria, salvo rivelare con grande scandalo, qualche tempo dopo l’udienza, che la sua conversione era falsa, come una simulatrice era la satanista-palladiana Diana Vaughan di cui aveva scritto le memorie, e la cui conversione apocrifa aveva ricevuto il plauso di santa Teresa del Bambin Gesù.
Code di paglia e imbarazzi: chi teme l’antisemitismo di oggi dovrebbe dare un nome all’antisemitismo di ieri, soprattutto se, come Lucetta Scaraffia, per mestiere fa lo storico. Perché il protagonista si chiama Simonino? Perché suo nonno venerava San Simonino, un bambino di Trento morto nella Pasqua del 1475. «Fanciullo trucidato crudelmente dai Giudei, autore di molti miracoli» si legge nel Martirologio Romano. Parole in auge fino al 1965. Dopo Hitler. Nel 1965 il culto venne proibito, il beato rimosso dal calendario e la processione che ogni anno lo celebrava, portando a spasso i suoi resti e gli strumenti che erano serviti per torturare e uccidere quindici ebrei, colpevoli di un omicidio inventato, fu abolita.
Alla Chiesa cattolica il merito del rimedio, alla Chiesa la responsabilità dell’infamia originale. Perché non ricordarlo? Se esistono omissioni e rimozioni simili, se qualcuno ha ancora il mal di pancia, il libro di Umberto Eco è importante. Perché riporta alla memoria una storia dell’infamia che non è nota come meriterebbe. Perché può spingere qualche lettore a leggere la terribile e fondamentale Storia dell’antisemitismo di Leon Poliakov (quattro volumi La Nuova Italia/Sansoni, più un quinto volume che si spinge fino al 1993). (2010)
Ferruccio Fölkel, Storielle ebraiche, Rizzoli, 1988

Ferruccio Fölkel (1921-2002), triestino di origine ungherese, Fery per gli amici, è stato dirigente editoriale (Mondadori) e scrittore: poesie e uno zibaldone per Guanda e Studio Tesi, un volume con Carolus L. Cergoly (Trieste provincia imperiale, Bompiani) che affetta giudiziosamente il mito asburgico, e La Risiera di San Sabba, sul più tristemente noto dei lager nazisti in Italia. Soprattutto, ha raccolto in tre volumi per Rizzoli le Storielle ebraiche. Questo è il primo.
Il fiore dell’umorismo yiddish, recita il sottotitolo. Askenaziti sparsi tra Parigi e Vienna, la Polonia e l’impero russo, con recenti propaggini americane, introdotti da un bel saggio (“Il sorriso degli ebrei”). Che parte dalla Bibbia, ricordando come il sorriso non sia di casa nel testo sacro, e termina con Jahve, passando per Freud e Bergson, ebrei e indagatori non casuali del riso e del motto di spirito, e sfiorando con molti altri anche Italo Svevo (è vero, non ci avevo mai pensato: La coscienza di Zeno è anche un’espressione dell’umorismo ebraico).
«Jahve non è un Dio ‘buono’, con lui bisogna trattare con cortesia ma anche con astuzia; la sorte degli ebrei è sempre stata incentrata sulla necessità di doversi difendere per sopravvivere. Quando uno è costretto ad aguzzare il cervello, non piange. Piuttosto alla fine ride: si ride e si sorride quando si è salvi, quando si ha in pugno la situazione. Anche se Hitler non è morto: ha soltanto cambiato divisa».
Così introdotti, gli ebrei di Fölkel, tra storielle e witz, danno vita a una dialettica serrata. Tra l’uomo e la divinità o almeno i suoi intermediari, l’uomo e la donna (e qui entra in scena una figura essenziale della yiddishkeit, lo shadchen, il sensale di matrimoni), fra ebrei e cristiani (rabbini e vescovi, rabbini e pope), fra ricchi e poveri (altra figura centrale di questa “commedia dell’arte” è lo shnorrer, il mendicante girovago e insolente che interloquisce con i Rothschild e gli Schmitz). Resistendo a guerre, pogrom, tradimenti, tabù alimentari e rovesci di fortuna.
Difficile dire quale, fra le 327 storielle della raccolta, sia la più folgorante. Io scelgo il vertiginoso domanda e risposta-domanda (gli ebrei rispondono sempre a una domanda con una domanda, si spiega in un’altra storiella) dei due ebrei alla stazione.
«Parti. E vai molto lontano?»
«Lontano da dove?»
Saint-Exupéry la amò molto e la considerò il perfetto emblema dell’assenza, della condizione di apolidi nell’anima al di là di piccole o grandi patrie. E Claudio Magris utilizzò la risposta per dare il titolo a un suo bellissimo libro giovanile su Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale. (2010)
Wlodek Goldkorn, Il bambino nella neve, Feltrinelli, 2016

«Zia Chaitele era cugina di mio padre. Chaitele è il diminutivo di “Chaia”, vita in ebraico. Sapevo che durante la guerra si era nascosta in una foresta. Lei diceva proprio così, nella foresta, senza mai farne il nome. E non parlava di quello che aveva subito.
Ho nutrito molte fantasie su questa storia segreta. Poi me l’ha raccontata mia sorella, che l’aveva saputa dalla mamma. E tra donne se l’erano tenuta per loro.
Era inverno. Chaitele, assieme ai suoi compagni, ebrei, dovette fuggire in fretta dal nascondiglio. Aveva un bambino piccolissimo. Lo abbandonò nella neve.
Lei si salvò».
Il primo, terribile capitolo (anzi, il capitolo zero) non tragga in inganno. Non c’è ricerca dell’effetto, non c’è corteggiamento del dolore. C’è angoscia, senso del vuoto: da affrontare e combattere senza lasciarsene inghiottire. C’è, in tutto il libro, nobiltà d’animo e riflessione pacata sul come dire l’indicibile, su come fare i conti con il Male e con quella cosa labile che è la memoria.
Il bambino nella neve è la storia di una famiglia di ebrei polacchi, i Goldkorn, che si salvano perché nel 1939 riparano in Unione Sovietica. Una famiglia di ebrei polacchi comunisti («Per i miei genitori e per molti loro amici il comunismo era un modo di vivere – una specie di ideale di fratellanza e giustizia cui essere fedeli, senza però prendere le cose alla lettera, ma anzi con un’ironia dovuta al fatto che le persone non sono perfette e i leader sono spesso ridicoli e non all’altezza del compito») che ritornano in Polonia nel dopoguerra. A Katowice, città di miniere e di aristocrazia operaia, poi a Varsavia.
Il ‘vuoto’, parola che nel libro ricorre spesso, non è annichilimento metafisico ma esperienza reale: ricominciare a vivere – in una casa dove anche i mobili e le stoviglie sono marchiate con le svastiche – tra le macerie e le assenze. Tre milioni di ebrei polacchi si sono ridotti a 300mila: case distrutte, esistenze cancellate, la geografia della vita degli affetti e delle amicizie diventata deserto. In un dopoguerra che conosce gli ultimi fuochi dei pogrom la vita riprende qui, tra i fantasmi. Perché altrove non avrebbe senso.
Polacco per scelta, Wlodek Goldkorn, nonostante i polacchi. O meglio perché non ci si chiama fuori da quel che ci tocca in sorte. Fino all’esilio, dei 300mila superstiti resteranno in Polonia diecimila. Avviene nel 1967, quando Gomulka – si è da poco conclusa la Guerra dei Sei Giorni – paragona Israele alla Germania nazista e invita gli ebrei ad andarsene. «Avevo quindici anni e diventai uno straniero in patria, un nemico interno, una quinta colonna».
Ed ebreo, profondamente ebreo, ma senza miti e retoriche. Senza cedere per esempio alla nostalgia dell’Ostjudentum, senza tessere l’elogio dello shtetel, il villaggio ebraico esteuropeo che abbiamo imparato a conoscere con Joseph Roth, Shalom Aleichem, i fratelli Singer: per Goldkorn simbolo dell’arretratezza, di un passato piccolo e feroce da cui fuggire. E senza sentirsi del tutto a casa in Israele. Dove lo infastidisce l’arroganza dei ‘sabra’, gli ebrei nati lì che imputano agli ebrei inermi d’Europa il fatto stesso di essere stati vittime della Shoah. C’è un termine agghiacciante che i sabra adoperano per i superstiti con il marchio del lager tatuato sull’avambraccio: ‘saponette’. Mentre per i magrolini c’è il termine ‘Biafra’. «I ragazzotti (i polacchi antisemiti e gli israeliani specialisti nel rintracciare le saponette e i Biafra) sapevano di poter essere identificati con tutti i boia di questa terra, quelli del passato come del futuro? Io credo di sì. E credo che identificarsi con i carnefici faccia piacere».
Ci sono altre esperienze sgradevoli che lo spingono a lasciare Israele. L’autista d’autobus che insegue un bambino arabo spaventato e frena a pochi centimetri da lui: «Cosa volete è un piccolo arabo, meno ce ne saranno, meglio staremo». Il sergente che gli intima di puntare il fucile contro un altro bambino arabo e, al suo rifiuto, minaccia di deferirlo alla corte marziale e lo insulta: gli amici degli arabi come lui, dice, andrebbero cancellati dalla faccia della terra, sono la vergogna del popolo di Israele.
Non vorrei che ci fossero equivoci: Wlodek Goldkorn, come tutte le persone civili, difende il diritto di Israele a esistere come Stato. Ma non si trova a suo agio tra i fanatici, da nessuna parte. E trova sbagliato fare della memoria, segnatamente della memoria della Shoah, un esercizio retorico e consolatorio. Per Goldkorn la memoria è labile e frammentaria, non può essere ingabbiata nel ‘mai più’ se il mai più viene smentito, ai danni di altri, sotto i nostri occhi.
Parlando della viltà dell’Occidente verso Sarajevo e ricordando una bellissima intervista a Marek Edelman eroe del Ghetto di Varsavia che Goldkorn elegge a maestro di vita e vice-padre, la conclusione è netta: «La memoria va usata, strumentalizzata, giocata politicamente: anche la memoria della Shoah. Ma bisogna saperla usare alla maniera giusta. Giusta eticamente, esteticamente, politicamente. La memoria della Shoah serve a difendere gli oppressi, i derelitti, coloro cui il potere toglie persino la voce. E del resto sarebbe stato Marek a dire e ripetere più tardi, a guerra dei Balcani conclusa e davanti ai barconi dei profughi sul Canale di Sicilia: nessun muro ha mai protetto il ghetto dei ricchi. Penso che si possano paragonare i barconi alle camere a gas, quando è il caso…».
Se la memoria va fatta agire oggi perché aiuti, soccorra, ripari il mondo, Auschwitz e gli altri campi di sterminio vanno desacralizzati. Questo, e molto altro, dicono le pagine lucide e straziate del ritorno in quei luoghi. Per Wlodek Goldkorn sono cimiteri e Auschwitz è il suo cimitero di famiglia. «Auschwitz sembra un luogo postmoderno, inventato per rappresentare gli orrori del Novecento e per esserne il simbolo. Io, invece, odio Auschwitz, vorrei vederla distrutta, rasa al suolo, ridotta al nulla; perché questo è un luogo maledetto che non dovrebbe e non sarebbe mai dovuto esistere e che non può essere, in alcun modo, riabilitato».
Il bambino nella neve termina così:
«L’ebraismo è tempo e non luogo.
L’anno prossimo a Gerusalemme significa l’anno prossimo nel tempo dopo il tempo, l’anno prossimo il Messia.
Ma, ammesso che il Messia verrà, la sua venuta sarà irrilevante.
Eppure dobbiamo fare come se lo aspettassimo». (2016)
Vasilij Grossman, L’inferno di Treblinka, traduzione di Claudia Zonghetti, Adelphi, 2010

«A est di Varsavia il fiume Bug si allunga fra sabbie e paludi, boschi fitti di pini e latifoglie. Sono luoghi deserti e desolati, con qualche raro villaggio. Chiunque si trovi a passarvi evita accuratamente quei sentieri stretti e sabbiosi dove i piedi affondano e le ruote finiscono nella rena fino al mozzo». Il primo reportage sul campo di sterminio nazista di Treblinka lo scrive nel 1944 il giornalista e romanziere sovietico Vasilij Grossman. Corrispondente di guerra per Stella Rossa con oltre mille giorni al fronte, arriva nel mattatoio quando di Treblinka, dopo l’eroica rivolta dei prigionieri di un anno prima, non restano che le macerie. Dà la parola ai pochi superstiti, interroga decine di carnefici, descrive i campi che continuano a restituire ossa, quaderni, fotografie, capelli, poveri effetti personali delle moltitudini assassinate.
Nelle pagine implacabili del suo resoconto emerge con nettezza questa catena di montaggio della morte: tre milioni di vittime, calcolate per difetto, in tredici mesi di attività. E vengono raccontate con asciutto furore tutte le stazioni del calvario: la meticolosa efficienza del campo («Parsimonia, precisione, oculatezza, attenzione maniacale alla pulizia sono caratteristiche tutt’altro che negative e tipiche di molti tedeschi. Se applicate all’agricoltura o all’industria danno il giusto frutto. L’hitlerismo le applicò ai crimini contro l’umanità: le SS del campo di lavoro polacco agivano come se stessero coltivando patate o cavolfiori»), l’avvio verso le camere a gas e in seguito verso i forni, il sadismo degli aguzzini; gli estremi gesti di dignità delle vittime, la macabra contabilità dei beni requisiti; il tentativo estremo e forsennato, dietro ordine di Himmler, di cancellare le tracce della strage. Il reportage di Grossman è un inno alla vita e all’umanità sotto forma di memoria dell’orrore: «Esseri umani nudi ai quali è stato tolto tutto restano tenacemente mille volte più umani delle bestie in divisa nazista che li circondano». E un monito agli ignavi e agli smemorati: «Leggere di queste cose è durissimo. E credetemi, voi che leggete, non è meno duro scriverne… Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Chiunque giri le spalle, chiuda gli occhi o passi oltre offende la memoria dei caduti». Perché, scrive Grossman nella chiusa: «Dobbiamo tenere a mente che di questa guerra il razzismo, il nazismo non serberanno soltanto l’amarezza della sconfitta, ma anche il ricordo fascinoso di quanto sia facile uno sterminio di massa».
Quando scrive queste pagine Vasilij Grossman ha trentanove anni: è un ebreo ucraino assimilato, un militante bolscevico, un romanziere di edificante realismo socialista, il più popolare e seguito dei corrispondenti di guerra sovietici. Ha tuttavia seguito l’assedio di Stalingrado e la sconfitta delle armate naziste di von Paulus e proprio lì, nell’eroismo di quella pagina che avrebbe contribuito in maniera determinante alla sconfitta di Hitler, le sue certezze granitiche hanno cominciato a incrinarsi.
Perché ha visto le similitudini, le affinità dei due stati-partito, delle due tirannidi, dei due totalitarismi. Da Stalingrado comincerà per Grossman il rovello, intellettuale e artistico, che lo porterà a creare il capolavoro Vita e destino e a finire ai margini: morto Stalin non si corre forse più il rischio della fucilazione o del gulag, ma la condanna al silenzio permane. Così, il manoscritto di Vita e destino verrà sequestrato dalla polizia segreta e il libro vedrà la luce postumo in Svizzera (Grossman muore nel 1964), dove è arrivato in maniera avventurosa. Chi legge queste pagine, veda in loro il primo germoglio di un capolavoro. (2010)
Marina Jarre, Ritorno in Lettonia, Einaudi, 2003

Ci sono libri che fanno vibrare corde profonde, che interrogano chi li legge. A me è accaduto con Ritorno in Lettonia. Non conoscevo Marina Jarre (1925-2016) se non per sommarie informazioni: una scrittrice torinese circondata dall’aura degli autori einaudiani, i titoli delle sue opere, non molto altro. Con questo libro, con questa “autobiografia aggiustata” (la definizione è dell’autrice) ho cominciato a conoscerla e continuerò a leggerla, perché della sua arte mi interessa il nocciolo duro che riguarda, lo dice Claudio Magris, «l’identità e la sua incertezza e la sua polivalenza; la frontiera o meglio le frontiere e il loro rapporto con la scrittura; la continua perdita o riconquista della propria persona».
Ritorno in Lettonia narra, con molte necessarie divagazioni che riannodano i fili di un’esistenza e connettono la vicenda personale alle tragedie collettive, un viaggio compiuto, oltre sessant’anni dopo la fuga precipitosa, nei luoghi dove l’autrice è nata e cresciuta. Dice ancora Magris: «Il senso dell’arte di Marina Jarre risiede, si potrebbe dire, nella stratificazione della Storia nella sua memoria, talora in un suo fondo di oblio. (…) Quel lavoro di disseppellimento che è la narrativa di Marina Jarre, ritrovamento e creazione di vita che è anche costruzione di se stessa, come dice splendidamente la scrittrice: “Come donna sono dovuta nascere da me stessa, mi sono partorita insieme ai miei figli”».
Riga, 1925. Clara Coisson (1896-1981), piemontese di famiglia valdese e di forte tempra calvinista, è lettrice di italiano presso la locale università. Si è laureata nel 1922 a Magistero, dopo l’esperienza in Lettonia dirigerà dal 1940 al 1943 l’Istituto di cultura italiana a Sofia, in Bulgaria. Nel secondo dopoguerra insegnerà e sarà una delle grandi traduttrici dal russo per Einaudi e Frassinelli. A Riga, la giovane e inflessibile Chiara conosce un ebreo affascinante, Samuel Gersoni.
Figlio di pellettieri, Gersoni ha trascorso qualche anno in Russia, è stato anche nell’Armata Rossa. Poi ha fatto l’allenatore e il rappresentante della Michelin per i paesi baltici. L’industriale no, appena riceve in eredità l’azienda paterna di pellami la cede subito a un cugino e per qualche anno folleggia con i proventi. Clara e Samuel si sposano, il matrimonio dura dieci anni ed è costellato di splendori e miserie: regali sontuosi, pony e bambole a Marina ‘Minni’ e alla sorella minore Annalisa detta Sisi, che negli anni ’70 sarà segretaria di redazione di Tuttolibri; brillanti a Clara, uno viene scagliato in faccia a Samuel durante una lite e non verrà più restituito; e periodi in cui Samuel va in giro con il cappello in mano. Soprattutto, il matrimonio è costellato di scenate furibonde: Samuel è un uomo che ama le donne e Clara non tollera i ripetuti tradimenti. Si separano e Clara, temendo che le vengano sottratte le figlie, fugge in Italia con loro.
Marina e Sisi approdano a Torre Pellice, capitale del piccolo mondo resistente dei valdesi, dei ‘barba’ che riuscirono a sopravvivere ai progetti sterminatori dei Savoia e di Luigi XIV. Vengono cresciute dalla nonna materna; Marina che fino a quel momento ha parlato in tedesco (e anche in russo e in polacco, non in lettone) continua a corrispondere in tedesco con la madre. Le lettere sono a volte inquietanti: «Si è rifatto vivo il brigante» scrive la bambina Marina, è il padre che le va a trovare due volte e il cui appello estremo a essere salvato («Ricordatevi che anche voi siete ebree» scriverà nell’ultima lettera alle figlie) resta inascoltato. Perché nessuno può immaginare la tragedia all’orizzonte, perché c’è un grumo di rancori duro da sciogliere.
Imparerà l’italiano come una lingua straniera, Marina Jarre, e qualche esitazione, qualche inflessione inconsueta affiora «nell’asciutta maestria del suo stile». Lei stessa scriverà: «La lingua di mia madre, divenuta forse quella dei miei sogni – ma i sogni hanno davvero accordi e grammatica, o non parlano nella nostra anima, e intanto dormiamo, con parole invece tutte e soltanto loro? – lingua però non immediata, che devo ogni volta riafferrare e controllare, da impropria rendere propria. Che non è mai intima. La impiego in quanto strumento».
Intanto il padre si è rifatto una vita con un’infermiera tedesca, che nel 1940 rientra in patria lasciandogli la figlia Irene. Moriranno insieme, il padre e la bambina, in quel dicembre 1941 in cui a Riga si fanno le prove generali della soluzione finale, prima ancora che sorgano i lager: i circa trentamila ebrei di Riga vengono rinchiusi in un ghetto, poi condotti nel bosco di Rumbula non lontano dalla città, dove sono fucilati in massa e sepolti in profonde fosse comuni, dopo che i loro corpi sono stati bruciati perché del massacro non rimanga traccia. Sovrintende all’eccidio la Wehrmacht, provvedono materialmente i nazisti lettoni, oggi in gran parte riabilitati in quanto ‘patrioti antisovietici’. E di questo silenzio più rancoroso che impacciato, di questa omertà che non arriva a essere negazionismo ma ci si avvicina, si colgono molte tracce nel ‘diario di viaggio’ di Marina Jarre.
La storia, le storie. Il padre perduto e rimosso, trasformato in fantasma (tutte le lettere e le fotografie smarrite o distrutte, quasi a non volere eco o memento di quell’infanzia prima incantata e poi infelice) è recuperato nel viaggio che l’autrice settantenne, accompagnata dal figlio Pietro che quel viaggio ha organizzato, compie. Assieme alla memoria dell’orrore, che si ha pudore a raccontare perché «la cosa non può essere narrata».
Ritorno in Lettonia è tante cose insieme: il diario di uno spaesamento, di un non essere da nessuna parte (in un suo intervento Marina Jarre si chiederà: «Quale patria per chi non ne ha nessuna o ne ha più d’una?»), la ricostruzione di uno sterminio ancora poco noto che è anche lutto privato e, insieme, della genealogia dei Gersoni (la sorte più che secolare di una famiglia, che riflette e incarna quella di un popolo).
Ha detto Marina Jarre in una bella intervista rilasciata ad Antonio Gnoli, a proposito dello scrivere: «Lo preferisco al parlare. Scrivendo restituisco i miei vari strati. I dolori, come le gioie. Le frastornate vicende accadute. È l’accumulo delle cose che mi interessa. La polvere che si toglie dalla vita. Scrivere è una forma di chiarezza. Di onestà con se stessi».
La chiarezza e l’onestà possono produrre il miracolo di un’epifania inattesa. «Vidi al margine di una macchia di alberi una lapide, mi parve, coperta di fiori. Non ebbi tempo per chiedermi che cosa fosse perché un attimo dopo, molto in alto, a destra, scorsi una scritta enorme, «Rumbula» – l’insegna della stazione –, e proprio nel medesimo momento, dall’altra parte della strada, una pietra nera con incisa, ben visibile, nell’angolo superiore a sinistra, la stella di Davide. Ecco i miei, mio padre, Irene, e Levin e Beile e Frume e Juddel e Abrahàm e Isacco, ecco i miei. Adesso, al contrario, ciò che diventava vero e presente, in quella stella di Davide che segnava il luogo dove lo avevano ucciso, non era la morte di mio padre, era la sua vita. Lo ritrovavo vivo. Scesa dalla macchina, mi fermai piangendo davanti alla pietra nera posta su un’altra pietra nera. Sopra questa, alcuni sassolini. Pietro stava in silenzio alle mie spalle. Non lessi la scritta, mi asciugavo gli occhi e pregavo. Così, pregando, chiesi perdono in tedesco, la nostra lingua, a mio padre, al mio Papi, per quello che gli avevano fatto e per essere uscita, quel mattino di dicembre, senza tornare indietro». (2017)
Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, traduzione di Anna Linda Callow e Rosella Carpinella Guarneri, Adelphi, 1997
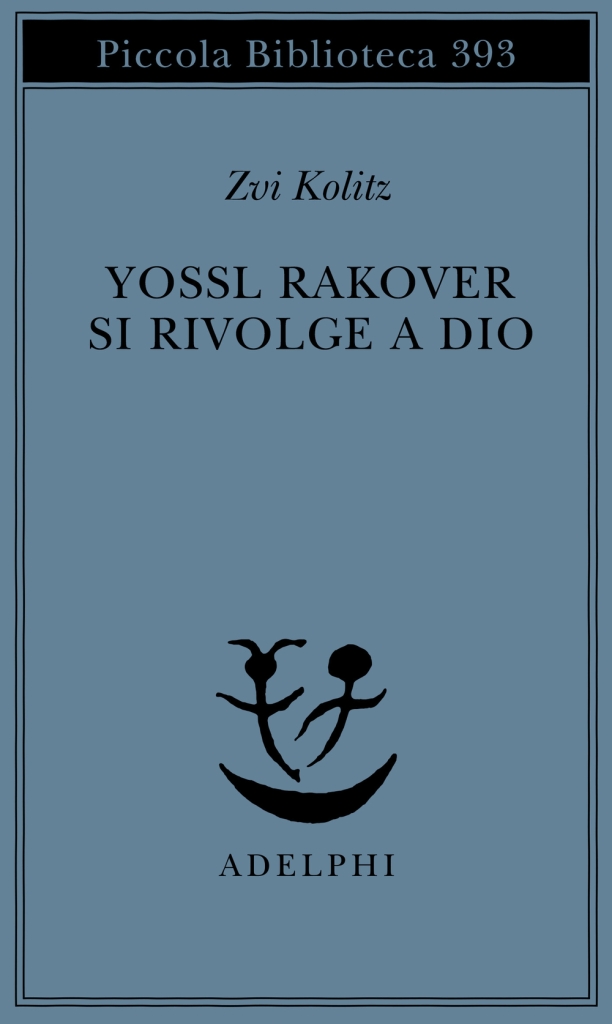
«Varsavia, 28 aprile 1943. Io, Yossl, figlio di Dovid Rakover di Tarnopol, discepolo del rebbe di Ger e discendente dei giusti, dotti e santi delle famiglie Rakover e Meisls, scrivo queste righe mentre le case del ghetto di Varsavia sono in fiamme, e quella dove mi trovo è una delle ultime che ancora non bruciano. Già da alcune ore siamo sottoposti a un cannoneggiamento di grande violenza, e il fuoco concentrico sbriciola e distrugge velocemente i muri intorno a me. Non durerà molto e anche la casa in cui mi trovo, come quasi tutte le altre del ghetto, sarà trasformata in una tomba per i suoi difensori e i suoi abitanti».
Yossl Rakover, combattente ebreo orgoglioso del suo popolo e creditore di Dio, proprio a Dio si rivolge, in un faccia a faccia teso e drammatico, poco prima di morire e di affidare a una bottiglia il suo messaggio estremo. Non come un ateo, non come un uomo in rivolta, ma come un uomo che ha deciso di credere nonostante tutto.
«Credo nel Dio d’Israele, anche se ha fatto di tutto perché non credessi in lui. Credo nelle sue leggi, anche se non posso giustificare i suoi atti. Il mio rapporto con lui non è più quello di uno schiavo verso il suo padrone, ma di un discepolo verso il suo maestro. Chino la testa dinanzi alla sua grandezza, ma non bacerò la verga con cui mi percuote. Io lo amo, ma amo di più la sua Legge, e continuerei a osservarla anche se perdessi la mia fiducia in lui».
A Dio, Yossl rivolge domande alte e terribili. «Tu dici che abbiamo peccato? Di certo è così. Che perciò veniamo puniti? Posso capire anche questo. Voglio però sapere da Te: esiste al mondo una colpa che meriti un castigo come quello che ci è stato inflitto?
Tu dici che ripagherai i nemici con la stessa moneta? Sono convinto che li ripagherai, e senza pietà, anche di questo non dubito. Voglio però sapere da Te: esiste al mondo una punizione che possa fare espiare il crimine commesso contro di noi?
Tu dici che ora non si tratta di colpa e punizione, ma che hai nascosto il Tuo volto, abbandonando gli uomini ai loro istinti? Ti voglio chiedere, Dio, e questa domanda brucia dentro di me come un fuoco divorante: che cosa ancora, sì, che cosa ancora deve accadere perché Tu mostri nuovamente il Tuo volto al mondo?
Ti voglio dire in modo chiaro e aperto che ora più che in qualsiasi tratto precedente del nostro infinito cammino di tormenti, noi torturati, disonorati, soffocati, noi sepolti vivi e bruciati vivi, noi oltraggiati, scherniti, derisi, noi massacrati a milioni, abbiamo il diritto di sapere: dove si trovano i confini della Tua pazienza?
E qualcosa ancora Ti voglio dire: non tendere troppo la corda, perché, non sia mai, potrebbe spezzarsi. La prova cui Tu ci hai sottoposti è così ardua, così insostenibilmente ardua, che Tu devi, Tu hai l’obbligo di perdonare quanti nel Tuo popolo si sono allontanati da Te nella loro disgrazia e nella loro indignazione.
(…)
Se non sei il mio Dio, di chi sei allora il Dio? Il Dio degli assassini?»
Scrisse questo testo sconvolgente, sotto forma di racconto-testamento di un estremo difensore del ghetto di Varsavia, l’ebreo lituano Zvi Kolitz (1912-2002), che era militante nel movimento della destra sionista di Vladimir Jabotinsky e, in Palestina, agente dell’Irgun di Menachem Begin che costellava di bombe contro gli inglesi il cammino degli ebrei verso la creazione di uno stato.
Lo scrisse in tre giorni per un giornale ebraico di Buenos Aires, dov’era per il congresso sionista mondiale. Il racconto di Kolitz sfuggì di mano all’autore, divenne testo anonimo come una ballata popolare, come un salmo o come una preghiera, circolando in yiddish e in ebraico, in francese e in tedesco e in inglese, in danese e in norvegese. E ogni volta che Kolitz cercava di ricordare che era opera sua, non veniva creduto.
Il merito di avere ristabilito la verità spetta al tedesco Paul Badde che ritrovò il testo originale e approntò l’edizione su cui anche Adelphi si basa (la storia più che avventurosa di Kolitz e del suo Yossl Rakover, in appendice, si legge come un racconto di Borges). La seconda appendice al libro è un saggio breve e denso del filosofo francese Emmanuel Lévinas, Amare la Torah più di Dio.
«Che cosa significa questa sofferenza degli innocenti? Non testimonia forse di un mondo senza Dio, di una terra dove l’uomo soltanto è la misura del Bene e del Male? La reazione più semplice, la più comune, sarebbe una scelta di ateismo. E sarebbe anche la più giusta per tutti coloro ai quali un dio un po’ elementare ha finora distribuito premi, inflitto sanzioni o perdonato errori e che, nella sua bontà, ha trattato gli uomini da eterni bambini. Ma che demone ottuso, che strano mago avete dunque insediato nel vostro cielo voi che, oggi, lo definite deserto? E perché sotto un cielo vuoto cercate ancora un mondo sensato e buono?
Che Dio c’è, Yossl figlio di Yossl lo prova con una forza nuova, sotto un cielo vuoto. Perché se lui esiste nella sua assoluta solitudine è per sentire sulle proprie spalle tutte le responsabilità di Dio». (2017)
Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, Feltrinelli, 2022

Da qualche tempo si affacciano in libreria romanzi scritti bene e documentati con scrupolo ma senza particolari assilli di stile, che hanno soprattutto l’urgenza di raccontare: un fatto, un personaggio, una storia, una famiglia. Erano così Il treno dei bambini di Viola Ardone, tutto sommato anche I leoni di Sicilia di Stefania Auci. Storie ‘vere’, a volte – è il caso di Titti Marrone – storie dolorose e necessarie. Qui è di scena il combattimento tra l’inferno e l’amore, non saprei dirlo altrimenti.
L’inferno è quello che hanno vissuto i bambini ebrei scomparsi nella Shoah, ma anche i sopravvissuti ad Auschwitz e Terezin, quelli nascosti in conventi e orfanotrofi, quando non in soffitte, scantinati e armadi. Di venticinque di loro, quattro anni il più piccolo e quindici il più grande, si prendono cura dal 1945 un gruppo di donne guidate dalla psicoterapeuta – e governante, e madre sostituta – Alice Goldberger. Li ospita la villa di sir Benjamin Drage, ebreo soccorrevole, a Lingfield nel Surrey, vigila su di loro la donna che ha voluto e avviato l’impresa, la grande Anna Freud figlia di Sigmund. Restituire l’infanzia a bambini che combattono ogni minuto con gli incubi, che diffidano dei grandi e in genere del mondo, che reagiscono con il mutismo e l’apatia oppure con scatti improvvisi di violenza. Che sono sgomenti di fronte a tanta generosità e sospettano la trappola. Che non mangiano ma rubano e nascondono il cibo come facevano nei lager.
Farli sentire a casa, dare loro il necessario, ma anche vestiti belli, giochi e musica e istruzione, vegliare sui loro sonni agitati, accarezzarli e non punirli mai senza rinunciare a guidarli, accogliere i loro silenzi e ascoltare i primi esitanti racconti senza forzare loro la mano. Farli crescere, rintracciare genitori e parenti superstiti o trovare loro una famiglia adottiva, avviarli alla vita e alla fatica – per loro più forte – di crescere. Non sempre c’è il lieto fine, e questa non è una fiaba, ma nell’asciutta commozione che guida la penna di Titti Marrone trova misura di verità anche qui quello che Giacomo Debenedetti definiva, sulla scorta di George Eliot, “il latte dell’umana bontà”.
«Erano passati sette mesi dall’arrivo del primo gruppo e Alice sentiva che era venuto il momento di fare di più. Oltre ad accogliere, sfamare, curare, trnquillizzare, oltre a insegnare l’inglese e a inserire i piccoli ospiti nelle scuole, c’era da cominciare l’altro lavoro, il più difficile. Toccava farlo insieme ai bambini, che dovevano essere aiutati a ricordare, penetrando nei loro segreti cullati dal silenzio. Con delicatezza, senza forzarne l’interiorità scorticata, senza mettere a nudo troppo bruscamente la carne viva di memorie tanto vulnerate. Lei sapeva bene che rammentare è come rammendare, cucire gli strappi, inclusi quelli interiori. Ripararli sapendo che i segni sarebbero restati comunque indelebili e visibili. Il recupero delle memorie di traumi estremi come quelli vissuti dai piccoli ospiti di Lingfield non era mai stato tentato prima. Non esistevano precedenti né teorie di supporto né strade già tracciate. Ed era facile immaginare che sarebbe stato devastante».
Rammendare il mondo, spendersi, esserci. Vale per tutti la scritta sulla stele all’ingresso del Giardino dei Giusti, nello Yad Vashem di Gerusalemme: «Chi salva una vita, salva il mondo intero». (2022)
Patrick Modiano, Dora Bruder, traduzione di Francesco Bruno, Guanda, 2004

Ha ragione Pietro Citati: «Questo libro nasce da uno scacco: si muove nel vuoto, si agita nel vuoto, attraversa il vuoto, interroga il vuoto, viene deluso dal vuoto; ma da questo scacco nasce la sua bellezza». Dora Bruder è un’adolescente scappata dal collegio negli anni cupi dell’occupazione nazista di Parigi, negli anni dell’infamia e delle stelle gialle, delle retate e delle deportazioni in massa. L’unica traccia del suo passaggio sulla terra, l’unica memoria di lei, è consegnata a un trafiletto del Paris Soir del 31 dicembre 1941: «Si cerca una ragazza di 15 anni, Dora Bruder, m 1,55, volto ovale, occhi castano-grigi, cappotto sportivo grigio, pullover bordeaux, gonna e cappello blu marina, scarpe sportive color marrone. Inviare eventuali informazioni ai coniugi Bruder, boulevard Ornano 41, Parigi».
Che fare, come dare consistenza a chi è passato veloce, senza lasciare ricordi, parole, testimonianze? Alla moltitudine marchiata a fuoco della ferocia della storia? Ai sommersi che non conobbero la salvezza, dei quali resta un nome, un numero, una data?
Si può immaginare, romanzare. Inventare il personaggio, infondergli vita. È lecito, spesso ha dato risultati splendidi. Patrick Modiano ha scelto un’altra strada. Si è aggrappato a quel trafiletto, ha interrogato le pietre e le carte, le vie che la videro bambina, la città da cui la famiglia Bruder si mosse per raggiungere la Francia (Vienna: i Bruder erano ebrei galiziani).
I documenti che la vergogna e la vigliaccheria dei piccoli lacché del terrore, dei complici dei nazisti, hanno risparmiato alla distruzione: il passato di legionario in Marocco e di invalido di guerra di Ernest Bruder padre di Dora. La povera vita in alberghi infimi, in camere ammobiliate, di questi ebrei viennesi che ebbero il sogno della Francia.
I lavori da sarta e da operaia della madre di Dora, ebrea ungherese. I registri scolastici del quartiere. I pochissimi ricordi di una parente superstite che ci restituisce una Dora ribelle e insofferente. Le scarse foto ingiallite e mute che raccontano la speranza impossibile della normalità.
E i documenti atroci, nella loro asciuttezza burocratica, del calvario di un popolo sotto l’occupazione: la registrazione presso la polizia (Dora, con un gesto di coraggio e di amore, non è denunciata come ebrea e viene nascosta in un tetro collegio di suore), le ricevute per la consegna delle stelle gialle.
Da quel collegio che dovrebbe sottrarla alle persecuzioni Dora scappa a più riprese, adolescente forse più spaurita e oppressa dal peso della solitudine che ribelle. L’atto estetico in apparenza freddo (fare parlare le pietre, le carte) è un atto etico e poetico: restituire l’aroma di un’assenza, dare l’odore cupo di palazzi e tuguri che non esistono più, spazzati dalle ruspe e sostituiti, con i loro ricordi di povere vite, da un «cemento color amnesia»; intuire nella facciata di una casa, nelle storie che la storia di Dora incrocia e delle quali resta qualche brandello di ricordo in più (la studentessa di medicina; la ragazza che amava un ariano ed era stata denunciata dalla famiglia di lui; la ladra che svaligiava appartamenti: tutte scomparse, tutte avviate ai campi) un pallido riflesso di lei, di come poteva essere stata.
Capirlo per similitudine attingendo a ricordi dolorosi dell’autore: il padre faccendiere – con cui sarà in conflitto per tutta la vita, lo racconterà nel bellissimo Pedigree – braccato in quegli anni, in quelle vie, come i personaggi di questa storia.
Ricordare ai distratti e ai pacificati che anche nelle pieghe di quelle carte bruciate, di quei palazzi sventrati si nasconde l’orrore, amplificato da queste rimozioni. Dora, la ragazzina che non porta la stella gialla, forse non poteva essere salvata comunque. Ripresa dopo l’ultima fuga, viene avviata a un campo di raccolta dal quale dovrà proseguire per un istituto correzionale. In quel campo di raccolta ritrova il padre, destinato ad Auschwitz. E sceglie di non salvarsi, di seguirlo. Resta questo di lei: un atto d’amore. Restano le strade di Parigi che da allora, per Modiano, sono «vuote per sempre».
Resta un segreto tenace, che ce la consegna più viva e palpitante di molte eroine da romanzo: «Ignorerò per sempre come passava le giornate, dove si nascondeva, in compagnia di chi si trovava durante l’inverno della sua prima fuga e nelle poche settimane di quella primavera in cui scappò di nuovo. È il suo segreto. Povero e prezioso segreto che i carnefici, le ordinanze, le autorità cosiddette d’occupazione, il Deposito, le caserme, i campi, la Storia, il tempo – tutto ciò che insozza e distrugge – non sono riusciti a rubarle». (2010)
Gaia Servadio, Un’infanzia diversa, Rizzoli, 1988
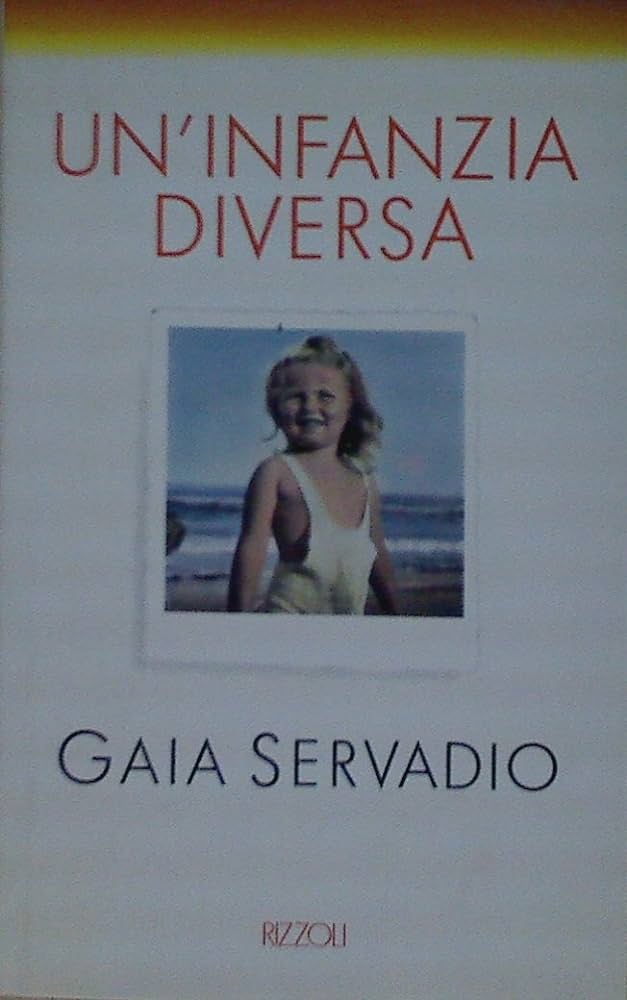
«Per strada, sotto i portici, con quello spirito di osservazione infantile solleticato soprattutto dall’orrido, mia sorella ed io c’eravamo incantate davanti a un manifesto. Raffigurava il torso di un uomo orribile dai denti insanguinati, i ricci unti. Gli occhi, iniettati di sangue, erano piccolissimi. Le unghie sporche, ad artiglio, si tendevano verso l’osservatore, le mani erano rapaci. Una specie di diavolo, un uomo orribile, schifoso, ci minacciava». Siamo nel 1943, a Padova. Il personaggio del manifesto è Süss l’ebreo, l’usuraio immortalato da una novella dello scrittore romantico Wilhelm Hauff, che la propaganda nazista ha trasformato nel simbolo della “perfidia giudaica”. E le due bambine che lo fissano affascinate e intimorite, Gaia Servadio e la sorella Pucci, sono figlie di un ebreo e di un’ariana. Ebree a tutti gli effetti per il fascismo, che nel 1938 ha emanato il Manifesto della razza. E ‘gentili’, estranee, per la comunità israelitica. Un’infanzia diversa, asciutta e drammatica autobiografia della giornalista e scrittrice Gaia Servadio, racconta questa doppia esclusione. E spiega come da un giorno all’altro una bambina della media borghesia, che fino a quel momento aveva percepito in maniera assai vaga la propria diversità, si trasformi in una fuggiasca cenciosa e affamata, costretta a nascondersi con la famiglia e testimone di grandi gesti di generosità (a Osimo, nelle Marche, i Servadio trovano rifugio presso la nobile famiglia dei Gallo) e di delazioni ripugnanti (la nonna paterna, che morirà ad Auschwitz, è denunciata ai tedeschi da una telefonata anonima). «Di quel periodo» ricorda Gaia Servadio «mi è rimasta per anni una terribile vergogna per il mio cognome. Quando alle medie o al liceo facevano l’appello mi prendeva il panico. Ma da quel periodo mi è venuto anche un attaccamento profondo alla cultura ebraica, al suo umanesimo. Quell’umanesimo che ha permesso a Primo Levi, grande amico di mio padre e chimico come lui, di sopravvivere al campo di concentramento». Dai ricordi di Gaia Servadio esce a brandelli il luogo comune, pieno di retorica e sentimentalismo spicciolo, di un’Italia generosa, col cuore in mano. «Non posso generalizzare, né posso dimenticare le testimonianze di solidarietà concreta che ho ricevuto. Ma le cifre raccontano un’altra storia, ben più cruda. Gli ebrei in Italia, prima delle leggi razziali, erano quasi 45mila. Furono deportati in 8500, dei quali sopravvissero meno di mille. A loro favore non ci furono dimostrazioni collettive, prese di posizione collettive, né in Italia né altrove. Neppure Pio XII mosse un dito: assistette immobile al rastrellamento del Ghetto, nella sua Roma». Dopo le persecuzioni, il gelo del dopoguerra: in giro c’è soltanto voglia di dimenticare, chi rompe il cerchio dell’omertà è segnato a dito. E loro, gli ebrei, sono i più sconfitti di tutti, non ascrivibili né ai vinti né ai vincitori. «Adesso eravamo diverse perché eravamo povere», conclude Gaia Servadio, «e perché non appartenevamo a quelle classi sociali che si erano fatte durante l’era fascista. Eravamo diverse anche perché tutti quegli anni di propaganda avevano insinuato questo sospetto, questa cognizione negli altri, e in noi stesse». Rimane soltanto un mucchietto di ceneri di Auschwitz, che il padre dell’autrice conserva religiosamente. «Era un simbolo ma, forse, in quella polvere c’era sua madre». (1988)
Piera Sonnino, Questo è stato, il Saggiatore, 2004

Luglio 1960: mentre Genova insorge contro il governo Tambroni, che ha consentito la celebrazione del congresso del Msi nella città medaglia d’oro della Resistenza, una giovane donna scrive le sue memorie. Al congresso fascista c’è anche l’uomo che nel 1944 l’ha fatta arrestare e deportare. «Mi chiamo Piera Sonnino, sono nata trentotto anni orsono a Portici, nei pressi di Napoli, quarta dei sei figli avuti da mia madre, Giorgina Milani, e da mio padre Ettore. Il loro matrimonio, celebrato con rito ebraico a Roma nel 1910, era stato fastoso, come si addiceva alle condizioni sociali di entrambe le famiglie, e la cerimonia si era conclusa con un concerto al quale aveva partecipato una soprano allora assai nota». Maggio 2002: al settimanale Diario, che ha promosso il progetto “Memoria lunga”, arriva il dattiloscritto La notte di Auschwitz. Sono le memorie di Piera Sonnino, morta nel 1999. Per quarantadue anni sono state custodite dalla famiglia, le spediscono al giornale le figlie di Piera. Il primo lettore, Giacomo Papi, trova il dattiloscritto ‘eccezionale’ e ha ragione. Il settimanale lo pubblica suscitando commozione e consensi e due anni dopo arriva il libro. Questo libro.
Che cos’hanno di eccezionale le memorie di Piera Sonnino? Tante cose. Il pudore, la mancanza di risentimenti, il quadro vivido e amorevole di una famiglia sfortunata ma solidale. E poi l’acume che le permette di antivedere la futura persecuzione quando nota, a metà degli anni ‘30, l’arrivo dei primi esuli ebrei dalla Germania hitlerizzata. La forza poetica con cui descrive l’orrore: penso alle pagine memorabili sul fango di Auschwitz, materia quasi animata e somma di decomposizioni. E l’esattezza con cui ricostruisce l’anno di clandestinità della famiglia, prima della fatale e inevitabile cattura. Inevitabile perché i Sonnino, oltre che ebrei, sono poveri. Ettore, il padre, è commerciante e rappresentante con alterne fortune. I figli e le figlie lavorano perché quel che porta casa Ettore non basta. Da Napoli e Roma vanno a Milano e, infine, si trasferiscono a Genova.
Non hanno vita sociale né amicizie, non vedono né frequentano gente: come molti poveri, bastano a se stessi e si isolano. Vivono la povertà con decoro, cercano di passare inosservati, le ragazze non portano mai compagne a casa perché «c’è ancora da sistemare».
Non illuda l’incipit di Piera sulle nozze fastose come si addiceva alla condizione delle famiglie: è esatto ma ricorda un eden prima della caduta, sempre rievocato in famiglia e mai vissuto. Questo benessere, la povertà successiva e l’incubo della clandestinità si fanno, nel racconto, metafora della breve e fragile integrazione degli ebrei italiani: «Rivedo mia madre, mio padre, i miei fratelli, le mie sorelle, io stessa, attingere in noi, dalla nostra unione, l’estremo calore umano che ci è consentito. Ricordo i frammenti uditi dalla storia delle famiglie da cui la mia è nata. L’oscuro destino entro cui si sono sempre dibattute. Da appena due generazioni i Sonnino e i Milani hanno potuto essere liberati dall’umiliazione del ghetto di Roma entro cui i padri dei padri erano nati e cresciuti. Le mura del ghetto caddero nel 1870 e da quell’anno i miei avi furono liberi. Ma portavano in sé il ricordo di ciò che avevano subito, delle notti d’angoscia in cui gruppi di fanatici penetravano nel ghetto per rapire i loro figli e consacrarli col battesimo a un’altra religione, delle sofferenze della segregazione, dell’abiezione verso cui erano sospinti. La nonna materna di mamma si chiamava Rosselli e un giorno di tanti anni prima io avevo udito bisbigliare che Carlo e Nello erano stati uccisi dai fascisti, ma non sapevo chi fossero, né che facessero. Al nome di Crescenzio Del Monte, poeta che scrisse in giudaico romanesco, cugino di primo grado di mamma, è intitolata una via di Roma, a Trastevere, dove le lapidi ricordano Belli e Trilussa. Zia Ersilia, una sorella del nonno materno, aveva sposato un Modigliani, parente del pittore e lo zio Ettore Modigliani aveva per moglie Nelly Nathan, nipote del sindaco di Roma, che fino al 1938 era stato direttore della Pinacoteca di Brera. Due famiglie che avevano duramente lottato per conquistarsi la vita ed erano riuscite a vincere le prevenzioni razziali di certi ambienti della borghesia romana e napoletana e a farsi rispettare. Soltanto due generazioni libere tra il ghetto di Roma e la notte di Auschwitz. Una breve parentesi. L’ondata è tornata a rinchiudersi su di noi».
Non hanno quasi nessuno i Sonnino quando, dopo il 25 settembre 1943, scappano. Li salvano soltanto i generosi aiuti che giungono dai datori di lavoro dei figli o dai colleghi, che di volta in volta individuano per loro una casa abbandonata, un albergo fuori mano, una cascina. Un anno di odissea, a girare in tondo attorno al luogo di partenza: l’entroterra chiavarese, la Val Trebbia. «Se il dramma degli ebrei italiani anche dopo l’8 settembre 1943 non attinse le proporzioni tragiche altrove subite dai nostri correligionari, ciò fu dovuto alla meravigliosa e umana coscienza del nostro popolo. E io ritengo che proprio la mia testimonianza possa essere più preziosa di altre perché nel corso dell’anno che vivemmo alla macchia, assillati e tormentati dall’incubo, sempre più vicini alla nostra tremenda fine, ho potuto conoscere e valutare il significato di ciò che vado dicendo. Ricordo un povero contadino di Sampierdicanne, nei pressi di Chiavari, dove ci eravamo rifugiati, ripetere che l’umanità non si divide in ebrei e non ebrei, ma in ricchi e poveri, tra chi possiede tutto e chi non possiede nulla, tra chi lavora la terra e non ne gode i frutti e chi non la lavora e si appropria della mietitura e della vendemmia. Queste parole di antica saggezza mi sono rimaste nel cuore e sono certa che esse racchiudono l’estrema verità dei popoli. Io, ebrea italiana, ne ho sperimentato il valore quando per me la mia sola esistenza rappresentava un reato da punire con la morte».
Italiani brava gente? Non sempre, non tutti. Isolati e braccati, talmente isolati e desiderosi di rendersi invisibili da non sapere neppure che dove si rifugiano sono già attive le bande partigiane, i Sonnino tornano a Genova. E lì, alla fine del 1944, vengono presi. Li catturano due poliziotti infami: c’è stato un inferno per loro, ci sarà? «Il poliziotto si stringe nelle spalle. Hanno avuto l’ordine di arrestare tutti i membri della famiglia. Una famiglia di ebrei, sottolinea con un risolino a fior di labbra. E prosegue subito che lui non capisce tanto dramma. Parla con un accento meridionale che deforma le parole. Un altro poliziotto lo interrompe e interloquisce come parlasse tra sé e sé: “Ebrei… veramente ebrei. Hanno inchiodato Nostro Signore Gesù Cristo, gli ebrei”. Si rivolge a noi, anch’egli con un risolino a fior di labbra. “In che guaio vi siete messi da allora. In che guaio. E chi può darvi retta dopo quello che avete fatto?” Il primo riprende a dire che le lacrime e il pianto sono sprecati».
La cattura, il calvario. Auschwitz, Bergen Belsen, Braunschweig. I genitori eliminati subito, poco dopo i fratelli. La sorella Maria Luisa trasferita in un altro lager, Bice che muore stremata dalla dissenteria in una branda: il suo corpo viene lasciato davanti alla baracca per quattro giorni, finché la neve non lo ricopre. L’orrore e i rari preziosi gesti di umanità (la vecchia tedesca che sbuca da una casa con un termos di tè caldo e un po’ di pane nero), fino alla salvezza a cui Piera non riesce a credere. È scampata lei sola, di otto che sono partiti. Il lungo recupero: cinque anni in ospedali, sanatori, colonie elioterapiche. Il ritorno a Genova, il matrimonio con un giornalista comunista, Antonio Gaetano Parodi, la nascita di due figlie. Alle quali dirà, quando fanno baccano: «Cerchiamo di non farci riconoscere». Bella prefazione di Enrico Deaglio, bel saggio finale di Giacomo Papi, che ha ripercorso l’itinerario della loro fuga. (2011)
Filippo Tuena, Le variazioni Reinach, Beat, 2015

Il pensiero va subito a Dora Bruder, struggente capolavoro di Patrick Modiano. Lì era di scena una quindicenne ebrea negli anni dell’orrore nazista e della vergogna francese, in fuga dalla famiglia e destinata ad Auschwitz. Era di scena il tentativo di dare corpo ai fantasmi.
Gli spettri popolano anche questo più recente romanzo, Le variazioni Reinach di Filippo Tuena, vincitore del Premio Bagutta nel 2005 e riproposto in una nuova edizione che toglie (poco), aggiusta e lima la prima.
Qui sono di scena due famiglie dell’aristocrazia ebraica francese. I Reinach, di origine tedesca (Francoforte), figli dell’haskalah, l’illuminismo ebraico. E quindi razionalisti, irreligiosi o al massimo teisti: nella villa greca Kérylos fatta costruire nel 1900 dal filologo e archeologo Theodore, membro del Collège de France e curatore dell’opera di Flavio Giuseppe, a Beaulieu vicino a Nizza, c’è un altare “al dio ignoto”. Banchieri ma anche intellettuali, coinvolti nella vita pubblica: Joseph fratello di Theodore è parlamentare socialista, difensore pubblico del capitano Dreyfus del quale sposa la figlia, segretario del primo ministro Leon Gambetta. Collezionisti munifici: biblioteche, quadrerie, interi palazzi eretti a musei vengono donati allo stato. E i Camondo, sefarditi di origine costantinopolitana, anch’essi banchieri, resi nobili dal nostro Vittorio Emanuele II nel 1867 per avere finanziato la terza guerra d’indipendenza.
Tuena segue soprattutto i discendenti, frivoli e rentier a un primo sguardo, stoiche vittime dell’annientamento nazista alla distanza. Leon Reinach, compositore di musica (di lui resta una sonata in re minore per violino e piano, rintracciata proprio da Tuena e negli ultimi anni incisa da più di un interprete), uomo ai margini del ritratto, adulto solitario e appartato, quasi un Mattia Pascal che si esercita a scomparire in vita.
E sua moglie Beatrice de Camondo. La bambina cresciuta senza madre (la bella e sventata Irene Cahen d’Anvers ritratta da Renoir ha lasciato il marito e si è fatta cattolica per convolare a nuove nozze con lo spiantato conte Serpieri, palafreniere e avventuriero) accanto a un padre murato nella solitudine e intento a cancellare ogni traccia del passato. La ragazzina grassoccia che Boldini ritrae di malavoglia, l’amazzone mascolina che eccelle nel dressage.
E infine la donna di mezza età imbruttita e sorda che si converte anch’essa al cattolicesimo ma, in uno slancio tanto irrealistico quanto commovente, continua a ingaggiare guerre burocratiche con gli occupanti (il suo conto corrente è stato congelato dai nazisti e da Vichy) per pagare le pensioni alla madre vecchia e spiantata e agli ex domestici della famiglia, perché è preoccupata più del loro sostentamento che di se stessa.
Con Leon e Beatrice i figli Fanny e Bertrand, la graziosa e vivace amazzone che trionfa ai concorsi ed è forse innamorata di un Rothschild e il ragazzone che non va bene a scuola e ripiega sul mestiere di ebanista e restauratore.
Il bel mondo francese prossimo all’arte e alla cultura: Proust è loro amico, come lo sono Fauré, Degas e la principessa Bibesco. L’eletta schiera che si imparenta con i Rothschild e con gli Ephrussi. Che, più ingenua e indifesa che arrogante, si ritiene integrata ed esente dalle persecuzioni: non tanto perché è ricca, quanto perché ha illustrato la Francia con la munificenza delle donazioni, con il rigore degli studi, con i contributi alla scienza, con il sangue versato per la patria.
Non servirà a niente: spogliati di tutto, internati dapprima a Drancy («Bisogna provare tutto, essere i primi e gli ultimi» scrive Leon in una cartolina al cugino Fabrice), dopo un tentativo di fuga tardivo e goffo finiranno ad Auschwitz. Nulla si saprà della loro fine, anche le date di morte resteranno a lungo contraddittorie.
Tuena, come Modiano, interroga carte e segni. Più di Modiano, mischia ricerca e rêverie, ascolta le voci del passato che crede di avvertire ancora nei luoghi dove i Reinach e i Camondo sono passati, nella convinzione che raccontare una storia sia rispecchiarsi in un destino.
Costruito per variazioni come nei brani che abbiamo amato, ognuno scelga il suo, le variazioni Goldberg di Bach, quelle di Beethoven su un valzer di Diabelli o quelle di Mozart su un tema di Haydn, questo splendido e nobile romanzo ha anch’esso un tema duplice: la scrittura e la memoria. La lotta tra la memoria e l’oblio: è strano come si finisca per sapere poco, per perdere le tracce di chi è stato inghiottito dalla storia, come se settant’anni fossero sette secoli.
La fatica e il dovere di raccontare: perché nessuno scrittore è un vero scrittore se non guarda il Male negli occhi, e perché bisogna che il lettore sappia di quali esili fili è intessuta una storia. Non una storia rotonda e d’invenzione, ma una storia congetturale dove occorre fare parlare una branda infestata dalle cimici, il frustino di un kapò o una foto in bianco e nero dove un bambino con le gambe lunghe siede sull’altalena, dove si può intuire una carezza o un silenzio, una complicità o una fuga.
Una storia che è anche storia di chi scrive e di chi legge: un rispecchiarsi nel pozzo buio dell’antisemitismo e del nazismo, che inghiotte anche il nostro volto. Un rispecchiarsi nell’erranza e nello sradicamento che sono la nostra condizione umana.
Non c’è autofiction, nel romanzo di Filippo Tuena. Lo scrittore che parla di sé in terza persona non è il narciso postmodern che a ondate alterne ci diverte o ci irrita, ma un virgilio che ci guida nell’inferno appena trascorso e mai del tutto sopito; chi crede che niente ritorni, che le chiassate dei populismi e delle xenofobie non significhino niente, faccia attenzione. (2015)