C’è , nelle proposte di questo mese, da giocare tra non sense e limericks, ci sono atmosfere gialle e nere e sapori amari, molta Inghilterra e i ricordi di un grande europeo come Stefan Zweig
Qualche novità, alcuni libri di ieri. Questo mese ho frequentato molti “gialli”. Anche molta autofiction, ne parlerò il mese prossimo; per lavoro molti libri sulla Fiat, sull’Europa e sulle regioni e, salvo alcuni, non mette in conto di parlarne. Nelle riletture, ho privilegiato la poesia nonsense e la narrativa non-fiction. E l’amato Stefan Zweig, del quale mi sono proposto di leggere o rileggere ogni mese un’opera.
Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Scheiwiller, 2002, e Morcelliana, 2018
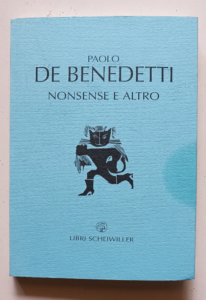
La produzione giovanile e scherzosa di Paolo De Benedetti, 1927-2016, dirigente editoriale – ricordo di averlo conosciuto alla Garzanti, me lo presentò Anna Drugman –, caporedattore del monumentale Dizionario Bompiani degli autori e delle opere, biblista insigne (La morte di Mosè e molto altro), tessitore del dialogo fra ebraismo e cristianesimo. E, fra gli anni ‘50 e i primi ‘70, pioniere del nonsense nelle vesti di autore e teorico. Passatempi di redazione i suoi, bigliettini tra intellettuali, giochi di professori: se ricordo bene, De Benedetti fu uno dei leggendari quattro Wutki del mensile Linus (gli altri tre erano Sergio Morando, Giovanni Gandini e Giampaolo Dossena). La deliziosa antologia parte con una vivace disamina dei limericks e del suo massimo esponente, Edward Lear, con una maratona composta assieme al futuro editore Mario Spagnol (un Viaggio in limerick sul Reno e dintorni in 23 strofe, 1957) e con sparsi pregevoli esempi:
C’era un vecchio di Lambrugo
che mangiava pane e sugo
quando n’ebbe pien lo stomaco
si pentì e si fece monaco
quell’ascetico vecchio di Lambrugo.
Prosegue con gattilene, micceidi e altre poesie sugli animali, di incantevole grazia e lieve profondità, compresa una sezione di “qinot”, lamentazioni, sulla morte dei suoi gatti – De Benedetti ha pubblicato, nel 2007, una serissima Teologia degli animali:
Il gatto giallo
canta da gallo
sorge nel cielo
con tutto il pelo:
oh che fortuna
un gatto luna!
Il gatto celeste
ha l’arie modeste
ma in cuor l’ambizione
di gatto mammone.
Il gatto bigio
è tanto ligio
se ruba il lesso
chiede il permesso.
Il gatto platonico
non è malinconico
perché sa che in cielo
c’è un gatto di pelo.
La grande scoperta, per me che non le conoscevo, sono state le “incarrighiane”. Indietro adagio. Ferdinando Incarriga, leale funzionario borbonico, fu tra il 1821 e il 1834 giudice in varie corti criminali di provincia. Sarebbe arrivato a Napoli se per sventura non si fosse coperto di ridicolo stampando un libro di cento anacreontiche “composto a solo uso de’ giovanetti” in cui, con troncamenti assurdi e uno spirito classificatorio talmente pedante da scivolare nel comico involontario, spiegava l’umano scibile. Come l’astronomia:
Stronomia è scienza amena
Che l’uom porta a misurare
Stelle, Sol, e ‘l glob’ Lunare,
E a veder che vi è là su.
Invano i parenti dell’Incarriga acquistavano le copie in circolazione per evitargli la baia dei lettori: le sue quartine si diffusero abbastanza da attirarsi le parodie, come questa di Michele Testa:
La poesia è quella cosa
Ch’è diversa dalla prosa:
È perciò che prosa e vers’
Sono generi divers’.
L’incarrighiana divenne moda, in tutto l’Ottocento. Nel Novecento le resero omaggio i futuristi di Lacerba con i loro “versi maltusiani” (il troncamento delle parole alla fine delle quartine veniva associato al coitus interruptus, metodo “maltusiano” prevenire le nascite). Nel loro Almanacco purgativo (1914) si può leggere:
Moralista è quella cosa
che del fico vuol la foglia
ma se poi gli vien la voglia
vuole il frutto al femminil.
Oppure, reazionaria ma oggi piacerebbe a molti:
Parlamento è quella cosa
che ci vanno tutti quanti.
I più bischeri e birbanti
vanno pure al minister.
Amico dei futuristi, anche il grande Ettore Petrolini si cimentò con l’incarrighiana:
Petrolini è quella cosa
che ti burla in ton garbato,
poi ti dice: ti à piaciato?
Se ti offendi se ne freg.
È la moglie quella cosa
che per lusso e per vestito
spende il doppio del marito
e si chiama la metà.
In tempi non lontani, sulla rivista online Golem scrisse qualche incarrighiana Umberto Eco:
Berlusconi è quella cosa
che ci dà tv ogni sera
poi per non patir galera
organizza Forzital.
Torniamo a Paolo De Benedetti. Con lui l’incarrighiana trasmigra: da nonsense malgré soi diventa nonsense compiuto per lunare, ironica soavità:
Il formaggio è quella cosa
che si fa col latte vecchio
lo si mette dentro un secchio
e si lascia stare lì.
È la mummia quell’arnese
che veniva imbalsamato
per restare conservato
dentro a grandi piramìd.
Il castello è quel palazzo
messo in cima a una collina
quando poi cade in rovina
è castello ancor di più.
Il vertice del De Benedetti teorico è lo splendido e nonsensicamente erudito (l’autore cita la Bibbia, l’Edda di Snorri, il sanscrito, Pascoli, Oliver Goldsmith, Sholem An-Ski ecc) La letteratura nonsensica, pubblicato originariamente nell’Almanacco Bompiani del 1966. Dopo una minuziosa suddivisione fra le innumeri specie nonsensiche, condotta con la pignoleria di un Linneo delle filastrocche, arriva perentoria e laconica la “definizione definitiva”: «Poesia insensata nell’anima, di autore sensato, e antiepigrammatica».
Cosimo Filigheddu, L’odore della città, Il Maestrale, 2024

Un thriller che si fa apologo, una commedia nera che diventa radiografia impietosa di una collettività. Potete assaporarlo pagina dopo pagina o immergervi come ho fatto io, in una serata di questa primavera piovosa, senza riuscire a staccarmi.
Siamo in Sardegna ma scordatevi pastori e selve, l’arcaismo confortante del folklore con le sue vendette e i suoi banditi. Lo scenario è urbano e duro, la storia è accaduta qui ma gran parte dell’Italia potrebbe ospitarla. Una città di provincia, nella quale per me è facile riconoscere, non senza qualche soprassalto, la Sassari che ricordo effervescente nella mia gioventù, qui stretta nella morsa della canicola e illividita. Al punto da riuscire a immaginarmi la scena del delitto, il palazzo nobiliare del fattaccio e, sotto, il bar del centro con i tavolini all’aperto e le comitive dei nottambuli chiassosi.
Un commerciante che dissipa gli averi di famiglia in un negozio di vestiti destinato al fallimento, tra una normalità apparente e una doppia vita che tutti sospettano, si porta a casa un foresto, cerca di sedurlo e lo sopprime. Poi chiama a soccorrerlo il gruppetto degli amici ai quali è legato da un patto (un pactum sceleris, si scoprirà nella fine che non si racconta, come non è lecito raccontare l’esito dell’impresa) che li fa complici fin dalla giovinezza.
Accorre dunque, a dargli manforte e ad aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere che si decompone rapidamente, al punto che l’intera città pare ammorbata da quel fetore, un campionario esemplare di antieroi di provincia. Borghesi immorali, li definisce il risvolto, ma i quattro amici sono qualcosa di più. Uomini senza qualità, inetti senza bonomia, oblomov dalle tenui fortune, arrampicatori con nessuno scrupolo o incapaci parcheggiati nelle loro professioni come un’auto scassata in un viottolo di campagna. Il medico pigro che non sa fare neppure un’iniezione, il giudice al quale non affidano cause per paura che combini disastri, il deputato corrotto e miracolato dalla politica sono guidati con mano ferrea dal capo della combriccola, un bancario infedele e abile a muovere un denaro illecito che, a differenza del cadavere, è sempre più inodore.
Tra il tenace poliziotto Davide (ma sono notevoli anche la questora e la capa della mobile), un procuratore moralista che non sopporta più la città, una bella veneziana che governa con polso saldo il bar del centro, i politici di felpato malaffare, le donne imbronciate e/o sguaiate, cresce nelle pagine governate da un plot saldissimo l’immagine di una città che non ha più un’economia ma soltanto traffici, che muore assieme ai suoi borghesi piccoli piccoli. La commedia nera si accompagna a un asciutto scoramento, il cadavere pronto a essere fatto a pezzi è una città che non ne esce intera. E anche l’ultima rivolta, con i cittadini che scendono in piazza a sventolare un rancoroso orgoglio municipale, lascia l’amaro in bocca. Come diceva il sottotitolo di un giallo assai famoso di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani: e poi non rimase più nessuno.
Francesco Guccini/ Loriano Macchiavelli, Vola golondrina, Giunti, 2023
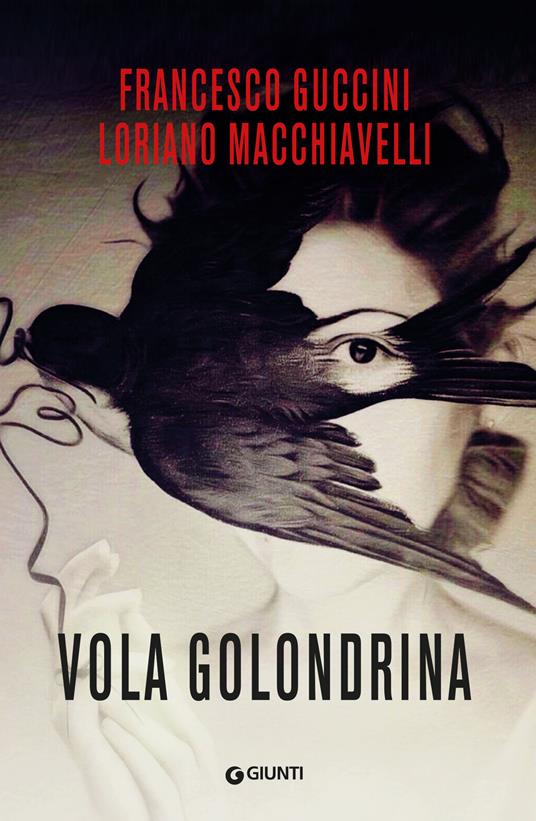
Hanno ucciso il camerata Ardito Richeldi, candidato del Movimento Sociale-Destra Nazionale alle elezioni del 1972, sparandogli al petto con una vecchia pistola spagnola a Montefosco, immaginario paese dell’Appennino tosco-emilano. Il morto non era una bella persona: squadrista durante il regime, volontario in Spagna contro la repubblica, seduttore di donne e padre di un figlio non cercato e non riconosciuto, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria per eversione a cui aveva cercato di sottrarsi facendo i nomi dei complici. Sulla sua morte indaga la giovane giornalista Penelope Rocchi detta Lope, che viene da Bologna e da Montefosco è andata via per recidere ogni legame con il passato. Il delitto del 1972 ne porta in pancia altri due: la morte di uno sconosciuto che, nei giorni delle elezioni del 18 aprile 1948, aveva svegliato il paese con le sue scorribande notturne a bordo di una moto con il sidecar, ed era stato trovato ucciso in un fienile. E la morte di una giovane donna, Ignacia Esteban che i compagni chiamavano Golondrina, combattente repubblicana che, catturata da Richeldi e dai suoi, si era gettata da una finestra per evitare lo stupro. Una lunga ballata sulla tenace amicizia, cementata nella guerra di Spagna, che in gioventù legò il comunista Pietro Nanni “Pedro” e l’anarchico Rivo Bassi detto Bakunin e Gambetta. Sarà l’anarchico, tornato dopo la Spagna a Montefosco a fare il meccanico, ad aiutare Lope a sbrogliare l’intricata matassa, che cela una vendetta privata. Tutto bene e tutto in qualche modo già saputo. Si è riconfortati nella convinzione che il fascismo sia pessima cosa e ci si commuove nell’omaggio all’Orwell di Omaggio alla Catalogna. Ma Guccini e Macchiavelli, sempre siano lodati, hanno scritto di meglio.
Edward Lear, Limericks, trad. Ottavio Fatica, Theoria, 1994, e Einaudi, 2002

Magari partiamo dalla definizione, così via il dente via il dolore. Dunque, “limericks”, strofette anapestiche di cinque versi rimati secondo lo schema aabba. In pratica così:
There was an Old Person whose habits
Induced him to feed upon rabbits;
When he’d eaten eighteen
He turned perfectly green,
Upon which he relinquished those habits.
O, se preferite la versione italiana, così:
C’è un tizio che, ahilui, gozzoviglia,
per vezzo o per vizio a conigli;
Se ne pappa diciotto:
Si fa verde di botto,
E a conigli mai più gozzoviglia.
“Limericks” perché tutti li dicono nati nella città omonima d’Irlanda. Dove all’inizio, nel Sei-Settecento (per dettagli anche minuziosi vedere Nonsense e altro di Paolo De Benedetti), erano strofette salaci, tra il volgarotto e l’osceno, cantate ai matrimoni e alle riunioni conviviali. Con il verso finale obbligato: “Will you come to Limerick?”. Un po’ come le nostre strofette da osteria.
Nell’Ottocento i “limericks” cambiano sede e statuto. Vanno ad abitare nella cameretta dei bambini, vestendosi d’insensato o di assurdo. Pronubo di questa inversione è Edward Lear (Londra 1812 – Sanremo 1888), che non inventa il genere ma lo porta a perfezione e a uno straordinario successo di pubblico.
Notevole esemplare di “eminente vittoriano”, il nostro Lear: acquarellista delicato, illustratore di testi botanici e zoologici, vignettista (i limericks che fanno la sua fortuna sono accompagnati da disegni caricaturali irresistibili che rendono reali e domestiche le fantasie dell’autore), maestro di disegno della regina Vittoria. E uomo al fondo quietamente triste e votato alla solitudine: sposo mancato, epilettico, asmatico, un’infanzia che neanche Dickens (venti fratelli, padre incarcerato per debiti), autore di arie malinconiche che suona piangendo al pianoforte, pittore di quadri a olio assai pompier e contesi dagli aristocratici, esploratore dell’esotismo mediterraneo (conobbe abbastanza a fondo l’Italia e la raccontò in alcuni notevoli libri di viaggio: in Abruzzo, Basilicata, Calabria), forse omosessuale timido e platonico.
Un innocente con l’inconscio non del tutto innocente. Come il reverendo Charles Dodgson in arte Lewis Carroll. Ma nell’era vittoriana che velava anche le gambe dei tavoli, chiusi ormai i conti con il romanzo gotico e con i furori byroniani, l’inquietante e l’abnorme potevano essere esorcizzati soltanto facendoli diventare “genere” più o meno di intrattenimento (i racconti di fantasmi), o consegnandoli, come detrito sterilizzato di antichi incubi, come straccetti ben lavati di vecchi abiti insanguinati, ai bambini, perché si baloccassero con la paura diventata stupore – che non impietrisce – e con l’eccentricità. Non più il mostruoso, ma il bislacco.
Vengono così confinate nella stanza dei bambini le visioni che urtano il realistico senso comune della borghesia trionfante (sarà questa, a lungo, la sorte dei Viaggi di Gulliver), perché le utopie e le satire diventino fiabe e i babau si trasformino in omini di pezza, lunghi lunghi oppure perfettamente sferici come Humpty Dumpty o con nasi ventri barbe orecchie sterminati. Soltanto così potranno essere presi a martellate, messi nel forno, affogati, punti da sciami di api, mutilati, destando il sorriso invece che il raccapriccio. Come accade in molte strofette di Lear, scritte in origine per svagare i nipotini del conte di Derby.
In fondo la civilizzazione consiste in questo: nel passare dal crudo al cotto. Nel trasformare una bestia uccisa in una crocchetta. Le deliziose crocchette di Lear ogni tanto (ma solo ogni tanto) fanno pensare all’animale morto. Diciamolo meglio: lasciano libere fantasie che nel ‘900 diventeranno incubi a occhi aperti. Per fare qualche esempio, il signore che gozzoviglia a conigli è illustrato con un coniglio che pare uscirgli di bocca. E con sei conigli che saltellano e zampettano tutt’intorno. Eruttati, più che ingeriti. A me fanno venire in mente il racconto di Julio Cortázar in cui un uomo vomita coniglietti rosa, ma sarà un caso. Proviamo con un altro limerick.
C’era un certo signore di Skye,
Di danzar non stancavasi mai:
Ronzò con un moscone,
Della luna all’alone,
Ammaliando la gente di Skye.
È un limerick mite e benignamente lunatico, ma l’illustrazione (l’uomo e il moscone grandi uguali, gli occhiali che somigliano agli occhi sporgenti dell’insetto, le code della giacca come ali di mosca) annuncia, sotto sotto, metamorfosi future più manifeste e meno ilari: Gregor Samsa che si sveglia scarafaggio, per dirne una. Come altri limericks rimandano a metamorfosi antiche, fiabesche: il principe rospo.
Ma se queste sono le punte estreme, gli affioramenti di archetipi che hanno dimenticato il senso originario, più in generale l’eccentricità che fascia i vecchietti e le vecchiette leariani (“There was an old person”, “There was an old man” sono gli incipit più comuni) hanno a che fare con il darsi un contegno o con l’essere privi di contegno. Con il mascherare i propri sentimenti o con l’esternarli (e perciò essere eccessivi, stravaganti, infantili). A me viene in mente Dickens. Avete presente il benefattore di Casa desolata? Ogni volta che l’orfanella accolta nella sua casa sta per ringraziarlo, si cava d’impiccio (d’impaccio) correndo a chiudere le finestre perché c’è vento o sta arrivando il temporale.
Una logica simile governa i vecchietti di Lear: burberi che fanno i balenghi per evitare mollezze sentimentali. O, quando non burberi, espansivi o esuberanti. E quindi infantili e sotto sotto un po’ riprovevoli: come il signor Dick del Copperfield, goloso di pan di zenzero e incapace di gestirsi. Tanto più infantili in quanto old persons, old men (e women):
C’era un certo signore del Cile,
Dal contegno penoso e futìle;
Sulle scale a sedere
E a mangiar mele e pere,
Che imprudenza, il signore del Cile.
Nel teatrino di Lear le signore sono arcigne il più delle volte, svanite più d’una volta, fuori misura sempre.
Un’anziana madama di Pisa
Alle figlie era sempre più invisa;
Con la veste più frusta
Le metteva alla frusta
Tutt’intorno ai bastioni di Pisa.
C’è la sensazione che, in una società quieta ma ferreamente normativa come quella vittoriana, l’eccentricità fosse la scorciatoia più breve per simulare un carattere, un’individualità. Meno pericolosa e meno inquietante della ribellione. Ma poi, siccome la logica non spiega mai tutto, e meno che mai nel nonsense, c’è soprattutto il senso ludico (quello che si è alla fine imposto, quello che i lettori hanno fatto loro) del mondo come ilare teatro d’incidenti. Dove tutti partecipano di “una catastrofe del cosiddetto razionale”, di una “quarta dimensione della letteratura”.
E allora, dopo aver cercato di indovinare gli ingredienti, proviamo ad assaggiare la pietanza. L’appetito è intatto, la tavola invitante.
Signorine stravaganti, uomini distratti o smodati, incidenti come nei film delle torte in faccia. O cruenti come nei cartoon di Wil Coyote che precipita da un canyon o si appiattisce dietro una porta sbattuta. In fondo persiste, smorzata, l’eco di un’antica minaccia. Lo sappiamo, ma questo non ci guasterà la festa.
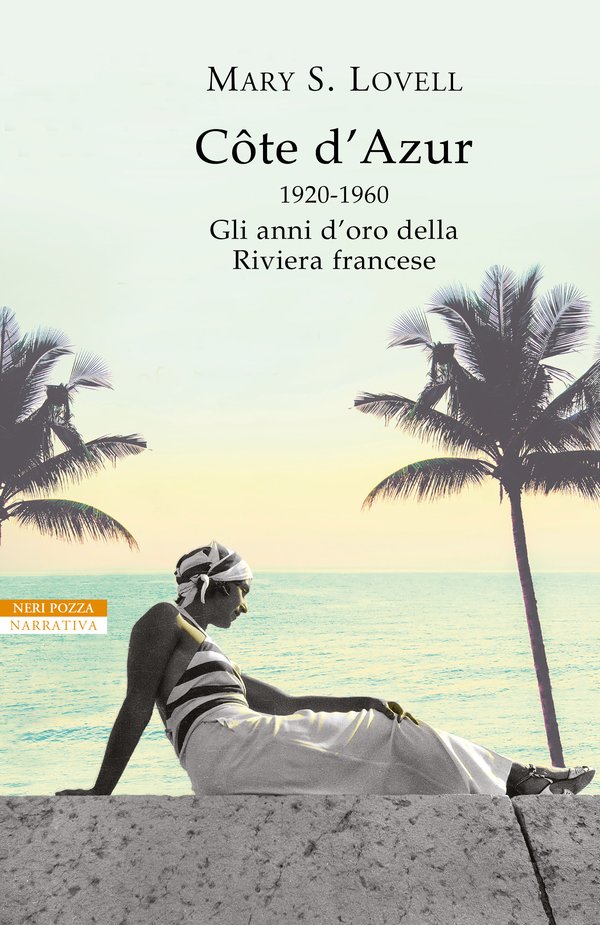
Non vi aspettate da questa piacevole ricostruzione la storia della Costa Azzurra e dei suoi ricchi e famosi o dei suoi belli e dannati, as you like it, ma soltanto di una porzione di essi. E di un luogo, lo Chateau de l’Horizon tra Antibes e Vallauris nel Golfe Juan, dei suoi proprietari e dei suoi ospiti assortiti. Lo costruì nel 1932 l’architetto americano Barry Dierks per la connazionale Maxine Elliott (1868-1940), attrice teatrale di vasta fama tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, donna in gioventù bellissima e nella maturità inquartata, pioniera dell’enstrangement.
Figlia di un marinaio, Maxine (che all’anagrafe fa Jessie Dermott) esce di casa con un matrimonio minorenne che dura pochissimo, calca le scene, sposa un divo del teatro dal quale, divenuta più acclamata di lui, divorzia. Ha un flirt con un tennista neozelandese che morirà durante la Grande Guerra (in Belgio lei soccorre e sfama 300mila civili in fuga dai tedeschi) e relazioni con uomini potenti (il banchiere e magnate dell’acciaio John Pierpont Morgan si occupa dei suoi investimenti e fa di lei una donna ricchissima, quando altri alle amanti avrebbero aperto una merceria). Con la famiglia d’origine ha rotto i ponti, manterrà rapporti affettuosi soltanto con la sorella minore anch’essa attrice, e con i nipoti per i quali sarà la protettiva zia ricca. La figlia del marinaio, che dall’America trae le sue fortune, si sente però inglese e punta alla “high society”.
Esistono regole non scritte ma ferree per essere ammessi, se non a corte, almeno nei salotti: avere un blasone (Maxine non lo ha e rifiuterà nobili proposte di matrimonio), essere ricchi quanto o più di loro (e Maxine lo è, molti degli aristocratici che frequenta vivono perennemente al di sopra dei loro mezzi) e saperli intrattenere, divertire, coccolare, sfamare. L’americana punterà su queste doti, riuscendo a sedurre e frequentare Edoardo VII figlio libertino della regina Vittoria e monarca a sua volta dal 1901 al 1910, e con lui il gotha inglese. Quando si trasferirà in Francia e farà erigere il suo “castello”, gli ospiti non mancheranno: il fatuo e fascistoide Duca di Windsor e la sua intrigante moglie Wallis Simpson amica dei nazisti, ma anche il premier britannico David Lloyd George, la “divina mondana” Elsa Maxwell, soprattutto Winston Churchill in esilio dalla politica che tra il 1934 e il 1940 si ritirerà allo Chateau per mesi (Maxine gli mette a disposizione un intero piano) per scrivere e dipingere.
Occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, affittata brevemente dalla moglie di un miliardario americano con velleità da jet set, la villa verrà acquistata nel 1948 da Ali Khan padre dell’attuale Kharim, che qui celebrerà nel 1949 il matrimonio con Rita Hayworth. Ali è l’altro grande personaggio del libro: islamico cosmopolita e occidentalizzante (suo padre, l’Aga Khan III, è il capo della setta sciita degli ismailiti), farfallone e mondano qb (i flirt si contano a decine, dopo la fine del matrimonio con la Hayworth arriverà la storia con la bellissima Gene Tierney) ma anche colto e versatile (è stato ottimo combattente in guerra con gli inglesi, guida fuoriserie e pilota aerei, è abile uomo d’affari e leggendario conoscitore e allevatore di cavalli). La sua eccessiva mondanità gli costerà il “trono” ismailita (ma va ricordato, in tempi di talebani, il suo sostegno all’intraprendenza e all’indipendenza femminile), la sua morte in un incidente d’auto chiuderà nel 1960 la saga. La villa di Maxine, nel 1979, verrà acquistata dalla famiglia reale saudita, alla quale tuttora appartiene.
Trait d’union fra Maxine e Ali è uno tra i più notevoli personaggi tratteggiati da Lovell, Pamela Digby poi Churchill poi Harriman. Proveniente dai lombi dell’aristocrazia inglese, sposa dell’inconcludente e alcolista Randolph Churchill figlio di Winston (1939-1945), una lunga relazione con Gianni Agnelli (iniziata nel 1948; interrotta quando lui, sorpreso a letto con un’altra donna, lascia la casa di Pamela dopo un litigio e, pieno d’alcool e coca, ha un incidente d’auto che lo lascerà zoppo; terminata nel 1952), altre storie con Ali Khan, il barone Elie de Rothschild e l’armatore Stavros Niarchos, un secondo matrimonio con il produttore hollywoodiano Leland Hayward (1960) e un terzo con l’antico amore Averett Harriman (1971), industriale (sua era la ferrovia Union Pacific), diplomatico (fu l’inviato speciale di Roosevelt presso Churchill e Stalin) ed eminenza grigia del partito democratico. Inaffondabile come Maxine Elliott, Pamela conclude la sua vita più che movimentata come ambasciatrice degli Stati Uniti a Parigi. Quando muore, nel 1997, Chirac decora la sua bara con la Legion d’Onore e Clinton le decreta funerali di stato.
La Costa Azzurra, se non “posto soleggiato per gente losca” come la definì Somerset Maugham che pure ci risiedeva, come parco giochi per ricchi e scrocconi d’alto bordo.
Massimo Montanari, Amaro. Un gusto italiano, Laterza, 2023

Restare con l’amaro in bocca è, per il vocabolario, essere costretti ad accettare qualcosa di sgradevole senza potere esternare il proprio disappunto. Sarà anche vero in senso metaforico, ma in cucina la musica cambia. Ce lo ricorda Massimo Montanari, il nostro maggiore storico dell’alimentazione, con Amaro. Un gusto italiano.
Difficile trovare, altrove, dolci e liquori che si chiamano “amaretto”, frutti con il leggiadro nome “amarena” o “(a)marasca”, vini che esibiscono l’amaro in etichetta (amarone, negramaro), gente abituata come noi a preferire il caffè senza zucchero. Sono apprezzate da noi le arance (e le aranciate) amare, l’amarognolo delle olive e di certi oli “fruttati” ed erbacei che l’Europa del nord fa fatica ad accettare, il miele amaro (di corbezzolo, di castagno).
E gli amari intesi come liquori, centinaia in tutta la penisola dove ogni città ha il suo o ne ha più d’uno, record difficile da eguagliare, che oggi vengono premiati nei contest internazionali come i migliori del mondo (è accaduto nel 2018 al calabrese Jefferson, nel 2022 al siciliano Amara) e celebrati nella mixology. All’origine di questa fortuna, monaci e centerbe a parte, c’è la produzione industriale avviata nel 1845 da Bernardino Branca con il Fernet nel 1848, quando a Milano si combattevano le Cinque Giornate: lo seguì ben presto il farmacista bolognese Ausano Ramazzotti. All’inizio il Fernet era pubblicizzato come medicinale. Era del resto convinzione dei medici di allora che erbe e pozioni amare curassero molti mali.
Ecco, le erbe, le verdure. Amare soprattutto le selvatiche che i contadini raccoglievano ma anche le cicorie e i radicchi, le radici di scorzonera, i carciofi – un viaggiatore illustre come Michel de Montaigne inorridiva alla nostra abitudine di mangiarli crudi – e i cavoli, pensate a quello nero fondamentale nella ribollita. Cibo per i villani che i nobili e la nascente borghesia spregiavano. La vituperata cucina contadina, racconta Montanari, alla fine ha vinto. Si è introdotta di soppiatto nei banchetti, cosparsa di spezie o addolcita sulle prime, per cominciare a celebrare i suoi trionfi con le insalate. Da allora le verdure hanno avuto campo libero e l’amarognolo è diventato quasi emblema identitario a tavola. Come dice il proverbio: le cose amare tienile care.
Bruno Munari, Supplemento al dizionario italiano, Corraini, 2023

È la ventiseiesima ristampa, il libro venne pubblicato in prima edizione fuori commercio nel 1958 per la Carpano. Il linguaggio dei gesti, da “ok” a “cosa vuoi”, da “silenzio” a “ti taglio la gola”. Didascalie trilingui, fotografie da modernariato di pregio. Il divertimento di un genio curioso.
Alessandro Robecchi, Pesci piccoli, Sellerio, 2024
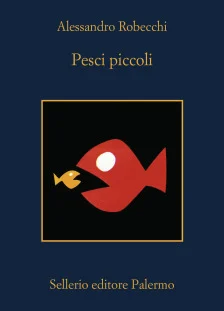
C’è una statua di Cristo con la corona di spine che si è messa a luccicare in quel di Zelo Surrigone, paese altrimenti sonnolento dalle parti di Abbiategrasso. E un santone belloccione, l’ex prete don Vincenzo assistito da un’ex pornostar convertita in perpetua, che attrae torme di gonzi in cerca del miracolo. Un’occasione troppo ghiotta perché Crazy love, il programma spazzatura di Flora De Pisis inventato da Carlo Monterossi, non ci si butti a pesce. Lui, il Carlo, bon vivant che un po’ si fa schifo per avere inventato l’obbrobrio e molto ci campa di lusso, per riscattarsi (per dimenticare la tv?) collabora con la Sistemi Integrati dei suoi amici detective Oscar Falcone e Agatina Cirrielli. Stavolta in ballo c’è uno strano furto alla Italiana Grandi Opere: durante la notte hanno trafugato una busta con 65mila euro, una pennetta usb e alcuni documenti relativi a una diga che dovrebbe essere costruita nel Ghana. Tangenti, ricatti, giri sporchi: il manager che chiede l’aiuto di Monterossi & c. ha buone ragioni per non rivolgersi alla polizia. Il malloppo è finito, per caso, nelle mani della piccola Teresa, donna delle pulizie divorziata e rassegnata, che fa orari impossibili per una miseria. E che vede quei soldi come una sorta di vincita al lotto, un’occasione per fare una vita diversa, senza troppo azzardare: un negozio da parrucchiere da aprire assieme a un’amica. Mentre le indagini proseguono svelando una serie di doppi e tripli giochi, di tentativi di estorsione e minacce, Carlo si innamora di Teresa mettendo in stand by la sua storia con Bianca Ballesi, in un impeto da Robin Hood la aiuta a truffare i truffatori (l’invenzione del “controcolpo”, che non si svela, è magistrale), e poi si allontana dal suo mondo di pesci piccoli risarciti dalla sorte, in cui sarebbe un estraneo forse paternalista, forse prevaricatore. Intanto i poliziotti Ghezzi e Carella, che stavolta non incrociano i detective, si dedicano alla routine: il minuscolo truffatore fesso, la puttana irreprensibile che una vicina di casa malmostosa ha denunciato, cose così. Perché, a Milano più che altrove, «servono un sacco di perdenti per tenere vivo il mito della città vincente». Sempre più Robecchi, sotto la buccia della commedia brillante e aguzza, affonda il bisturi negli orrori della disuguaglianza. Dando stavolta voce, con le parole dell’amatissimo Dylan, anche a un accorato sconforto amoroso. «Si è sentito solo, con un dolore che va su e giù come un cavatappi nel cuore». La canzone, non vi state a scervellare, era You’re a big girl now, dal capolavoro Blood on the tracks.
Toti Scialoja, Versi del senso perso, Mondadori, 1989

All’inizio degli anni ‘60 Toti Scialoja (1914-1998), pittore e scenografo tra i nostri maggiori, si reinventò poeta. Per caso e per azzardo. Con una serie di “poesie con animali” scritte per i tre nipoti. Dieci anni dopo era già uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento. Lodato da Italo Calvino, Giovanni Raboni, Giorgio Manganelli, Antonio Porta e molti altri. Questi lettori eccellenti avevano visto giusto: la produzione “infantile” di Scialoja, col tempo ne sarebbe arrivata anche una “seria”, raggiungeva vertici del nonsense non inferiori a quelli di Edward Lear e di Lewis Carroll e velava con il nonsense un “senso altro” tutto da decifrare, spesso con colate di umor nero, schizzi di malinconia, pozzanghere di derisione, mostrando una maestria formale (di rima, di ritmo, di associazioni foniche, di clamorosi giochi verbali) del tutto inconsueta ai nostri climi.
Nella sua dichiarazione di poetica Scialoja giocava la carta dell’understatement: «La struttura di queste poesie nasce da un metodo puramente linguistico automatico, al modo dello scioglilingua, della filastrocca e del nonsense. Gioco fonemico che i bambini intendono d’istinto, che eccita la loro curiosità, li muove alla scoperta della parola nuova come incantevole meccanismo sonoro. Infatti l’ostacolo che rappresenta il vocabolo inatteso, nell’assonanza con gli altri, contribuisce a creare quei “paesaggi di parole” … che liberano il bambino dalla soggezione al linguaggio e dentro i quali essi entrano ed escono con felicità e naturalezza».
Tutto vero, per carità. Ma tutto vero per sottrazione. Per modestia. Già fermandosi alle filastrocche, ci sarebbe da ripetere la storia (vera, la raccontava Antonio Porta) di W. H. Auden che, quando riceveva aspiranti poeti, andava per le spicce chiedendo subito: le piacciono le filastrocche? Se il giovanotto rispondeva sì il colloquio proseguiva affabile, altrimenti arrivederci e grazie, è stato bello, meglio che facesse il geometra.
Dov’eravamo rimasti? Ah sì, al fatto che Scialoja non è soltanto un poeta per pargoli. Quelli del Gruppo ‘63, riuniti in un convegno molto battagliero a Orvieto, gli chiesero di declamare per loro. E Scialoja intonò:
Il sogno segreto
dei corvi di Orvieto
è mettere a morte
i corvi di Orte.
Cioè i tradizionalisti, le “Liale della letteratura”, vedi un po’ dove ti va a parare una filastrocca…
Un esercito di pulci
sta passando in treno merci
quando grido: Arrivederci!
fanno tutte gli occhi dolci.
Ridiamo la parola a Porta: «Immagine più amara delle tradotte militari non l’avevo mai trovata». Versi del senso perso, un’antologia uscita per la prima volta nel 1989, raccoglie sei volumetti di poesia che Scialoja aveva pubblicato tra il 1971 e il 1985. Provo a scegliere qualche verso al quale sono particolarmente affezionato, nel mio rimbambi(ni)mento:
Se l’ape apatica
posa una natica
sul fior del cardo
diventa un dardo.
A Sciaffusa
si è diffusa
la notizia
che le gatte
fan le fusa
per malizia.
Ogni topo di chiavica
appena nato naviga.
Un moscerino, spinto dal suo inconscio,
cadde nel vino, e vi divenne moscio.
Sotto un ace
ro il rinoce
benché lace
ro e di pece
dorme in pace.
Sotto un noce
ch’è di fronte
ronfa il ronte.
È lastricata d’ostriche
ogni strada ad Ostenda.
La passeggiata è ostica
ma la strage fu orrenda.
Potrei continuare per ore. Senza trascurare le attenzioni, a mezza strada fra l’affettuoso e il derisorio, che Scialoja rivolge alla “poesia maggiore”. Ce n’è per Leopardi, per Eliot (avete presente “Aprile è il più crudele dei mesi/ genera lillà dalla terra morta”?). E per Dante:
Sempre caro mi fu quest’erto corno
pensa il rinoceronte
senza nessuno intorno.
La lepre ha il più crudele dei musi
quando morde i leggeri lillà sulla radura brulla,
strappa i fiori d’aprile, li ricaccia nel nulla,
col labbro che strafà profumato di verde.
A mezzogiorno, nella luce piena,
sui tavolini del Caffè Ruschena,
conobbi il tremolar dell’amarena.
Può bastare. Per dire che Toti Scialoja è stato un genio. Un genio compreso, per fortuna. Chi ha bambini, chi ama i bambini e li frequenta e coltiva un po’ di fanciullaggine, farà bene a tenere i suoi versi a portata di mano, a portata di voce.
Lytton Strachey, Ritratti in miniatura, trad. Rodolfo e Maria Celletti, Guanda, 1989

La musa della concisione detta all’eminente bloomsburiano Giles Lytton Strachey (1880-1932) pagine che restano a lungo nella memoria. Piccoli gioielli di scintillante prosa che impastano un’osservazione benevola del biografato e la fanno lievitare con pepite di critica acuminata, con scaglie di irresistibile ironia, con minuti particolari che diventano la misura del ritratto. Questi Ritratti in miniatura risalgono all’estrema fase della vita di Strachey, dopo il successo non privo di polemiche che era arrivato con il classico Eminenti vittoriani (1912) e con le altrettanto perfette biografie La regina Vittoria (1921) ed Elisabetta e il conte di Essex (1928).
Strachey privilegia personaggi eccentrici, ai margini della scena culturale. O grandi personalità che ricevono luce dalla loro frequentazione (o dalle loro controversie) con personaggi piccoli ma in qualche modo in grado di definirli.
Sfilano così, pagina dopo pagina, il poeta minore cinquecentesco sir John Harrington, delizioso vagheggino di corte che traduce l’Orlando furioso ma passa alla storia per un poemetto, Le metamorfosi di Aiace (“ajax”, nell’inglese vernacolo dell’epoca, designa gli escrementi), che accompagna una sua invenzione, il water closet, prontamente adottata dalla regina Elisabetta.
Lo strampalato riformatore religioso Lodowick Muggleton, profeta autonominato e sarto nella vita, che ritiene la preghiera inutile e blasfema. Il secentesco John Aubrey, ricco ridotto in povertà da un’impressionante e quasi comica serie di catastrofi, che assapora la felicità quando, caduto in miseria, vive alle spalle degli amici. Dotato di erudizione prodigiosa (sa di storia naturale, geologia, architettura gotica, mineralogia, pittura, araldica, statistica, astrologia, geometria), Aubrey è tra i fondatori dell’archeologia inglese, scrive trattati di pedagogia e gastronomia ed è uno straordinario quanto casuale compilatore di Vite brevi (la sua raccolta di ritratti in miniatura è stata pubblicata in Italia da Adelphi).
Seguono il pedante e apprensivo dottor North, rettore del Trinity College. Il grande commediografo della Restaurazione William Congreve rivalutato con grande penetrazione critica. Madame de Sevigné riflessa dalla vita del suo cugino amabilmente fatuo e bon vivant, Emmanuel de Coulanges. Lo scioperato, libertino, ubriacone e snob James Boswell, autore a sorpresa di quel capolavoro che è la Vita di Johnson. L’abate Morellet che ha conosciuto la “douceur de vivre” degli anni prima della rivoluzione e si è specchiato nelle vite eccellenti di Diderot e degli altri esponenti del secolo dei Lumi. Mary Berry, amore senile non corrisposto di Horace Walpole che la lascia erede delle sue sostanze.
L’aristocratica russa Madame de Lieven, che da Londra detta le mosse delle cancellerie di mezza Europa, fino allo scontro impari con Palmerston che provoca il suo rientro in Russia e il successivo trasferimento a Parigi, dove diventa l’amante di Guizot (lo era stata di Metternich). Di toccante eleganza la sua morte: «Un giorno ella lo pregò di lasciarla sola, di recarsi per un attimo in una stanza vicina. Guizot obbedì; quando tornò, ella era morta. Gli aveva lasciato un biglietto, scarabocchiato a matita: “Je vous remercie des vingt années d’affection et de bonheur. Ne m’oubliez pas. Adieu, adieu”».
In un mondo in cui anche le uscite di scena erano “a futura memoria”, le liti potevano essere feroci e protrarsi per una vita. Strachey ne racconta due: la lunga controversia, con attacchi reciproci, cause giudiziarie e appelli alla Corona che oppone Colbatch e Bentley per la guida del Trinity College, forse il più bel resoconto che io abbia letto sui rancori accademici e le polemiche fra intellettuali. E la lite per futili motivi (il pagamento di venti carri di legna) che oppone a Ferney il grande e taccagno Voltaire al puntiglioso e umanista presidente de Brosses (ricordo ancora le penetranti pagine di un suo viaggio in Italia), che gli ha venduto una proprietà. La spunta de Brosses, deciso a non cedere al grand’uomo più per questioni di principio che per l’esiguità della somma dovuta. La paga cara: dieci anni dopo, quando de Brosses viene candidato all’Accademia di Francia, Voltaire muove tutte le sue pedine perché non venga accolto.
Ci sono infine sei ritratti di storici inglesi: a parte l’amato David Hume, che finisce fra gli scrittori di storia anche se è soprattutto grande filosofo (scrive il Trattato sulla natura umana non ancora trentenne), sono Gibbon e Carlyle a incarnare il buono e il cattivo storico per Strachey. Sotto il segno della felicità, della pienezza di vita e dell’acutezza d’ingegno, sotto il segno del dilettante di genio di smisurata erudizione, salda volontà e brillante esecuzione è posto Edward Gibbon, autore della monumentale e straordinaria Storia della decadenza e della caduta dell’impero romano.
Viceversa Thomas Carlyle, bigotto e conservatore, adoratore di personalità eroiche, viene rudemente ridimensionato: «Nell’ultimo periodo della sua vita, Carlyle si dedicò allo sviluppo di una sorta di teoria super-morale, in forza della quale tutti i peggiori difetti della natura umana (l’egoismo, la mancanza di sensibilità, l’amore del potere) divennero oggetto della sua religiosa adorazione. Era un’etica mostruosa e contro natura in cui si fondevano tutti gli inconvenienti possibili e immaginabili della virtù e del vizio. Orbene, Carlyle, spintovi da qualche arcano motivo, elesse a prototipo, a eroe del suo sistema, Federico di Prussia, e impiegò quattordici anni di indefesso lavoro a narrarne la storia. Mai si conobbe maggiore aberrazione. Federico fu in realtà un furfante di genio, uno scettico, un avventuriero settecentesco dotato di una volontà ferrea e di spiccate attitudini organizzative».
A proposito del moralismo sermoneggiante del Carlyle, il giudizio non è meno tagliente: «Se saltuari, i luoghi comuni sono tollerabili; ma se ne incontriamo per ogni dove, sono insopportabili, ossessionanti, anzi. In Germania, taluni cuochi hanno il culto dei semi di comino: e non sanno astenersi dall’introdurne in ogni piatto, dalla panna montata al cosciotto d’agnello. Non si tarda a riconoscere il sapore fatale. Lo si attende in preda a una inerzia pervasa di orrore, e tutto a un tratto lo si avverte. A un certo punto, anche il minimo sospetto che una vivanda contenga del comino è sufficiente a provocare un senso di nausea. Le opere storiche di Carlyle (al pari, sia detto per inciso, dei romanzi di Thackeray), evocano le identiche sensazioni: il riconoscimento del ben noto odore sin dalla prima zaffata, l’inevitabile saturazione e uno stringimento di cuore sempre più violento».
Su Thackeray dissento, Carlyle è colpito e affondato.
William Trevor, Leggendo Turgenev, trad. Laura Pignatti, Guanda, 2012
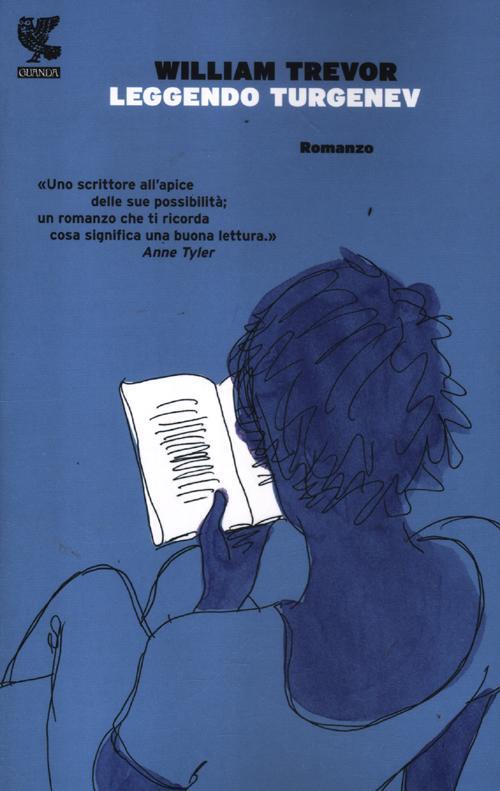
«Una donna, cinquantasette anni non ancora compiuti, esile e all’apparenza fragile, mangia con circospezione a un tavolo in un angolo. Qualcuno le ha diviso a metà le fette di pane imburrato, le ha schiacciato le uova con la forchetta, le ha tagliato a pezzetti il bacon. “Questa sì, che è felicità!” mormora a mezza voce, ma nessuna delle donne presenti nella sala da pranzo le risponde, perché nessuna è abbastanza vicina da sentire. È una privilegiata, dicono le altre, ha il permesso di occupare da sola il tavolino senza tovaglia nell’angolo. Ha il suo sale e il suo pepe personali».
La donna si chiama Mary Louise Dallon, da trentun anni è ricoverata in un ospedale psichiatrico. Deve affrettarsi a finire la cena perché al parlatorio la attendono: è il marito, i manicomi vengono smantellati anche qui e lui è venuto ad annunciarle che la riporterà a casa. «Tu un posto dove stare ce l’hai, cara», le dice. «Pensavo che fossi Insarov», risponde lei, «a dire il vero sono stata interrotta durante la cena». E si gira per andarsene. Insarov è il personaggio di un romanzo di Turgenev, Alla vigilia.
Un passo indietro. Mary Louise è cresciuta in una piccola fattoria, figlia di contadini poveri. Era una bambina ingenua e incline ad accendersi (la sua maestra ricorda che Giovanna d’Arco la appassionava), vivace e pronta allo scherzo: una volta fu punita perché aveva messo dei lombrichi nel banco di una compagna impressionabile. Ma nel complesso mite, di buon carattere, solo un po’ svagata. Mary Louise ha sposato Elmer Quarry a ventun anni: lui ne aveva trentaquattro, era grassoccio e cominciava a perdere i capelli. Elmer aveva un negozio di tessuti nel centro della cittadina dove Mary Louise aveva sognato di andare a vivere, per fare la commessa in farmacia, abbandonare la campagna e indossare un camice bianco. Un matrimonio di reciproca convenienza. In qualche modo un matrimonio obbligato: siamo in Irlanda, negli anni ’50, in un paesino polveroso (forse la Mitchelstown dove Trevor è nato), e Mary Louise ed Elmer sono protestanti. Benestante lui, povera lei, ma membri superstiti di una minoranza in estinzione: in chiesa, alla domenica, saranno sì e no una trentina e i matrimoni misti sono rari.
Il loro matrimonio si trasformerà in un piccolo inferno. Per lei soprattutto, ma in definitiva per tutti e due. In casa comandano le due sorelle di Elmer, nubili e tiranniche. E la giovane cognata è fatta bersaglio di piccole ma costanti angherie, vissuta come un’intrusa che sconvolge la loro routine. Il matrimonio non dà figli: perché Elmer è impotente (lo si apprende in maniera obliqua, William Trevor è un maestro dello sfumato, dell’accennato, del non detto o quasi), anche se la cittadina troverà più comodo credere che Mary Louise sia infeconda.
Elmer, incapace di far funzionare il matrimonio, timido protettore della moglie ma disarmato e vigliacco di fronte alle sorelle, reagirà trasformandosi, lui astemio, in un ubriacone. Le sorelle reagiranno con la costante querimonia, con tentativi maldestri di rimandare la cognata nella famiglia di origine, e con tentativi più riusciti (e assecondati dalla cittadina) di cucire addosso alla giovane i panni dell’eccentrica, di quella che vive in un mondo tutto suo, di quella che ha rovinato il marito, di quella maldestra che non aiuta né in casa né al negozio, di quella che se ne va in giro e chissà dove va. Della matta, infine.
Mary Louise asseconda le cognate. Distratta e come sorda, sta sulle sue, mangia appartata. Gira in bicicletta. Va in campagna, a trovare un cugino coetaneo e cagionevole che le legge i romanzi russi (forse solo quel romanzo di Turgenev), le spiega le battaglie muovendo i soldatini, le mostra gli aironi. Mary Louise se ne innamora, crede di esserne stata innamorata quand’era bambina. Il loro amore, romantico e platonico, dura pochi mesi. E quando il giovane muore, Mary Louise sceglie di serbarne il ricordo. Di più, sceglie di farlo diventare la sua vita.
Svaligiando la cassaforte del marito (ma la somma spesa, malgrado lo scandalo e gli strepiti delle cognate, è esigua e il denaro di famiglia torna al sicuro), acquista all’asta i mobili, i libri, i soldatini del defunto. Ne recupera gli abiti da una famiglia povera alla quale sono stati regalati. Si trincera nella soffitta di casa, non vede più nessuno, passa il tempo in solitudine. E l’internamento, quando si sospetta che abbia cercato di avvelenare il marito e le due zitelle con un topicida, è inevitabile.
William Trevor (1928-2016), che con deliziosa civetteria si considerava uno scrittore di romanzi nel tempo libero, è ritenuto da molti e autorevoli estimatori il massimo autore di short stories in lingua inglese (Goffredo Fofi lo definisce «maestro del racconto nella linea di Cechov, Mansfield, del conterraneo Joyce dei Dublinesi e oggi di Alice Munro»). Trevor è grande anche nell’arte del romanzo. Sottoscrivo il giudizio che ne ha dato Daria Galateria: Leggendo Turgenev è magistrale. Sottoscrivo il giudizio di Fofi: lo si legge con ammirazione e commozione.
Sottoscrivo fino a un certo punto le loro interpretazioni. Per Galateria, è il romanzo di una nuova Bovary. Per Fofi, è il romanzo «di una vita che non può dare fiore né frutto, che non può vedere pienezza e maturazione, ma solo vivere il classico, antico intreccio di amore e repressione». Sì, la repressione c’è, anche se Mary Louise la subisce e la ignora al tempo stesso. E il suo amore sospeso fra realtà e immaginazione può essere scambiato per bovarismo.
Eppure, non sono sicuro che le cose stiano così. Mary Louise non è una donna «condannata – come tante, come troppe – alla malinconia e alla solitudine». Mettendo per un attimo da parte il politically correct compassionevole, occorrerà notare che lei quella solitudine l’ha cercata, l’ha coltivata. Ritrovandosi “felice” in manicomio (ricordate la frase con cui, non a caso, comincia il romanzo?). E artefice del proprio destino: è lei che, con l’alibi della distrazione e con una calcolata strategia della disattenzione, ha mosso gli eventi in direzione di quell’internamento, perché per la giovane donna il ricordo di quell’amore (e di quei romanzi russi, sembra sottendere con discrezione ma con ferma convinzione l’autore) erano più veri e degni di essere vissuti della vuota e opaca vita vera che le era stata data in sorte. Una strategia di “uscita dal mondo” (come i mistici raccontati da Élemire Zolla) che è rivelazione di sé a se stessi. Mary Louise, più che una vittima, è un’eroina intrepida. Come la Giovanna d’Arco che ammirava da ragazza. Come le protagoniste dei romanzi russi che le hanno oscurato il povero orizzonte irlandese.
Con un colpo di scena che non raccontiamo (ma che è tutt’altro che una trovata ad effetto, tutt’altro che un calcolo da plot, e che getta una luce intensa e coerente sul personaggio, consentendo di leggerlo a ritroso), Mary Louise non solo non ha tentato di avvelenare i parenti, ma ha fatto in modo che loro credessero al tentato veneficio e la rinchiudessero, per sbarazzarsi in maniera incruenta e altrettanto definitiva di loro. Mary Louise, per buttarla sul prosaico, si è finta matta per non pagare il dazio di quell’infernuccio familiare.
Anche gli echi letterari di Leggendo Turgenev non portano dalle parti di Madame Bovary, se non per constatare che Trevor, per me il maggiore degli irlandesi contemporanei, è un romanziere flaubertiano, un burattinaio invisibile e demiurgico dei suoi personaggi. L’aria che ci respiro è inglese: Il Mulino sulla Floss, con l’amore dell’intrepida Maggie per il sensibile e deforme figlio dell’avvocato Wakem. E più ancora irlandese, in quella vibrante apologia della memoria sentimentale che è il pianto dirotto di Greta al ricordo del giovane innamorato che si era ammalato ed era morto dopo aver cantato sotto il suo balcone (l’ultimo racconto dei Dubliners di Joyce), mentre la neve cade a imbiancare la terra d’Irlanda, a coprire sotto la sua coltre i vivi e i morti.
Se il romanzo di Trevor non è un capolavoro, gli assomiglia in maniera impressionante.
Simon Winchester, Il professore e il pazzo, trad. Cristina Leardini, Adelphi, 2018
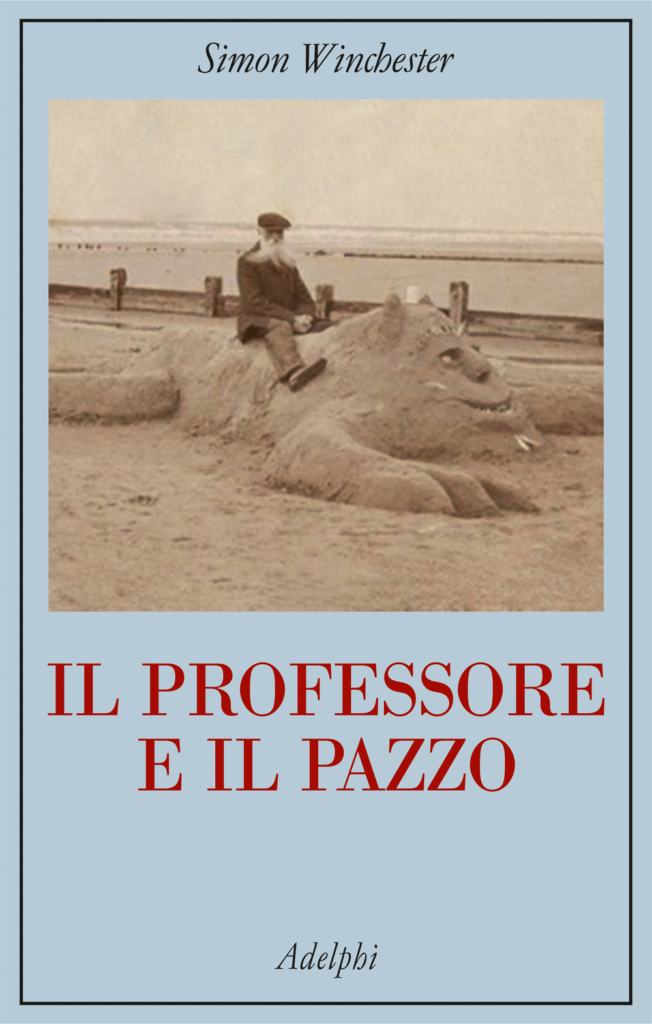
Dove i romanzi falliscono rimedia a volte l’inchiesta storico-giornalistica, che si dimostra capace di un plot più ingegnoso, di personaggi incisi con maggior vigore, di sorprese ed epifanie meno prevedibili. È il caso di Il professore e il pazzo, pubblicato in una prima edizione italiana – la traduttrice è la stessa – da Mondadori nel 1999 con il titolo L’assassino più colto del mondo.
La storia è vera: l’incontro nel 1896, dopo anni di rapporto epistolare, fra il professor James Murray, fondatore e coordinatore dell’Oxford English Dictionary, e il suo più importante collaboratore, l’erudito William Chester Minor che gli spedisce citazioni dotte e insolite da Broadmoor in Cornovaglia.
Il luogo è la sede di un manicomio criminale dove Minor, un ufficiale medico dell’esercito americano impazzito durante la guerra civile (era stato costretto, riluttante, a marchiare a fuoco sul viso un disertore irlandese), è stato rinchiuso dopo avere ucciso vent’anni prima a Lambeth, nella periferia di Londra, un giovane operaio. Nella sua follia, lo aveva scambiato per un nazionalista irlandese venuto a vendicare il soldato deturpato.
La storia di questo incontro, e le vite parallele del professore scozzese e del folle americano, si intrecciano con la storia dell’Oxford English Dictionary, di gran lunga il più importante e monumentale repertorio linguistico dell’Occidente. È straordinaria la vita dell’erudito James Murray, figlio maggiore di un sarto e negoziante di tessuti scozzese, nato nel febbraio 1837, scolaro fino ai quattordici anni e da allora in poi autodidatta, pastore di vacche e assistente del direttore di una scuola, poi fondatore a sua volta di una scuola a pagamento.
A trent’anni scrive per chiedere un impiego al British Museum, che non lo assume. Si presenta così: «Devo dire che la filologia, sia comparativa sia specialistica, è stata per tutta la vita il mio campo di ricerca favorito, e che possiedo una padronanza generale delle lingue e della letteratura delle classi ariane e siro-arabiche; con ciò non voglio dire di avere familiarità con tutte o quasi tutte, ma di possedere le conoscenze generali lessicali e strutturali che fanno della loro conoscenza più approfondita solo una questione di un po’ di applicazione. Di diverse ho una padronanza più solida, come delle lingue romanze – italiano, francese, catalano, spagnolo, latino e in misura minore portoghese, valdese, provenzale e vari dialetti. Nel ramo germanico, ho un’accettabile familiarità con l’olandese (dovendo, in qualità di corrispondente commerciale, leggere in olandese, tedesco, francese e occasionalmente in altre lingue), il fiammingo, il tedesco, il danese. Nell’anglosassone e nel gotico della Mesia i miei studi sono stati molto più accurati, avendo preparato su queste lingue alcuni lavori per la pubblicazione. So qualcosa del celtico, e al momento sono impegnato con lo slavo, avendo raggiunto una soddisfacente conoscenza del russo. Nell’ambito del persiano, della scrittura cuneiforme del periodo achemenide e del sanscrito, so quanto basta per gli obiettivi della filologia comparativa. Ho una conoscenza dell’ebraico e del siriaco sufficiente per leggere a prima vista l’Antico Testamento e il Peshito; a un livello inferiore conosco l’arabo aramaico, il copto e il fenicio fino al punto in cui fu lasciato da Genesio».
Ingeneroso fare confronti con i curricola odierni, dove tutti conoscono l’inglese e il francese e sanno usare Windows e navigare nel web. E di sommo fascino la storia del dizionario, di questa muraglia cinese di parole per ciascuna delle quali, in decenni di lavoro, si rintraccia la genesi e la prima certificazione dell’uso in un testo letterario, grazie all’appassionata opera di spoglio da parte di gruppi di collaboratori volontari e non retribuiti, fra i quali emerge il medico folle di Broadmoor. Una storia di dolore e di perdita di sé dalla quale nasce, con il censimento delle parole, un possibile ordine del mondo. Il professore e il pazzo è anche il titolo di un film del 2019 tratto dal libro. Lo ha diretto P. B. Shemran, il professore è Mel Gibson e il pazzo Sean Penn.
Stefan Zweig, Il mondo di ieri, trad. Lorena Paladino, Garzanti, 2021

Sono incantati e dolenti questi “ricordi di un europeo” del grande e generoso viennese Stefan Zweig (1881-1942). Sospesi tra due secoli, la testa nell’800 e il cuore nel ‘900, poco o niente nostalgici malgrado il titolo, o meglio nostalgici non del passato ma del futuro che poteva essere e non è stato, quel sogno della ragione che per breve tempo regalò progresso, pace che si pensava perpetua, affratellamento e cosmopolitismo (sono pagine bellissime quelle in cui Zweig racconta come, all’inizio del secolo, si potesse viaggiare per ogni dove senza passaporto, e come in America si riuscissero a trovare cinque lavori in due ore). Un sogno sconfitto dal furore nazionalistico che ha portato alle due guerre mondiali, alla macelleria immane di quei conflitti.
Zweig nasce in una famiglia della medio-alta borghesia ebraica, di quell’ebraismo colto che non si mette troppo in mostra e si arricchisce con prudenza, senza azzardare speculazioni. Di quell’ebraismo ansioso di integrarsi e di elevarsi culturalmente, che riempiva i teatri, collezionava arte, faceva mecenatismo ed esprimeva musicisti e scrittori. L’Austria di fine ‘800 e inizi ‘900, capitale culturale dell’Europa assieme a Parigi (qui operano e creano Mahler e Schönberg, Freud, Musil e Schnitzler, Hofmannstahl e Kraus e Roth a tacere degli innumerevoli altri), viveva la sua “età della sicurezza”. «In questo clima di commovente fiducia in cui si aveva la certezza di poter proteggere la propria vita circondandola con una palizzata priva della benché minima breccia da dove potesse irrompere la sorte, si respirava, malgrado tutto l’apparente buonsenso e la sobrietà che una simile visione del mondo sembrava trasmettere, un pericoloso senso di presunzione. Il diciannovesimo secolo, con il suo idealismo liberale, era sinceramente convinto di muoversi lungo una rotta diritta e sicura verso “il migliore dei mondi possibili”. Osservava con disprezzo le epoche precedenti, con le loro guerre, carestie e rivolte, considerandole tempi in cui l’umanità non aveva ancora raggiunto la maggiore età, non era ancora sufficientemente illuminata».
Questo apogeo racchiude già in sé l’inevitabile declino: l’imperatore che sembra immortale ed è soltanto vetusto, la bonomia che nasconde ottusità e corte vedute, la morale sessuale ipocrita del doppio binario, del “si fa ma non si dice” (e possono fare soltanto i maschi, che hanno diritto a sfogare gli impulsi, non le donne che se solo ci pensano sono catalogate “isteriche”).
Zweig vive come una gabbia, dorata ma gabbia, quel “paese ordinato” che era l’Austria. È gabbia con le sbarre che chiudono l’accesso al mondo la scuola, con un programma arido e formale e nessuna concessione alle curiosità degli allievi, che devono scoprire in solitudine passioni e maestri. È messa in gabbia la donna compressa nel busto con le stecche di balena, è gabbia l’impossibilità di frequentare in amicizia l’altro sesso (ma lo si può frequentare al bordello). Sono pagine vibranti, quelle in cui Zweig celebra le conquiste del ‘900: accanto alla scienza e alla tecnica, e forse prima ancora, gli stanno a cuore l’incivilimento dei costumi, quelle ragazze degli anni Venti che possono tagliare i capelli corti, uscire a spasso, indossare vestiti comodi e fare sport.
Altrettanto vibranti, e dense di ammonizioni, sono le descrizioni dei nazionalismi di inizio secolo (il fervore, l’entusiasmo delle folle viennesi alla prospettiva di una guerra che doveva essere passeggiata e sarà carnaio e rovina, l’eccesso di forza che fa accantonare ogni misura) e del pensiero con l’elmetto che, prima, trasforma ogni vecchio amico in nemico e poi, sotto il nazismo, diventa servo encomio o silenzio vigliacco di fronte alla brutalità di Hitler, per Zweig intuibile già quando si affaccia sulla ribalta e prima che prenda il potere. Zweig è uomo di cuore e di ragione: un umanista votato a un tolstojsmo laico, quasi a una sorta di gandhismo. Un pacifista, parola che oggi sembra fare quasi orrore, che pensa di fermare la marea montante della barbarie con gli appelli alla mitezza e alla ragione. Fu sconfitto, ma quanta nobiltà di spirito in quella sconfitta.
Zweig è, in quegli anni Venti e Trenta, l’autore in lingua tedesca più letto e venduto nel mondo. Un bestsellerista, si direbbe oggi (di qualità aggiungerei, per non lasciare spazio agli equivoci). Nei rapporti con gli amici e con il mondo letterario non si comporta come un maestro ma come un apprendista sempre pronto a inchinarsi di fronte al talento o al genio altrui, e a soccorrere amici e colleghi più sfortunati o votati alla distruzione (per anni sarà il finanziatore, munifico quanto discreto, di Joseph Roth). In queste memorie gli incontri sono tanti e tutti fervidi: Emile Verhaeren e Auguste Rodin che si dimentica di lui mentre sta scolpendo; Theodor Herzl giornalista e non ancora padre del sionismo che gli pubblica i primi articoli (Zweig confessa di dovergli molto ma di non avere potuto aderire al sionismo: si sentiva europeo, diffidava dell’esclusivismo ebraico come di altre fedi che imponessero vincoli, lui che pure era vicino ai socialisti e ammirò i primi passi della rivoluzione d’ottobre); Paul Valéry e Sigmund Freud, l’alfiere del pacifismo Romain Rolland Nobel del 1915 e Maksim Gorkij, i venerati Hugo von Hofmannstahl e Rainer Maria Rilke (e chissà che cosa ci avrà trovato un laico innamorato dell’umanità come lui nell’asceta aristocratico, nel sublime passatista votato a un individualismo esoterizzante e mitizzante: l’unico punto di contatto oltre alla religione delle lettere, forse, è l’amore disincarnato, che niente chiede e tutto sacrifica, della protagonista di Lettera a una sconosciuta, così segretamente affine alle amanti non corrisposte delle Elegie duinesi). Ma anche il ministro degli esteri della Germania weimariana, Walter Rathenau, assassinato nel 1922 dall’estrema destra che che nel breve volgere di qualche anno si farà nazismo. Il poeta Ernst Lissauer che scriverà una ballata tristemente famosa di odio per gli inglesi: e non ne avrà in seguito, lui ebreo, mercede dai nazisti. Il generale Karl Haushofer che inventa la geopolitica (e Zweig coglie subito, nel concetto di “spazio vitale tedesco”, un affioramento di ur-hitlerismo). Il colonnello Alfred Redl capo dei servizi segreti asburgici, costretto per la sua segreta omosessualità a diventare spia russa: scoperto, sarà indotto dai superiori a uccidersi con un colpo di pistola alla tempia per soffocare lo scandalo (alla vicenda ha dedicato un film assai bello, nel 1985, l’ungherese Istvan Szabò). Richard Strauss che accetta di collaborare con Hitler per salvare la nuora ebrea.
Scritto nel 1941 e pubblicato postumo (a Stoccolma, nel 1946), Il mondo di ieri è una memoria della sciagura in atto e dei passi che portano alla catastrofe collettiva. E a quella personale dell’autore. Entrato nella lista nera, condannato a non essere pubblicato, i suoi libri messi al rogo, Zweig fugge: in Inghilterra, in America, infine in Brasile. Sperimentando il vuoto attorno a sé e l’angoscia, lasciando un ultimo racconto mirabile e asciuttamente straziante (la Novella degli scacchi, in cui un prigioniero dei nazisti gioca una partita a scacchi tutta mentale contro se stesso, nella cella in cui è rinchiuso, per non arrendersi, per non abdicare alla ragione) e infine, nel 1942, suicidandosi a Petropolis vicino a Rio assieme alla giovane moglie. Ha lasciato scritto la sua amica e prima traduttrice italiana, Lavinia Mazzucchetti: «Stefan Zweig fu un assetato e un affamato di giustizia, ma non un beato in terra, perché gli mancò la speranza di essere mai saziato».