Curioso e, stavolta, veramente vorace! Il nostro lettore di gennaio è prodigo di consigli di lettura che spaziano dal sesso nel Medioevo alla poesia, passando per gialli, insoliti romanzi, saggi accattivanti fino al grande Enzensberger che di recente ci ha lasciati
Giuro che non la rifaccio così, questa rubrica, d’altronde sarebbe impossibile. Il periodo tra l’avvento e l’epifania è stato tempo, più che negli altri mesi, di libri letti e ricevuti. E i miei propositi (segnalare i libri arrivati in casa e quelli davvero letti) qui hanno strabordato. Colpa della stagione: tanti regali anche improbabili (un libro sulla cucina di Hayao Miyazaki, e se forse rivedrò Il castello errante di Howl è improbabile che cucini qualche piatto giapponese), teneri (un Essere nonni oggi che, diventato nonno, compulso come si consultano i tarocchi), azzardati (un giallo che comincia con una casalinga che fa i mestieri di casa come un guerriero ninja o come un monaco shaolin: con un incipit siffatto non avrei proprio voglia, ma c’è la dedica di un’amica cara, e dunque chissà). E poi tanti passaparola ai quali prestare ascolto, so di chi fidarmi. E, complice un tempo pigro e sospeso, letture e scritture più abbondanti del solito. Domani si riprende, con un numero maggiore di letture per lavoro e uno spazio minore alle letture per piacere. Intanto, largo al diario mensile.
LA SPESA (acquistati e/o ricevuti)
Giancarlo Ascari/ Pia Valentinis, Guida all’Italia semplice, Bompiani
Kate Atkinson, Il cerchio magico, Marsilio
Corrado Augias, La fine di Roma, Einaudi
Giorgio Boatti, Abbassa il cielo e scendi, Mondadori
Valentino Bompiani, Vita privata, Ronzani
Patrizia Carrano, Campo di prova, More Than A Horse
Alice Ceresa, La morte del padre, La Tartaruga
Gian Andrea Cerone, Le notti senza sonno, Guanda
Joshua Cohen, I Netanyhau, Codice
Pino Corrias, Vita agra di un anarchico. Luciano Bianciardi a Milano, Feltrinelli
Teresa Cremisi, La Triomphante, Adelphi
Torcuato Luca De Tena, Le linee storte di Dio, Vallecchi
Tove Ditlevsen, Gioventù, Fazi
Bob Dylan, Filosofia della canzone moderna, Feltrinelli
Ernesto Ferrero, Album di famiglia, Einaudi
Cosimo Filigheddu, La guerra di Pasca, Il Maestrale
Goffredo Fofi, Per Pasolini, La Nave di Teseo
Goffredo Fofi, Son nato scemo e morirò cretino. Scritti 1956-2021, Minimum Fax
Antonio Franchini, Leggere possedere vendere bruciare, Marsilio
Chiara Frugoni, A letto nel Medioevo
Susan Glaspell, Una giuria di sole donne, Sellerio
Élisabeth Jammes/ Étienne Pihouée, Manuale di eleganza per il perfetto gentiluomo, il Saggiatore
Lietta Manganelli, Giorgio Manganelli. Aspettando che l’inferno cominci a funzionare, La Nave di Teseo
Soma Morgenstern, Il figlio del figlio perduto, Marsilio
Carmine Pinto, Il brigante e il generale, Laterza
Joseph Pontus, Alla linea, Bompiani
Mariano Sabatini, Ma che belle parole! Luciano Rispoli, Vallecchi
Aldo Tanchis, Barbara la vita, 1000eunanotte
Stefan Zweig, La società delle chiavi incrociate, Jouvence
LE LETTURE
Giancarlo Ascari/ Pia Valentinis, Guida all’Italia semplice, Bompiani
Un viaggio in Italia amabile ed eccentrico, che accosta personaggi e avvenimenti, monumenti e talvolta prodotti, ai luoghi che li hanno resi famosi e proverbiali. “Mostri, casalinghe, venti e santi del bel paese”, per dirla con il sottotitolo. Così ci sono la casalinga di Voghera e la focaccia di Recco, la spigolatrice di Sapri (la statua che le hanno dedicato è stata lo scorso anno al centro delle polemiche per il culo in bella evidenza) e la porta alchemica di Roma (questa, nel cuore multietnico dell’Equilino dove il mio amico Lorenzo mi ha mandato la foto di una law firm con le bandiere che sembrava un internet point, ve la andate a scoprire, così magari decifrate la formula della pietra filosofale che permette di fabbricare l’oro), il santuario di Montevergine con “Mamma Schiavona” cara ai femminelli, la saponificatrice di Correggio e il busto di Lenin di Cavriago (ne parla anche il musicista Massimo Zamboni in un romanzo-memoir di aspra bellezza, La trionferà), il tempio sotterraneo di Damanhur e la pantera di Goro (è Milva, mentre Mina è la tigre di Cremona e Iva Zanicchi l’aquila di Ligonchio). Giancarlo “Elfo” Ascari e Pia Valentinis sono fra le altre cose due illustratori dei nostri maggiori, e le immagini che accompagnano i testi brevi e succosi, privi di sussiego e ricchi dei particolari curiosi che tanto ci piacciono, sono una festa per gli occhi. Fra gli aneddoti, delizioso quello dedicato al Tamburo della banda d’Affori, canzone zumpapà del 1943 che venne censurata dal fascismo perché quel tamburo principale che comanda 550 pifferi (“Che passion, che emozion, quando fa bum bum/ Guarda qua, mentre va le oche fan qua qua”) non può essere che lui, il Crapone, Mussolini, visto che 550 sono i membri della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che dal 1939 ha preso il posto della Camera dei Deputati. Un libro buono anche per giocarci, per fare elenchi. Il tamburo della banda d’Affori? E perché non anche la postina della Val Gardena, che bacia solo con la luna piena? E perché non Eulalia Torricelli da Forlì? Voi non la conoscete ma ha tre castelli, uno per dormire, uno per mangiare e uno per amare De Rossi Giosuè.
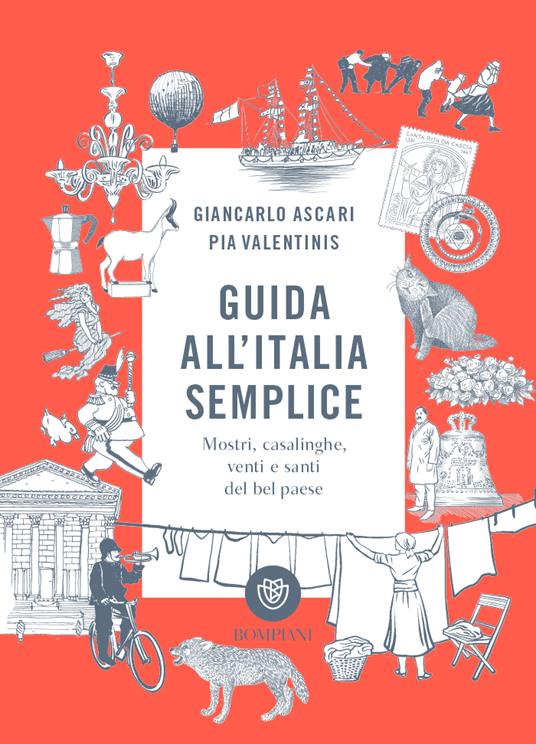
Kate Atkinson, traduzione di Ada Arduini, Il cerchio magico, Marsilio
«Cominciò a pensare a tutte le ragazze perdute nel corso degli anni. Quelle perdute nei boschi, sui binari ferroviari, nei vicoli, nelle cantine, nei parchi, nei fossati lungo le strade, nelle loro stesse case. Ci sono tanti posti dove una ragazza si può perdere». Il cerchio magico dei criminali raduna, nel North Yorkshire, tre uomini un tempo scagnozzi di pedofili di rango – imprenditori, deputati pro-Brexit, giudici, aristocratici – che si sono messi in proprio a importare ragazze ignare dall’Est e dall’Asia, offrendo un lavoro inesistente e avviandole ai centri massaggi e ai bordelli. I tre sono insospettabili, fanno gli avvocati, gestiscono aziende di trasporti e alberghi e hanno mogli complici o distratte. Ma contro di loro (e contro un quarantenne con un nickname da adolescente che chatta con ragazzine da adescare, una finirà per rapirla) indaga e agisce Jackson Brodie. Solitario e quasi ‘spalanuvole’ come il commissario Adamsberg della Vargas, laconico e mite ma svelto di mano, gentile all’occorrenza ed empatico con le donne e le persone fragili, nomade e appassionato di vecchie abbazie (e ascoltatore compulsivo di musica country, nessuno è perfetto), due matrimoni alle spalle, una relazione finita e una frequentazione non interrotta con l’attrice Julia con cui ha fatto l’adolescente Nathan, un cane sempre diverso che lo accompagna in ogni romanzo, Brodie è il miglior detective in cui mi sia imbattuto negli ultimi tempi. La Bbc gli ha dedicato negli scorsi anni una serie, Case histories, in cui ha il volto di Jason Isaacs, il perfido Lucius Malfoy della saga di Harry Potter; qui in Italia avrei visto nei suoi panni Valerio Mastandrea o Massimiliano Gallo. Il cerchio magico è il quinto episodio della serie, i precedenti quattro li trovate nei tascabili Feltrinelli.

Patrizia Carrano, Campo di prova, More than a Horse
«Gli animali hanno le loro ragioni e persino i loro segreti, assai diversi da quelli che abitano il cuore degli uomini». Misteriosi ma leggibili, interpretabili come campioni affidati alle cure di istruttori saggi ed esperti, i sei cavalli di questi racconti sono lo specchio in cui l’uomo si vede e si riconosce, per affinità o per contrasto. L’innesco che permette alle pulsioni e ai destini di venire allo scoperto. Campo di prova fu pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 2002. Lo ripropone ora una raffinata casa editrice specialistica, con la bella prefazione di Gian Luigi Tomassini.
La saura Chiaia, «dorata, bionda come una colata di miele», timida e umbratile, che nella gara riscatta l’insicura Etta sua padrona, consentendole di paraggiare i conti con l’ex marito sottilmente prevaricatore Alessandro (L’eredità di Pagoro). Il bambino Giulio al quale l’egoismo senile del nonno – i vecchi cattivi sono una specialità di Carrano – vieta di assistere il pony Porthos che per trascurataggine morirà (Il disegno di Fattori). L’amante di un allevatore che diventerà, trasferendo quell’amore, signora dei cavalli (Arlecchino, ispirato alla figura di Egle Fanelli morta nel 1930, che con il suo Arlecchino arrivò a vincere tra fine ‘800 e inizi ‘900 la cifra allora fantastica di 100 mila lire nei concorsi). Lorenzo Longhi che ha dissipato averi e talenti nel sogno di un circo equestre, e al quale il ritrovamento casuale e insperato di una serie di disegni di Géricault consentirà di sognare ancora (Il cavallo dei miracoli, ispirato dal Teatro Equestre Zingaro di Bartabas). Linea di sangue, la più vibrante di queste storie, che racconta la fine cruenta di Pioneer e del cagnolino Benvenuto, vittime delle zoomafie, con accenti di empatia che ricordano i racconti crudeli di Maupassant dedicati ai cani. E il conclusivo Il passo dei migliori, quasi ghost story che richiama per affinità di umori il Sandor Marai di Le braci: l’incontro estremo tra due vecchi che furono amici e che un cavallo, Lord Jim, e una donna divisero. «Ogni cavallo porta dentro di sé la misteriosa e ineludibile capacità di rivelare il valore delle persone con cui ha avuto a che fare. Per chi sappia ascoltarli, i cavalli sono narratori omerici, fluviali». Patrizia Carrano li ha saputi ascoltare, in queste storie (d’amore) in modo classico. Con una messe non soverchiante di termini specialistici che non devono spaventare né distrarre, come non ci distraevano ma aggiungevano un di più di fascino i termini marinareschi profusi da Melville e Conrad che leggevamo ragazzi perché, come ha scritto Daniele Del Giudice: «Solo la precisione permette di conservare lo stupore».

Alice Ceresa, La morte del padre, La Tartaruga, 2022
Una profana rappresentazione a celebrare, tra liberazione e soprassalti dolorosi, il congedo da un “sacro” ordine patriarcale. Personaggi senza nome, risucchiati e come pietrificati dal loro ruolo, sopravvissuti alle loro funzioni: il Padre morto (un padre-casa di muri e di pietra che tutta la famiglia imprigiona in sé), la Madre (non moglie, non vedova, e comunque sola in vedovanza come lo è stata nel matrimonio), i figli sempre figli anche quando sono cresciuti facendosi a loro volta padri e madri. La Figlia Maggiore che “mangia” il padre per eternarne l’autorità, la Figlia Minore con cane al seguito (Alice Ceresa ebbe, per tutta la vita, una nutrita serie di airedale a farle compagnia) che elabora un “padre concettuale” dal quale prendere per sempre le distanze, il Figlio che ha fatto i conti con la concreta eredità paterna. Quanto al Padre, ed è forse l’invenzione più vertiginosa di questo racconto arduo e raggelato, si ritrova per la prima volta “indifeso alla mercé dei vivi” e prende congedo da sé, dai suoi possessi e dai suoi ricordi, nei tre lunghi giorni che separano la morte dalla cremazione: la morte non come distacco hic et nunc ma come lento processo di sparizione. Dopo la cerimonia, auspicio più che evento nel lapidario capoverso che conclude il racconto marchiandolo di quieto furore: “Allora la famiglia infine esploderà”.
Riproposto dalla rinata La Tartaruga (è ora un marchio della Nave di Teseo, affidato alle cure dell’ottima Claudia Durastanti), questo racconto anomalo uscì nel 1979 su Nuovi Argomenti. Ne è autrice Alice Ceresa (1923-2001), scrittrice svizzera trapiantata in Italia, andata via di casa a sedici anni in rivolta contro quel padre tiranno – nella vita, apprendo da un dizionario degli scrittori svizzeri, era impiegato delle ferrovie – che non voleva farla studiare e poi giornalista, redattrice di Tempo presente di Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, consulente della Longanesi, traduttrice e parca scrittrice (soltanto due opere pubblicate in vita per Einaudi: La figlia prodiga, 1967, che inaugurò la collana “La ricerca letteraria” diretta da Davico Bonino, Manganelli e Sanguineti e vinse il Viareggio Opera Prima; e Bambine, 1990).
Scrittrice per scrittori, vicina al Gruppo 63 e molto amata da Calvino e Manganelli, la ‘figlia prodiga’ Ceresa, in rivolta contro il vecchio mondo, ha un argomento-ossessione del suo scrivere: l’ineguaglianza femminile. “Lo sgomento di non potersi considerare un essere umano a pieno titolo è un’esperienza tremenda che andrebbe analizzata. Non c’è accesso naturale, libero, gioioso alla vita per chi nasce donna”. La famiglia allora, lo ricordo bene, era considerata ‘istituzione totale’ come il carcere, la caserma e la fabbrica. ‘La Creatura’, come ha definito tutto quel che ci sembrava reprimesse Giorgio Boatti in Sulle strade del silenzio. Tutte facce di un unico ordine tirannico. Poi forse, sperando di non vedere le trappole sparse sul nostro cammino, ci siamo addolciti, smussati. Arresi? Chissà.
C’è in Ceresa uno sperimentalismo severo che lascia ammirati, ma intimorisce. Un’astrazione della scrittura della quale si capiscono le ragioni ma che non (mi) conquista. Un eccesso di programmatico e di volontaristico nella ricerca di una ‘nuova grammatica della visione’. Un’aria austro-svizzera di glaciale nichilismo: mi viene in mente Thomas Bernhard, il Musil che fa passeggiare il suo Ulrich per il Prater senza fargli vedere gli alberi e l’erba ma soltanto i propri pensieri. E invece gli alberi e l’erba bisognerebbe guardarli.

Ernesto Ferrero, Album di famiglia. Maestri del Novecento ritratti dal vivo, Einaudi
Cesare Pavese che respinge le prose di Sibilla Aleramo già pubblicate da Mondadori e riproposte a Einaudi: “Non è nostra abitudine usare la donna d’altri”. E che malsopporta la popolarità in casa editrice dell’esibizionista seduttivo Elio Vittorini, “troppo milanese, troppo soubrette”. Giulio Einaudi che non guida, si fa scarrozzare e gira senza soldi come Gianni Agnelli (quando a spasso per Bologna acquista una giacca di cachemire e Mario Soldati gli scrocca un montone con i risvolti di pelliccia, è Nico Orengo a tirar fuori il libretto di assegni). L’amatissimo Primo Levi che inventa rebus e palindromi, Norberto Bobbio goloso di cioccolato e marmellata di fichi, Mario Rigoni Stern imbarazzato perché ha ricevuto soltanto sette copie omaggio del Sergente nella neve e non bastano per tutti i suoi fratelli. Italo Calvino che guida malissimo e quando parte alla volta di Parigi con l’auto carica di pasta De Cecco fa stare tutti in apprensione. Erich Linder, re degli agenti letterari nato a Leopoli, che ha un libro per tutti gli editori e per tutte le tasche (vero: Elvira Sellerio mi raccontò che fu lui a darle per una somma assai modesta lo svizzero Friedrich Glauser, che fu il primo bestsellerista della casa editrice palermitana con i gialli del sergente Studer prima che arrivasse Camilleri) e che soccorre i suoi autori in difficoltà (a un Mario Soldati, ancora lui, indebitato fino al collo, trova la commessa per un ‘libro da banca’ sulla Valtellina che gli frutterà cento milioni). Il saturnino Livio Garzanti che dice di se stesso: “Della cattiveria ho fatto una civetteria, dell’antipatia quasi un mestiere”. Eugenio Montale che disquisisce di cipolline e sottaceti, Giuseppe Pontiggia che ha una biblioteca di 40 mila volumi (Maurizio Cucchi, rievocandolo su Robinson, la ridimensiona a 30.500 libri). Guido Ceronetti incline a riscrivere i classici che traduce (avviene con la Storia di Roma nel Medioevo di Gregorovius, se ne accorge Giulio Bollati e Ceronetti replica: su molte cose Gregorovius non ne sa abbastanza) e che ficca una mongolfiera negli epigrammi di Marziale: gliela lasciano. I genitori di Vittorio Foa (“Due vecchini dolcissimi, sapevano di vaniglia”), Gianni Rodari a lungo ostracizzato dal Pci. Carlo Fruttero che inserisce di soppiatto un suo racconto firmato Charles F. Ostbaum (‘albero da frutto’ in tedesco) nella fortunatissima antologia di fantascienza Le meraviglie del possibile che ha curato con Franco Lucentini. Massimo Mila che s’intromette per affetto negli amori sfortunati di Pavese (“Mi dispiace vederti fare il matto e rovinarti l’anima e la salute”).
Fioccano gli aneddoti e le rievocazioni nei quarantacinque ritratti di Ernesto Ferrero ma il gossip letterario è la buccia e non la polpa di questo acuto e molto spesso commovente Album di famiglia. Dentro c’è la rievocazione di quando Torino (la Torino di via Biancamano, sede della Einaudi) era il centro della vita culturale italiana, l’orgoglio di una torinesità pudica e non compiaciuta di avere respirato l’aria dei maggiori. Ed eccoli che scorrono: su tutti, ed è giusto, Italo Calvino e Primo Levi, ma ritratti densi di penetrazione e affetto sono dedicati al generoso Vittorio Foa, a Nuto Revelli che racconta le storie dei vinti, a Rigoni Stern che è il Virgilio di Asiago, a Roberto Cerati direttore commerciale e ‘monaco trappista’ della Einaudi (l’ho conosciuto bene e l’ho avuto caro, era il padre del mio amico Federico morto giovane in un incidente), a Natalia Ginzburg che professa la religione della verità, all’inetto che sapeva fare tutto Oreste del Buono. Particolarmente intensi e colmi d’affetto i tre ritratti di scrittori morti giovani: Beppe Fenoglio, Daniele Del Giudice e il mio scontroso conterraneo Sergio Atzeni che con Bellas mariposas hascritto uno dei più bei racconti del nostro ‘900.
Ernesto Ferrero, classe 1938, einaudiano di ferro (ma ha lavorato anche per Bollati Boringhieri, Mondadori e Garzanti) e a lungo direttore del Salone del Libro di Torino, è un autore che frequento da una vita. Lo scoprii, lui giovane e io ragazzo, nel 1974 con l’incantatorio I gerghi della mala dal ‘400 a oggi (lo avevano pubblicato i benemeriti ed economici Oscar Mondadori, tra i pochi libri che allora potessi permettermi di acquistare) e mi entusiasmò con il successivo Gilles de Rais (oggi si trova nei Tascabili Einaudi) che raccontava il Barbablù francese che fu compagno d’armi di Giovanna d’Arco e seviziatore seriale di bambini. Da allora l’ho seguito nelle incursioni napoleoniche (il suo N. vinse nel 2000 lo Strega, io gli preferivo L’anno dell’indiano dedicato alla figura di un impostore americano, il sedicente capo indiano Cervo Bianco, che nel 1924 prese per il naso tutta l’Italia compresi il Papa e il Duce: Delio Tessa gli dedicò la feroce satira Alalà al pellerossa), nell’indagine sugli ultimi tragici giorni di Emilio Salgati (Disegnare il vento), negli studi su Primo Levi, nei mille interessi. Album di famiglia è un libro da amare.

Cosimo Filigheddu, La guerra di Pasca, Il Maestrale
«Il sergente maggiore Alden Mason era certo di essere nel suo buon diritto mentre stuprava la ragazzina delle pulizie. Fuori c’era il saltimbanco che mangiava le lampadine». Arriva dalla Sardegna un romanzo compiutamente romanzo, bello e importante – per scrittura avvolgente, per governo di un plot assai ricco di situazioni e personaggi – che mischia le carte tra realtà storica e finzione. Lo ha scritto Cosimo Filigheddu, a lungo capocronista della Nuova Sardegna, qui alla seconda prova narrativa, e lo pubblica Il Maestrale, la più importante delle case editrici isolane votate alla narrativa contemporanea.
Sono donne forti le protagoniste dei romanzi di Filigheddu. Lo era la Rosa del suo esordio, alle prese con le epidemie ottocentesche che colpirono Sassari (Rosa Zicchina e i suoi colera, Edes). Lo è ancor più Pasca, servetta quindicenne e orfana che vive sola in un magazzino nel quartiere popolare di San Donato – quanti ricordi: a San Donato ci abitava mio zio Giustino, io ho frequentato le elementari nel vicino Sant’Apollinare – e che per mantenersi, mentre studia per diventare maestra, durante i convulsi anni della guerra fa le pulizie dovunque la chiamino, anche in una caserma vuota. Dove un soldato americano che sta ispezionando le camerate la violenta. Pasca, che durante lo stupro è riuscita a impadronirsi della sua pistola, gli spara nelle parti basse e fugge, convinta di averlo ucciso.
Va a confidarsi con Eugenia Misuraca, moglie toscana di Angelo, il maggiore degli architetti di regime che operano a Sassari (Angelo Misuraca, 1893-1943, è figura storica e architetto di valore, basterebbe la rielaborazione del liberty con cui dà vita alla bellissima Villa Rau per dimostrarlo, e alla sua rivalutazione in anni recenti Filigheddu ha contribuito). Ed Eugenia, una delle sue molte ‘padrone’, che le vuole bene e assieme al marito avrebbe intenzione di adottarla, la nasconde in una loro casa vuota. La scomparsa di Pasca mette in agitazione altre due famiglie presso le quali la ragazza va a servizio, i Berlinguer e i Pigliaru. Così Enrico Berlinguer, qui ancora ‘sfrontato giocatore di bigliardo’, studente di giurisprudenza controvoglia e capo dei giovani comunisti che guiderà i moti per il pane del 1944 (finisce anche in carcere per qualche mese, il romanzo lo racconta) si mette a cercarla. Assieme al coetaneo Antonio Pigliaru, un orunese trapiantato a Sassari che studia lettere e filosofia, ama il jazz di cui scrive (in città suona, fra i personaggi di contorno, anche il militare di leva Ferdinando Buscaglione non ancora Fred) ed è un fascista puro di cuore, dalla parte del torto per intima coerenza (per ostinazione giovanile, verrebbe da dire), pur sapendo che tutto è perduto e pur non avendo grande consonanza con il dissolto regime.
Enrico Berlinguer è fin troppo noto a chi mi legge perché io ne dia conto. Basterà dire che qui, nella Guerra di Pasca, è personaggio sfaccettato e indagato a fondo: giovane che elabora il lutto per la perdita della madre, tardo adolescente goffo nelle faccende sentimentali, ribelle con una causa diviso fra l’amore pudico e riottoso per il padre (l’avvocato socialista e massone Mario, 1891-1969, deputato prima e dopo il fascismo) e la volontà di andare oltre l’opposizione liberal-radicale al fascismo. Merita l’attenzione di chi sardo non è, invece, la figura di Antonio Pigliaru (1922-1969), che dopo il fascismo giovanile per cui patì anche il carcere, fu uno dei nostri maggiori filosofi del diritto (La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, 1959, è un capolavoro che spiega molte cose della Sardegna), un educatore appassionato e l’animatore con Manlio Brigaglia e Giuseppe Melis Bassu di Ichnusa, la più bella e importante rivista-laboratorio del secondo ‘900 sardo.
Berlinguer e Pigliaru non sono i soli a cercare Pasca. Sulle sue tracce sono anche gli americani (il maggiore Camboni, sardo di Filadelfia che si è fatto catturare per depistare fascisti e tedeschi, convincendoli di un imminente sbarco alleato nell’isola), i carabinieri del Sim (l’irruento pugliese senza briglie capitano Milella con l’impagabile spalla del maresciallo Amoruso) e la polizia (il commissario Eugenio Colonna per il quale «lo Stato eravamo noi funzionari»). Perché Pasca, colpendo l’americano che non è morto, è entrata in una storia più grande di lei: un piano segreto che riguarda Mussolini, del quale non è lecito dire e che fa di Sassari, in quei torbidi anni di guerra civile e di confuso trapasso dei poteri, una sorta di centro del mondo. Ne uscirà bene, riuscirà a diventare maestra e direttrice didattica, dopo avere ereditato gli averi dei Misuraca.
Romanzo a molti strati, La guerra di Pasca. Affollato di personaggi che restano nella memoria: il valoroso medico d’ospedale Andrea Padula e la fumantina Suor Azzurra che apprezza il whisky, il commerciante comunista Bruno Mura, il latifondista soltanto in apparenza esangue Antonio Segni, la banda Koch di torturatori fascisti, Flaminio Mancaleoni ultimo sindaco prima del fascismo, il pescatore Millelire che odia i crucchi, il parroco della Maddalena don Salvatore Capula “confessore” di Mussolini, il soldatino Ugo Mattone futuro sceneggiatore che proprio dall’incontro con Pasca avrà l’ispirazione per lo pseudonimo con cui diventerà famoso, Ugo Pirro. E attraversato da persistenti aromi d’epoca: l’acqua che manca – a Sassari accade anche oggi – e la borsa nera, la tintura Super Iride per i tessuti e la spuma bionda, il “noiosissimo” Marino Moretti e il manuale di medicina e igiene coloniale.
Resta soprattutto, del romanzo, la capacità di rendere senza nessuna concessione al revisionismo storico la complessità di un’epoca in cui «la ragione e il torto non hanno confini così chiari». E resta l’affettuosa rievocazione di un mondo, l’orgoglio municipale privo di campanilismi che ho conosciuto e respirato e che mi è caro.

Chiara Frugoni, A letto nel Medioevo. Come e con chi, Il Mulino
Il Medioevo è il tempo dell’inverno perenne: i lupi fuori dalla porta di François Villon, la morsa del gelo che vesti e manti non riescono a scacciare. E se l’inverno come noi oggi lo conosciamo e lo pensiamo è creatura dell’800 (il tepore del salotto o del tinello, i vetri appannati, lo sci e le esplorazioni polari, il sincretismo natalizio: sull’argomento esiste un libro felicissimo di Adam Gopnik, L’invenzione dell’inverno, Guanda), la malastagione al tempo dei libri d’ore e delle miniature, delle crapule e delle penitenze è esorcizzata dalla camera da letto. Il luogo più caldo della casa, spesso l’unica stanza con un camino. La camera da letto per fare l’amore e per riposare? (Si dormiva nudi, con la berretta in testa: le vesti erano appese a un’asta, l’armadio non esisteva ancora, per tenere lontani dal giaciglio pulci e altri parassiti molesti). Non soltanto. Piuttosto una stanza “multitasking” dove studiare e lavorare, desinare e ricevere gli amici in visita, per i re un luogo dove tenere udienza.
Quanto ai letti, c’erano quelli per i ricchi (i più sontuosi erano francesi, con tanto di baldacchino e soffitto trapunto di stelle, i più solidi erano italiani) e i giacigli per i poveri, per non parlare delle stanze degli ospizi e delle locande, dove si dormiva in tre o quattro nello stesso letto (con gli scambi da pochade tra letto e letto, tra la moglie o la figlia dell’oste e il ‘galante’ di passaggio, non infrequenti nelle novelle di Boccaccio e Sacchetti) e dei separé con letto delle ‘stufe’, i bagni pubblici medievali dove si andava per lavarsi ma anche per banchettare e intrattenersi con donzelle più o meno onorate.
Nel letto si infilava spesso la Chiesa. Con i divieti alla fornicazione: una casistica pedante e sessuofobica che proibiva la copula per metà dell’anno. E con le regole infrante da chi le statuiva: nelle pagine della Frugoni c’è una processione di monaci e abati colti – e spesso messi alla gogna – mentre se la spassano sotto le lenzuola con servette e vedove. A volte si infilava anche il diavolo: per tentare eremiti e santi (Antonio, ma anche Ilarione), per generare esseri maligni anche se l’impresa non riusciva quasi mai (assai belle le pagine sul concepimento e la nascita del mago Merlino).
Chiara Frugoni, scomparsa di recente, è stata la nostra maggiore medievista. Straordinarie le sue indagini francescane (nel catalogo Einaudi) e le sue incursioni nella storia materiale dell’ “età buia”. Questo è il suo libro estremo, in perfetto equilibrio fra lievità e sapienza. Il ricco corredo di illustrazioni aiuta: non soltanto perché impreziosisce il libro, ma soprattutto perché le miniature e gli affreschi sono utilizzati come fonti che raccontano una storia, che aiutano a fare la storia.

Susan Glaspell, Una giuria di sole donne, traduzione di Roberto Serrai, Sellerio
Un racconto perfetto del 1917. In una fattoria americana, il signor Wright è morto nel suo letto, con una corda al collo. La moglie che gli dormiva accanto non si è accorta di nulla, dice che ha il sonno pesante. L’hanno arrestata che era in stato confusionale ma per poterla processare mancano le prove e non c’è un movente. Sul luogo del delitto indagano lo sceriffo Peters, il testimone Hale che per primo ha trovato il morto e il pubblico ministero Henderson. Uomini sicuri del fatto loro, che mettono a soqquadro la casa senza trovare niente. La moglie dello sceriffo e del testimone, arrivate con gli uomini per prendere degli effetti personali da portare alla carcerata – Minnie, che una volta era piena di vita e cantava nel coro – , si fermano in cucina e fanno qualche commento su quel che vedono. E gli uomini a deriderle: di fronte a un omicidio sono capaci di pensare solo a cose di donne. Gli uomini cercano invano, le donne senza volere fanno la vera indagine: una coperta a parchwork cucita male in un punto, la stufa della casa in pessime condizioni, un uccellino morto con il collo spezzato. Indizi di solitudine, disagio, tirannia maschile, che spariranno perché le accuse non si concretizzino. Un poliziesco sui generis, non si fa peccato a spoilerarlo perché non è un enigma ma uno spaccato acuto sull’infelicità femminile e domestica e sulla solidarietà fra ‘sorelle’, che verrà riscoperto negli anni ‘70 dagli studi sulla letteratura delle donne. Susan Glaspell (1876-1948) è stata la maggiore drammaturga americana del ‘900 e nel 1931 vinse il Pulitzer per il teatro. Nota introduttiva di Alicia Giménez-Bartlett e postfazione di Gianfranca Balestra.

Élisabeth Jammes/ Étienne Pihouée, Manuale di eleganza per il perfetto gentiluomo, il Saggiatore
Serve un manuale per essere comme il faut? Può darsi di sì, vedete voi. Questo è formale e molto, forse troppo, francese. Assai gradevole nelle illustrazioni ma più che tradizionale nel gusto, pignolo fino all’ovvietà e un filo irritante nei consigli (lavarsi la faccia con l’acqua tiepida, evitare le pozzanghere: ci arriviamo da soli). Prescrive sempre l’abito, suggerisce di averne tre nell’armadio e ai creativi raccomanda di non fare gli stravaganti (“Siete lì per lavorare”). Lo spezzato viene buono soltanto per le occasioni informali, la giacca meglio se in tweed, neanche dovessimo uscire in brughiera per una battuta di caccia alla volpe. Gli autori si soffermano sui dettagli (i revers, la taglia giusta, l’orlo dei pantaloni), sulle tessiture della camicia (popeline, oxford, twill ecc), sulle scarpe (possibile che non ci sia vita oltre francesine, derby, brogue e monk?), sul nodo alla cravatta, al papillon e alla sciarpa, sui gemelli e sull’orrido fermacravatta, sui cappelli. Tra consigli utili (evitare il ton sur ton, cravatta più scura della camicia ma dovrebbe essere intuitivo, massimo tre colori in tutto l’abbigliamento, come stirare un camicia e come togliere le macchie), occasioni abiti e accessori speciali, non è raro sconfinare nell’opinabile (se a un colloquio di lavoro mi si presenta uno in abito blu scuro o grigio, camicia bianca, cravatta scura, cintura calze e scarpe nere, cartella e in bocca una mentina, non lo assumo per principio). E fare cadute di stile come quella di mettere le scarpe nell’armadio assieme agli abiti, che orrore. Sciatteria tutta editoriale invece quella di offrire quasi soltanto negozi francesi nella rubrica finale sul dove acquistare: e un indirizzario italiano no?

Joseph Pontus, Alla linea, traduzione di Ileana Zagaglia, Bompiani, 2022
In fabbrica canti
Cazzo se canti
Canticchi mentalmente
Urli a squarciagola coperto dal rumore delle macchine
Fischietti la stessa melodia ossessionante per due ore
Ti gira in testa la stessa canzone idiota sentita alla radio la mattina
È il più bel passatempo che ci sia
E ti aiuta a resistere
Pensare ad altro
Alle parole dimenticate
E a stare allegro
Quando non so cosa cantare
Torno ai fondamentali
L’Internazionale
Les temps des cerises
La semaine sanglante
Trenet
Sempre Trenet e ancora
Il grande Charles “senza il quale saremmo tutti contabili” come diceva Brel
Trenet che porta gioia in questo cazzo di mattatoio…
La vita in fabbrica in Bretagna, turni di notte, in un primo impiego a pulire e confezionare gamberetti e crostacei e fare bastoncini di pesce, poi a trasportare quarti di manzo, buttare via gli scarti, fare i conti con teste corna sangue e frattaglie. Lavoro interinale, senza la certezza che duri ancora una settimana, ancora un mese. Con una laurea in letteratura che non serve a niente, con un lavoro di educatore nella periferia di Parigi alle spalle. È il potente, lirico, brutale e gioioso Alla linea di Joseph Pontus (pseudonimo di Baptiste Cornet, 1978-2021), caso letterario in Francia, che fa della fabbrica il luogo della fatica e dell’orrore, dell’identità e dello splendore: paradiso e veleno. Un approccio non vittimistico, un inno alla vita e alla dignità, prosa ritmata come un unico ininterrotto canto (c’era una volta il prosimetro, la Vita nova di Dante: che sia questa la vita nuova di oggi, in tempi di fine del lavoro come dignità e riscatto?) e intervallata da citazioni di Apollinaire e Beckett, Thierry Metz (altro campione della letteratura working class con il Diario di un manovale) e Braudel, La Bruyere e Baudelaire, Barbara e Vanessa Paradis.
Mi viene in mente che si cantava anche in Tuta blu. Ire, ricordi e sogni di un operaio del Sud di Tommaso Di Ciaula, 1978, pubblicato nella collana Franchi Narratori di Feltrinelli, la stessa di Padre padrone, e oggi riproposto da Alegre: «Certe volte sul lavoro canticchiamo per tenerci allegri. Non per allegria, ma per rabbia, come dice la famosa favola dell’uccello in gabbia. Altre volte cantiamo a squarciagola, almeno per sovrastare il rumore infernale delle macchine. Si canta di tutto: stornelli piccanti, canzoni strappacore napoletane, Bandiera rossa, ma quest’ultima, almeno per quanto mi riguarda, con poca convinzione, negliultimi tempi». Cantare – e scrivere – per resistere, per puntellare un’identità working class sempre più precaria e rimossa. Per raccontarsi, per esistere.
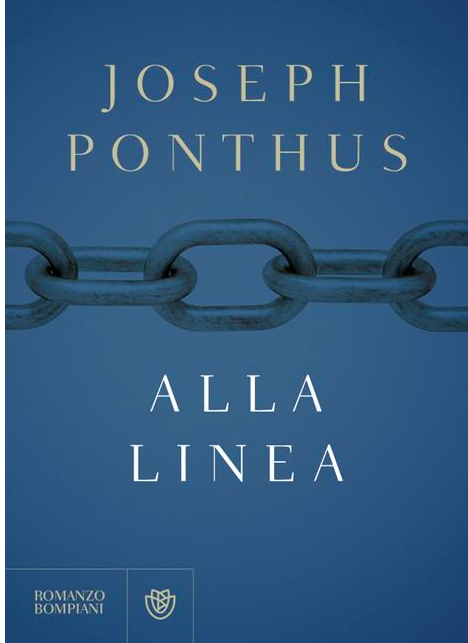
Mariano Sabatini, Ma che belle parole! Luciano Rispoli, Vallecchi
La buona tv di una volta, garbata (termine che Rispoli non amava) o, meglio, civile e rispettosa. Che educava intrattenendo, che intratteneva facendo cultura. Ci sono affetto, lealtà e pignoleria (il biografato avrebbe apprezzato) in questa biografia che Mariano Sabatini, per vent’anni collaboratore di Luciano Rispoli, ha dedicato a uno dei creatori, mai dimenticato e al tempo stesso mai valutato come meritava, della radio e della tv moderna. Ne emerge il ritratto di un uomo perbene ma ruvido, spesso iracondo nel lavoro: un inflessibile poco propenso ai compromessi, più che un caratteriale. Però pacato, posato con gli ospiti, capace di temperarne le irruenze e gli eccessi di ego. Calabrese di Reggio, figlio di un militare deportato dai tedeschi, un fratello partigiano torturato e ucciso a Bologna, il futuro ideatore e conduttore di Parola mia entra alla Rai nel 1954, provinato da Vittorio Veltroni padre di Walter. Lo mandano in giro per l’Italia con le Radiosquadre, a stimolare il pubblico locale, e poi valorizzano la sua vocazione a educare in radio (La radio per la scuola, che aiuta gli studenti in difficoltà) e in tv (Telescuola). Il grande successo, la popolarità che non lo abbandonerà più arriva nel 1985 con Parola mia, fortunato e ancora ricordato quiz sulla lingua italiana che ha come giudice di gara il linguista Gian Luigi Beccaria (“Ma che belle parole!”, ormai frase idiomatica, è l’intercalare dell’ammirato conduttore di fronte alla sapienza lessicale del professore). Ma prima Luciano Rispoli ha inventato tanto, tantissimo. Programmi che restano nella memoria, in radio (Bandiera gialla, Gran varietà, La corrida sui cui fasti un irriconoscente Corrado camperà a vita, Chiamate Roma 3131 che rende gli ascoltatori al telefono per la prima volta protagonisti) e sul piccolo schermo (L’ospite delle 2, 1975, che inaugura la stagione dei talk show con un anno di anticipo sul Maurizio Costanzo di Bontà loro; Pranzo in tv, 1983, che introduce il dinner show, Tappeto volante per Tmc). Molte sono le stelle di prima grandezza che con Rispoli hanno esordito: Maurizio Costanzo, Paolo Villaggio, Gianni Boncompagni, Paolo Limiti, Raffaella Carrà, e l’elenco potrebbe proseguire. Una biografia che, frugando dietro le quinte e percorrendo i sessant’anni di carriera di Rispoli, riesce a raccontare nel dettaglio un pezzo di storia della tv, un tratto di storia del costume italiano.

I RECUPERI
Hans Magnus Enzensberger, La fine del Titanic, traduzione di Vittoria Alliata, Einaudi, 1980
Lo scorso 24 novembre è morto Hans Magnus Enzensberger, poeta tedesco e molto altro, a me particolarmente caro. Avevo cominciato a leggerlo a Sassari, ragazzo: il suo primo libro di versi (Poesie per chi non legge poesia, Feltrinelli, 1957, tradotto da Ruth Leiser e Franco Fortini) me l’aveva passato un amico di allora, il poeta Antonio Marras. Così ho prelevato dai miei scaffali il poemetto Titanic. Vorrei riprendere in mano anche Palaver, uno svelto e denso libro di interventi politici in cui dava della “turista della rivoluzione” a Maria Antonietta Macciocchi, giusto per risarcirmi delle insistenze della suddetta che negli anni ‘90, rimbalzata con garbo dal Corriere, cercava di farsi pubblicare dall’allegato di cui ero caporedattore delle articolesse di quindici cartelle sull’incolpevole Eleonora Fonseca Pimentel (“A signora donna Lionora/ che cantava ‘ncopp’ ‘o triato/ mo abballa mmiez’ ‘o mercato” del Canto dei sanfedisti). Comunque, ecco La fine del Titanic, più che mai attuale nei tempi odierni di harakiri della sinistra. La rilettura è di adesso, la recensione del 2010.
La fine del progresso, le illusioni perdute. E la fine del mondo che arriva «un po’ per volta, a rate, a pezzi e bocconi, in tempi e luoghi diversi», come scrive nell’introduzione Cesare Cases echeggiando lo stesso Enzensberger. In un poemetto di potente afflato lirico e visionario che fonde materiali, linguaggi, timbri. Che alterna descrizione secca, sarcasmo, rimpianto e rendiconto, rievocazione commossa, invettiva e inventario notarile. Che ammassa i materiali come relitti di un naufragio, appunto.
La prima stesura di La fine del Titanic il poeta tedesco la compose all’Avana, nel 1969, spettatore appassionato del socialismo tropicale, mentre cominciava a vedere le crepe dell’esperimento castrista e la partecipazione trascolorava in amarezza e desencanto.
A quei tempi all’Avana si sfaldava l’intonaco
delle case, nel porto sostava immobile
un putrido fetore, rigoglioso avvizziva il passato,
la miseria rosicchiava notte e giorno
smaniosa il piano decennale,
ed io scrivevo della “Fine del Titanic”.
Scarpe non ce n’erano e niente giocattoli,
niente lampadine e niente tranquillità,
la tranquillità poi non c’era proprio, e i mormorii
erano come zanzare. Allora tutti pensavamo:
domani andrà tutto meglio, e se non
domani, sarà dopodomani. Be’ –
forse non non proprio meglio,
ma comunque diversamente, del tutto
diversamente, in ogni caso. Sarà tutto diverso.
Una sensazione meravigliosa. Me lo ricordo.
(…)
Ed io ero distratto e posai lo sguardo
oltre il muro del porto, sul Mar dei Caraibi,
ed è lì che lo vidi, molto più grande
e più bianco del bianco, fuori, al largo,
lo vidi solo io e nessun altro,
nella rada buia, la notte era limpida
e il mare nero e liscio come uno specchio,
e lì vidi l’iceberg, assurdamente alto
e freddo, come una fredda Fata Morgana,
avanzare lento, inesorabile,
bianco, su di me.
Enzensberger come il capitano del transatlantico inaffondabile, che vede andare a picco le sue certezze. Quella prima stesura del poemetto, scritta su un quaderno con la copertina in tela cerata e inviata a Parigi con la posta, si perde. La stesura ricomincia, e si completa, a Berlino nel 1977, prima che Berlino diveti cool. E si fa riflessione sulla memoria e sul fare artistico, sul divenire dell’atto artistico (i suggestivi interludi dedicati a quadri anonimi di veneziani, umbri, fiamminghi). Bilancio in cui esperienza personale e memoria del secolo agli sgoccioli coincidono.
Così scrivo a Berlino. Come Berlino
io odoro di bossoli vecchi,
d’Europa orientale, di zolfo, di disinfettante.
Lentamente torna adesso a far freddo.
Attentamente io leggo le ordinanze.
Lontano, al di là d’innumerevoli cinematografi,
si erge inavvertito il muro, dietro al quale,
lontani gli uni dagli altri, si ergono qua e là dei cinematografi.
Con scarpe nuove di zecca vedo stranieri
qua e là disertare attraverso la neve.
Sto morendo di freddo. Ricordo, quasi
da non crederci, sono passati meno di dieci anni,
i giorni stranamente spensierati dell’euforia.
La sorte della nave e dei suoi passeggeri come potente allegoria del ‘900, dove lo splendore della tecnologia e le istanze di liberazione dell’uomo vanno incontro al medesimo naufragio. Dal quale emergono
rottami, frammenti di frasi,
cassette vuote, grosse buste commerciali,
bruni, fradici, rosicchiati dal sale,
estraggo dai flutti dei versi,
dai cupi, caldi flutti
del mar dei Caraibi,
dove pullulano gli squali,
versi esplosi, salvagenti,
vorticosi souvenirs.
