Tanta Italia – di ieri, di oggi e dell’altro ieri – e tanti autori italiani, ma anche recuperi, Rilke in doppia versione, letteratura straniera di pregio, senza dimenticare qualche chicca nella puntata di febbraio di proposte di lettura
Mi ritrovo, dopo quasi un anno di letture per così dire obbligate, “di lavoro”, con una montagna di arretrati che sarà piacevole smaltire. Comincio questo mese con Roberto Alajmo, Julian Barnes, Michael Bible, Jan Brokken, Paolo Cognetti, Enrico Deaglio, Abbott Joseph Liebling, Alessandro Marzo Magno, Patrick Modiano, Emanuele Trevi e Stefan Zweig. E con un recupero, le Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke.
Roberto Alajmo, Abbecedario siciliano, Sellerio, 2023

Pochi camillerismi. Assuppaviddani, la pioggerella “inzuppavillano” incessante ma troppo lieve perché i braccianti possano permettersi di abbandonare la campagna; i notissimi cabbasìsi che è meglio non rompere; a tinghitè, a bizzeffe, che a Palermo dicono a tignitè. Per il resto vocaboli ingegnosi e barocchi, sfumature che la lingua non possiede. Per fare un esempio, i termini che designano il mangione, quello che si abbuffa (lapardèo, manciatàro, sbutriàto), memoria dell’antica fame contadina. Una consuetudine con la tragedia che porta alternativamente a esagerare l’accaduto (s’ammazzò, di bambino che si è sbucciato il ginocchio) e a sminuirlo: fuitina per rapimento, ammazzatina per omicidio, feritina per coltellata. Ancor più numerose le parole dialettali dedicate al tirarsi indietro, al non esporsi, al dire e non dire, privilegiando la vaghezza. Il capolavoro, ai miei occhi, è almèno: dipende, se dio vuole, «una sorta di equivalente laico dell’arabo inshallah» chiosa Alajmo. E racconta l’aneddoto quasi metafisico del cittadino che, non fidandosi delle informazioni accattate online, telefona al museo: «Oggi pomeriggio siete aperti?». E il centralinista: «Almèno», dipende. «Dipendeva dalla disponibilità del personale del museo, che veniva verificata di giorno in giorno». Repertorio prezioso, l’abbecedario di Alajmo regala un asciutto umorismo e nasconde (neanche troppo) un malinconico disincanto.
Julian Barnes, Elizabeth Finch, trad. Susanna Basso, Einaudi, 2023

Un’insegnante che ti allena al libero pensiero, chi non la vorrebbe? L’io narrante Neil – due matrimoni andati a monte e una serie di lavori intrapresi e abbandonati, dall’attore al cameriere al coltivatore di pomodori idroponici – se la trova all’università dove si è iscritto assieme a un gruppo di trenta-quarantenni, che insegna “cultura e civiltà”. Si chiama Elizabeth Finch, è imperturbabile e gentile senza fare concessioni, non prescrive letture e non chiede nozioni, dice che non li vuole trattare come “oche all’ingrasso”. Sobria nel vestire, fumatrice imperterrita e abituata a pensare “in direzione ostinata e contraria”, EF come la chiamano gli allievi è donna misteriosa: una parete liscia che non offre appigli, in apparenza senza amicizie amori famiglia. Alcuni allievi sono diffidenti, altri ne restano sedotti, Neil è tra questi. La frequenterà fino alla morte – pranzi in un ristorante italiano tre quattro volte all’anno, paga lei – in una singolare intimità tutta di testa ma priva di confidenze, e riceverà in eredità la sua biblioteca e le sue carte. Alle prese con gli appunti e gli aforismi che lo hanno affascinato alle lezioni, il “re dei progetti incompiuti” Neil scriverà il libro che forse lei avrebbe voluto scrivere: la storia di Giuliano l’Apostata, l’imperatore che cercò di restaurare il paganesimo e venne sconfitto. Se avesse vinto, sosteneva EF, il corso della storia sarebbe cambiato in meglio, chissà: senz’altro non avrebbe vinto un monoteismo fanatico e basato sulla mortificazione, sulla negazione del qui e ora (della vita) perché la vera vita comincia dopo la morte. Nessuna parola che comincia con mono-, a parte monorotaia, diceva EF, promette niente di buono. Conclusa l’opera, Neil riprende a cercare tracce di lei, mission impossible, per scoprire che nessun aneddoto, nessuna storia prende corpo: la ricorderà come l’ha conosciuta, punto e basta. Julian Barnes è tra i pochi grandi scrittori dei nostri anni ma Elizabeth Finch è opera non troppo riuscita: la zavorrano i buchi del plot e la salvano lo stile come sempre impareggiabile e lo scintillio dell’intelligenza. Ma qui gli aforismi di EF, che parlino degli stoici o dell’amore, del “legno storto dell’umanità” o di Swinburne, che critichino l’imperfezione della creazione o capovolgano l’incipit di Anna Karenina, quello in cui tutte le famiglie sono felici nello stesso modo, sembrano puri giochi di prestigio. La tripartizione del libro – Neil ed EF, la storia di Giuliano, Neil dopo EF – è appesantita dalla vita dell’imperatore. Barnes è penetrante narratore di “uomini pubblici”: ne ha dato prova con Flaubert, con Shostakhovic. Qui, mettendosi nei panni dell’allievo curioso e autodidatta, compila forse per mimesi di una midcult che cerca di volare – troppa sottigliezza, se è così – una voce quasi da Wikipedia. Per inciso, la voce che Wikipedia dedica a Giuliano è ottima, e contiene anche tutto quel che si trova in Barnes. Da annotare, en passant, che Elizabeth Finch è l’ultimo frutto della fascinazione che gli scrittori inglesi – da James Hilton a Christopher Isherwood, da Muriel Spark ad Alan Bennett a Ian McEwan – provano per gli insegnanti.
Michael Bible, L’ultima cosa bella sulla faccia della terra, trad. Martina Testa, Adelphi, 2023

«Volevo vedere cadere quell’ultima fioritura. Sentivo uno strano legame. Come se fosse l’ultima cosa bella sulla faccia della terra». La fioritura del corniolo Iggy la vede dalla finestrella di una cella. È condannato a morte, aspetta l’iniezione letale. Diciott’anni prima è entrato nella chiesa battista di Harmony, una cittadina senza storia del Sud, con una tanica di benzina in mano. Voleva darsi fuoco come i bonzi ma la benzina ha impregnato il pavimento di legno e il fiammifero gli è sfuggito di mano, nell’incendio sono morti in venticinque ma non lui, il paese si troverà a elaborare un lutto che non se ne va. Un’opera prima di buon ritmo e frasi secche: ma le quattro storie che lo compongono sono un po’ sfilacciate, Iggy avrebbe meritato un rilievo maggiore. Destino ineluttabile ed echi biblici, vite risucchiate dal vuoto e dalla dissipazione, dolore desolazione e fuga. Modelli irraggiungibili William Faulkner e Flannery O’Connor, ma anche così niente male. Bella traduzione di Martina Testa, ma “l’autorevolezza veterotestamentaria” con cui cade la pioggia si poteva evitare.
Jan Brokken, La suite di Giava, trad. Claudia Cozzi, Iperborea, 2023
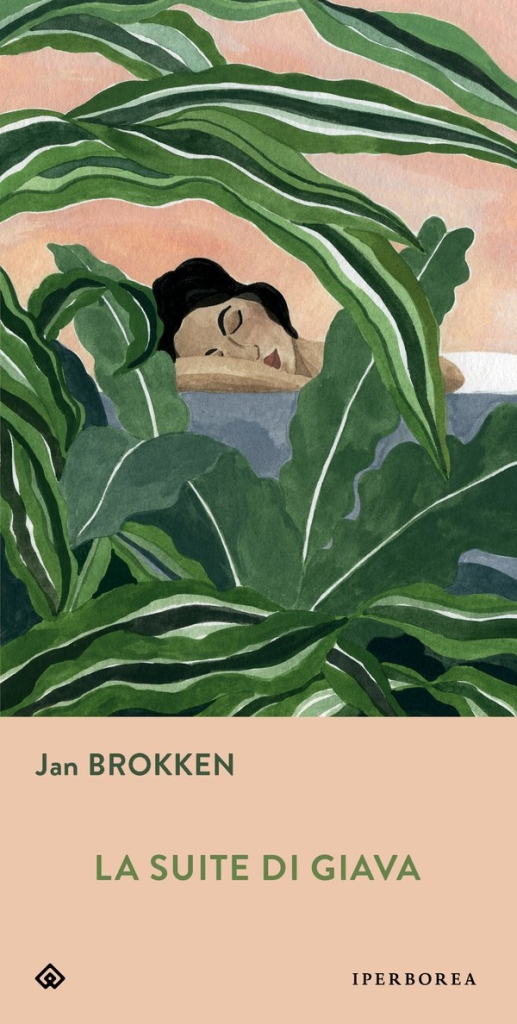
La scoperta della madre, la scoperta di un mondo. Un’indagine sul conoscere, sull’entrare nello specchio dell’altro, sul vedere oltre il guardare. Su quanto poco sappiamo delle persone a noi più vicine, che abbiamo cristallizzato in un ruolo, in una fase della vita, in una sconfitta. L’olandese Jan Brooken, tra gli scrittori che più amo, è nato nel 1949. Quattro anni dopo che la madre Olga e il padre Han sono tornati dall’Indonesia dove hanno vissuto dal 1935, conoscendo la felicità della giovane coppia, l’impulso a esplorare quel mondo vivace e ricco di idiomi e sfumature, quella natura che stordisce. Han è pastore protestante, incaricato di studiare la religiosità locale: animisti, musulmani, transfughi da una religione all’altra spesso per motivi più che terreni: l’islam è religione dell’élite feudale indonesiana, fondamento dello schiavismo, chi si fa cristiano scansa le corvée. E capaci di sviluppare un sincretismo che impasta le credenze (belle le pagine sul viaggio alla Mecca come truffa e malaffare). Missionari, rabdomanti senza l’altezzosità e la boria degli europei, Olga e Han. Lei soprattutto, autodidatta curiosa di tutto, tempra gioiosa e intrepida, intelligenza vivace e ricca di intuizioni profonde. Pronta a imparare a leggere e scrivere molte delle lingue locali – l’Indonesia ne possiede tuttora oltre settecento – come a suonare il pianoforte e l’organo, ad andare a cavallo, a cucirsi gli abiti a macchina insegnando quell’abilità anche alle giovani indonesiane. La stagione incantata ha fine nel 1942 con la guerra, l’occupazione giapponese e il campo di prigionia: in quello maschile Han, in quello femminile Olga con due figli di pochi anni. Separati per tre anni, riuniti e prossimi al rientro quando hanno perso tutto sprofondando nella povertà. È questa la cesura tra il prima e il dopo, fra la gloria della giovinezza e l’accettazione – stoica e senza recriminazioni, ma in qualche modo “spenta”, consegnata alla sordina quando non al silenzio – della sconfitta, del niente sarà più come prima. Brokken, per stendere questo memoir che mi regala una “malinconia presa in prestito”, è partito da un fascio di lettere che la giovane madre spediva dalle Indie alla sorella Nora in Olanda. E da un brano per pianoforte, I giardini di Buiterzorg, parte di una Javanese suite. La compose il lituano americanizzato Leopol’d Godovskij affascinato dalla “gamelan music” che tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 sedusse anche Saint-Saens, Debussy e Ravel. Bel personaggio, Godovskij: ebreo e autodidatta, enfant prodige sfruttato dal padre come una bestiolina ammaestrata, concertista riluttante ma prodigioso – Rubinstein disse che gli sarebbero occorsi 500 anni per possedere la sua tecnica – e rielaboratore di partiture altrui, soprattutto Chopin, che arricchiva di cromatismi e complicazioni esecutive da virtuoso. Sono andato su YouTube a sentire I giardini di Buiterzorg, suonato dallo stesso Godovskij negli anni ‘30. E su Spotify ho trovato un Godovskij in Asia con la Suite di Giava eseguita da una brava pianista filippina dal bizzarro nome Charisse Baldoria. I giardini di Buiterzorg che oggi si chiama Bogor, con le sue oltre mille varietà di palme, Olga li ha conosciuti bene, nel suo primo anno di soggiorno a Giava. Chissà se ha conosciuto anche la musica di Godovskij e dell’altro musicista abbagliato da quelle sonorità, il tedesco-olandese Paul J. Seelig dal quale acquistava gli spartiti da suonare a casa o in chiesa (di Seelig si trova qualche fascinoso frammento su YouTube). Senz’altro ha conosciuto la pianista Lili Kraus, sua compagna nel campo di prigionia giapponese, “che suonava Schubert come nessun altro”: di lei c’è molto, anche Schubert, su Spotify, sarà fra le mie prossime esplorazioni. Nei libri di Brooken capita di incontrare musicisti non troppo noti: il russo espatriato Yuri Egorian, i baltici Ciurlionis e Vasks, il catalano Mompou. Sono incontri preziosi. Come lo sono quelli dei guru indonesiani, degli studiosi olandesi, dei compositori che affollano queste pagine: viaggiatori curiosi che percorrono il mondo per impregnarsene e non per conquistarlo. Conoscere il mondo, mettere a fuoco chi ti sta vicino: nell’asciuttamente commovente altare per la madre che è La suite di Giava c’è tutto questo.
Ps. Ho la curiosa impressione che i libri che leggo si parlino tra loro. Qui uno dei grandi edificatori di Buiterzorg, giardino botanico tra i più importanti d’Asia, ha per cognome Blume, fiore. Come Anna, moglie adorata e rimpianta del Baumgartner di Paul Auster.
Paolo Cognetti, Giù nella valle, Einaudi, 2023

Due fratelli. Luigi e Alfredo. La guardia forestale e lo sbandato. Il maggiore e il minore. Il larice e l’abete, come gli alberi che il padre ha piantato per loro quando sono nati. Li divide carattere e sorte, li unisce l’alcool. Beveva il padre invecchiato precocemente – si è ucciso sparandosi con il fucile quando gli hanno diagnosticato un tumore – al quale la nuora annacquava di nascosto la grappa. Bevono per giorni, al bancone di un bar, i due fratelli quando si ritrovano. Luigi si è sposato con Betta, ragazza di città che per lui si è trasferita in montagna, aspettano una figlia. Dopo una falegnameria presto chiusa perché era bravo con il legno e non con i conti, ha trovato impiego fisso da “sbirro”. A sorvegliare fauna e boschi, indagare da dove arriva l’inquinamento che avvelena il Sesia, cercare la bestia – forse un cane, forse un lupo – che in poco tempo ha ucciso dieci cani. Fredo invece, uscito di galera dopo una rissa, se n’è scappato lontano, in Canada, a fare il taglialegna. Ed è tornato per vendere al fratello la sua metà della casa paterna. In un dialogo di detti e non detti, fra una birra mischiata al whisky, il lupo-abete Fredo rimprovera al larice-cane Luigi di essere un fasullo che famiglia e lavoro hanno smidollato, mentre lui è rimasto quello vero e, insieme, quello sbagliato. Luigi lo sta imbrogliando, sospetta, ma fa niente: forse acquista la sua quota di casa per farci una speculazione, fra un po’ da quelle parti costruiranno un impianto di risalita. Una sera al bar Fredo apre la testa con l’accetta a un compagno di bevute molesto. Scappa in moto inseguito con i lampeggianti da Luigi, prenderà il volo senza che il fratello buono riesca a fermarlo. Una Valsesia come le badlands americane, natura sotto assedio e capannoni, balere e bar che sembrano discariche della città. Usando Raymond Carver e soprattutto lo Springsteen di Nebraska e dintorni come fonte di ispirazione dichiarata (Highway patrolman, The mansion on the hill, The river), Cognetti ne cava un piccolo capolavoro terso e polito, senza una parola né di troppo né fuori posto.
Enrico Deaglio, C’era una volta in Italia. Gli anni Sessanta, Feltrinelli, 2023

Impresa titanica, un libro di seicento pagine di formato grande zeppo di rievocazioni e immagini e allestito in meno di un anno, per fortuna c’era il fieno in cascina della trilogia Patria. Qui il passo muta: meno “dispaccio” e più narrazione a tutto tondo, viene da dire più “ricerca del tempo perduto”. Le deliziose storie futili e le molte pagine nere, i tintinnii di manette e la bomba che nel 1969 mandò in frantumi tutto, anche la nostra innocenza. Tra le perle, ma tutto merita: il filarino che non ci fu tra Livio Berruti e la “gazzella nera” Wilma Rudolph, Giovanni Gronchi democristiano “dalla cintura in su”, Palma di Montechiaro patria della povertà (e dei Tomasi di Lampedusa), la fine del mondo farlocca del luglio 1961, Kerouac in Italia sfasato e sbronzo, i peli pubici di Tamara Baroni allegati a una rivista, Ian Fleming e Raymond Chandler che intervistano Lucky Luciano, la vita vera e ignobile di Generoso Pope, la riabilitazione di Fiorentino Sullo, il vaccino antipolio nello zuccherino, il monocolo del generale De Lorenzo, i beat e Barbonia City, lo scandalo della Zanzara, il ricordo commosso e memorabile di Gigi Meroni. Il libro di Deaglio con Ivan Carozzi per i più giovani sarà scoperta, per chi ha la mia età è insieme rammemorazione e ripasso. Che cuce assieme cronache distese, brani famosi o che meritavano di esserlo, elenchi nei quali immergersi con gusto: chi firmò per Pinelli, chi fu fermato dalla polizia durante le occupazioni studentesche di Pisa Torino e Trento, gli olivettiani che sarebbero diventati famosi, gli “angeli del fango” accorsi a Firenze colpita dall’alluvione del 1966, il who’s who del Gruppo 63 e dei basagliani, i partecipanti del convegno al Parco dei Principi a Roma che nel 1965 diede il via alla strategia della tensione (c’era, assieme a molti fascisti che avremmo imparato a conoscere, anche Renato Mieli ex direttore dell’Unità e padre di Paolo). Seguo Enrico Deaglio da quando raccontò la storia di Giorgio Perlasca, lo Schindler italiano (il libro era La banalità del bene), sono stato un lettore fedele e felice di Diario e ho molti amici tra gli ex redattori e collaboratori di quell’ancora rimpianto settimanale, a suo tempo ho intervistato per il suo Reporter Bartezzaghi padre, il mitico inventore del cruciverba più difficile della Settimana enigmistica. E attendo di tuffarmi nella prossima puntata di C’era una volta. Intanto, è stato il mio regalo di Natale per amici e familiari.
Abbott Joseph Liebling, Tra i pasti. Un appetito per Parigi, trad. Katia Bagnoli, Settecolori, 2023
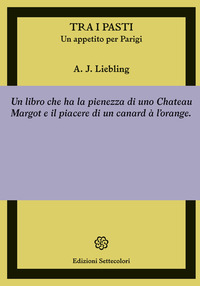
«Mens sana in corpore sano è una contraddizione in termini, la fantasia di qualcuno che vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Nessuna persona sana di mente può permettersi di rinunciare a piaceri debilitanti; nessun asceta può considerarsi attendibilmente sano di mente. Hitler era l’archetipo dell’astemio. Quando gli altri crucchi lo videro bere acqua in birreria avrebbero dovuto capire che c’era poco da fidarsi». Il mondo visto da un ghiottone, ce n’è anche per Proust. «Larousse definisce (la madeleine, ndr) “un biscottino dolce e leggero fatto con zucchero, farina, succo di limone, brandy e uova”. (La quantità di brandy contenuta in una madeleine non basterebbe a ubriacare un moscerino). Considerato quanto Proust scrisse grazie a uno stimolo così blando, è una vera perdita per l’umanità che non abbia avuto un appetito più vigoroso». Abbott Joseph Liebling (1904-1963), firma illustre del New Yorker, racconta il suo apprendistato ai piaceri della tavola nella Parigi degli anni ‘20. Americano in sabbatico in anni di lost generation, non frequenta gli scrittori e i pittori – si vanta di non avere conosciuto Gertrude Stein, di avere letto l’Ulisse senza che gli venisse voglia di incontrare Joyce – preferendo loro osti e camerieri. È uomo di appetiti ribusti: «Personalmente mi piacciono i sapori decisi, che sanno il fatto loro. Il motivo per cui le persone che detestano il pesce spesso tollerano la sogliola è che la sogliola non sa molto di pesce, e anche questo grado di somiglianza scompare quando viene immersa nel tipo di salsa che gli avventori dei ristoranti piemontesi di Londra e New York ritengono tipicamente francese… Preferiscono il formaggio fuso perché non è saporito e l’estratto di vaniglia artificiale perché non è vanigliato. Hanno fatto della mela Delizia un successo trionfale perché non sa di mela, e idem della Golden perché non sa di niente». Questo memoir di apprendista ghiottone – Liebling detesta la parola gourmet – è un omaggio alla Parigi della giovinezza, centro del mondo e città per tutte le tasche, di ristoranti con il menù scritto sulla lavagna d’ardesia e di piatti robusti e concreti. Scintillante nello stile, ricco di “cose viste”, Tra i pasti merita – lo scrive James Salter, e ha ragione – di trovare un posto tra gli scaffali della nostra libreria accanto a Festa mobile di Hemingway.
Alessandro Marzo Magno, Casanova, Laterza, 2023

«Mi è sempre piaciuto andare per strade traverse e ho sempre vissuto nell’errore con l’unico scopo di sapere che mi ci trovavo. Vizio non è sinonimo di delitto, perché si può essere viziosi senza essere criminali. Tale sono stato io durante tutta la mia vita». Giacomo Casanova il vizioso, veneziano, 1725-1798, seduttore e avventuriero, in una biografia divertita e minuziosa – Marzo Magno ha persino accertato se le locande e gli alberghi in cui il nostro ha soggiornato esistono ancora – che ne passa in rassegna le molteplici sfaccettature e attività. Seduttore meno di quanto si creda, Casanova: a fargli i conti a letto, all’incirca due donne all’anno, il Don Giovanni che “in Ispagna son già mille e tre” è confronto impossibile. Però in compenso amante generoso con le popolane, scroccone con le ricche, seduttivo sempre e “innamorato”, se non nell’accezione romantica che forse ancora resiste, senz’altro in quella di “curioso delle donne”, che corteggia e stima. Tempi lontani e diversi i suoi: fra le prede anche ragazzine appena puberi e forse neanche, ma allora l’età canonica per il matrimonio era fissata a dodici anni. Anche figlie naturali godute assieme alle madri: letto oggi se ne ha orrore ma leggere di storia è accertare, se non accettare, distanze. Casanova amante dei “sapori forti”, viaggiatore che non si accorge dei luoghi che attraversa e delle città a cui approda – ma il paesaggio è invenzione romantica –, interessato più alle persone a cui si presenterà, in cerca di mecenati che lo soccorrano e di polli da spennare: è giocatore e baro, se ne vanta. Agente segreto e spione per conto della Repubblica veneziana da cui è scappato – la famosa evasione dai Piombi – che lo utilizza a Trieste e, dopo il salvacondotto che gli permette di ritornare in patria, tra i “viziosi” e gli anticonformisti della città, che non si fa scrupolo di denunciare simulando virtù. Che altro? Letterato e poligrafo o meglio grafomane – ma le Memorie sono considerate da molti la scaturigine del romanzo moderno – che si stampa da sé le opere che partorisce, riducendosi in bolletta. Conversatore che dicono logorroico, gabbatore di nobili: si vanta “cavaliere di Seingalt” lui che è figlio di un’attrice. Improbabile mago e cabalista che prosciuga le sostanze di Madame d’Urfè, massone in cerca di “buone relazioni” non diversamente dagli iscritti alla P2, amico di Lorenzo Da Ponte e contributore con qualche verso del libretto del Don Giovanni. Essere avventurieri, nel ‘700 dei lumi e di un ancién regime che viveva gli ultimi splendori prima del tramonto – vale anche per l’oligarchia che Marzo Magno ha già raccontato nei due libri su Venezia – è scorciatoia alla mobilità sociale per i giovani d’ingegno ma non di nobili lombi. La sua avventura finisce in Boemia, a Dux dov’è bibliotecario dei Waldstein, in una vecchiaia rancorosa e scrittoria dov’è ricondotto al rango di servo e schernito dagli altri servi. Dal 1820, quando in Germania vengono pubblicate edulcorate e postume le Memorie, comincia il mito.
Patrick Modiano, La strada per Chevreuse, trad. Emanuelle Caillat, Einaudi, 2023

«In quale circostanze aveva conosciuto Camille detta Teschio? In cinquant’anni non se lo era mai chiesto. Il tempo man mano aveva cancellato i vari periodi della sua vita, e nessuno era legato a quello successivo, tanto che la vita era stata un susseguirsi di rotture, valanghe e perfino amnesie». Quante vite si vivono se ogni fase della vita cancella la precedente, come un quartiere o una città che non si frequenta più? Jean Bosmans ha vent’anni e frequenta Camille, una giovane contabile che nasconde segreti e misteri. Camille fa, malvolentieri e cercando di metterlo in guardia, da intermediaria tra lui e alcuni uomini – e donne – che Jean ha conosciuto nel passato, quand’era bambino. Uomini loschi, dai nomi falsi, che hanno già assaggiato la galera, come l’equivoco giro di suo padre raccontato in Pedigree e altrove. Vorrebbero estorcergli un segreto che non possiede: nella casa in cui aveva abitato a guerra appena conclusa era nascosto un improbabile tesoro, chissà quale bottino di guerra. E lui doveva aver visto qualcosa. Comincia così un accerchiamento al quale Jean si sottrae con la fuga. E con la scrittura di un libro in cui i tre che lo braccano sono indicati con nome e cognome. Mai come ora, nella sua indagine sonnambolica, Modiano individua nel passato non un tempo da redimere ma un oggetto di vergogna e imbarazzo, da riportare alla luce per prenderne le distanze, per dire “non sono stato io”. Tra realtà e finzione che si scambiano i ruoli, una sensazione avvolgente di disagio – della vita, dell’invenzione romanzesca: ma palpabile e sottilmente artigliante – che è ultima, stilizzata variazione degli altri romanzi con i loro angoli bui. La vita e l’adolescenza randagia con il padre e la madre che li affidavano nelle mani di estranei, lui per inseguire i suoi traffici, lei per fare l’attricetta di giro. Mischiando ancora una volta le carte e proiettandosi in un personaggio – ma anche il Patrick di Pedigree è persona e personaggio – Modiano fa affiorare, mutate le circostanze, storie prelevate da altrove: il giardino con la tomba del dottor Guillotin è quello di Riduzione di pena, le fughe dal collegio quelle dell’autore adolescente e del suo personaggio più memorabile, Dora Bruder. Crescere e vivere non è ritrovare il tempo perduto, ma chiudere una porta perché l’io di ieri non intossichi quello di oggi. «Lo scherzo è durato abbastanza, occorre tagliare i ponti».
Rainer Maria Rilke, Elegie duinesi, trad. Enrico e Igea De Portu, intr. Alberto Destro, Einaudi, 1978
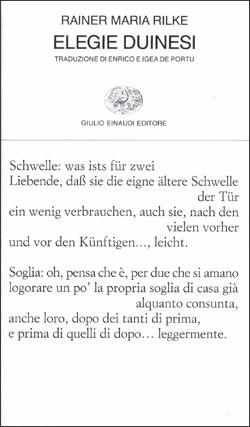
Un canto sulle macerie dell’Europa e di una civiltà (di una tradizione, parlando di Rilke il termine è importante) che la prima guerra mondiale ha spazzato via. Il praghese compone le dieci elegie in due riprese: nel 1912 presso il castello duinese dei Thurm und Taxis, credo le prime due, nel 1922 in Svizzera il resto. In mezzo c’è, conclusa l’impresa dei Quaderni di Malte Laurids Brigge, una lunga crisi creativa. Che coincide con la guerra. Come leggere le elegie? C’è la contestualizzazione storico-ideologica che suggerisce Alberto Destro: la morte di Dio, Nietzsche, la crisi della filosofia borghese e la “filosofia della crisi” (non a caso affascineranno Heidegger); la psicoanalisi freudiana come sostrato mentre il mito dell’originaria figurazione simbolista si ritrae e diventa per così dire astrazione individuale: gli angeli perfetti e terribili che, Rilke non lo sa, diventeranno qualche decennio dopo sodali dei cantautori e parafernalia pop, le Madri della decima elegia, le sparse nominazioni piegate alla necessità creativa senza “correttezza filologica”: Gaspara Stampa, Lino, le lapidi ecc. C’è la condanna della tecnica che tutto massifica e disumanizza, del mercantilismo capitalistico e del profitto. Destro dice da posizioni di romantico intimismo, di paternalismo aristocratico: e certo il dandy contemplativo e ascetico, il nomade accudito dai mecenati era anche “livrea” foggiata dal figlio di un impiegato delle ferrovie per evadere dalla sua sorte e dal suo tempo. Ma sono ripulse che risuoneranno in molti altri, vale la pena di ricordarlo, come voci che si propagano. C’è soprattutto, e pare il capo d’imputazione più pesante, l’accusa di individualismo radicale: le elegie come discorso del poeta a se stesso sulla propria poesia, che escludono qualsiasi interlocutore. Il rifiuto dell’azione per la contemplazione, la risposta puramente estetica alla crisi (la “missione” del poeta). Tutto criticamente appropriato (ma l’uomo nuovo che Destro evoca in contrappasso al borghese al tramonto è nel frattempo tramontato prima del borghese), non sono tuttavia sicuro che sia il modo migliore per fare tornare i conti. Per il solo fatto essere date alle stampe (nel 1923 da Insel Verlag), le Duinesi presuppongono un interlocutore, senza bisogno che gli si dica (lo farà Eliot nella così affine e così dissimile Waste land, citando scopertamente Baudelaire nei versi finali della “Sepoltura dei morti”) Tu hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. E il solo fatto di essere voce discorde può essere consolazione e/o sprone ad altri non pacificati. Insomma l’intima lettura di poesia, pur criticamente avvertita ed esortata a qualche cautela, non può non essere anche empatica: e rispondere non soltanto a crisi epocali ma anche a crisi individuali, a momenti di pesantezza dell’essere, a voglie di cedere o di ritrarsi. Al piacere estetico e alla momentanea rispondenza non meno che al dovere etico. Non altro erano il male di vivere incontrato (spesso) da Montale, il ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Quanto alla filosofia di Rilke, non è sistema dottrinale compiuto e chiuso (autosufficiente), ma elaborazione emotiva. Anche a diffidare del contesto, possono così risuonare in noi i versi sulla vacuità del tempo e l’inattendibilità dei sentimenti. Può trovare accoglienza, anche a non essere del tutto persuasi, il sospetto che la felicità non sia un moto ascensionale:
Ma se i morti infinitamente dovessero mai destare un simbolo in noi,
vedi che forse indicherebbero i penduli amenti
dei nocciòli spogli, oppure
la pioggia che cade su terra scura a primavera.
E noi che pensiamo la felicità
come un’ascesa, ne avremmo l’emozione
quasi sconcertante
di quando cosa ch’è felice, cade.
Emanuele Trevi, La casa del mago, Ponte alle Grazie, 2023
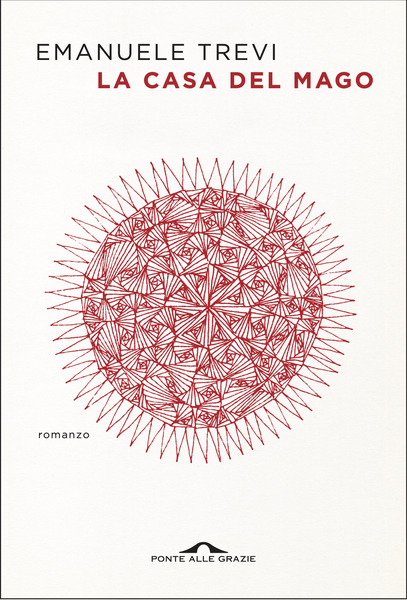
«Per questo c’è l’arte, perché noi non possiamo vivere né nell’unico né nel molteplice, siamo sudditi di un altro regno di cui solo le cose che accadono due volte ci fanno intravedere la strada.
Più invecchio, più realizzo che aveva ragione mio padre, mi sento sempre meno vero e sempre meno falso. C’è qualcosa lì in mezzo. Ho imparato ad avere fede nelle cose che accadono due volte, che rimangono sospese a metà di un’alternativa. Quando mi sento felice, per esempio la mattina appena sveglio, immagino che dita sottili e invisibili, delicate come dovrebbero essere quelle degli angeli, abbiano sciolto durante la notte i nodi delle contraddizioni e delle decisioni. Forse nei sogni che faccio e dimentico ci sono coppie di eventi che volteggiano nell’anima come colombe innamorate, come note ribattute. Avrei potuto chiedere precisazioni a mio padre, o farmi spiegare tante altre cose, ma a me piaceva stargli vicino, non attingere alla sua saggezza». È una cosa che accade due volte, in un certo senso, il ritorno alla casa del padre. Ritorno materiale, Trevi ci si trasferisce, e psichico: vivendo in quello che era stato il suo studio, il figlio cerca di sbrogliarne l’enigma. Il padre era lo psicoanalista Mario Trevi, tra i pionieri dello junghismo in Italia, amante della penombra e avvezzo a ritrarsi nel suo mondo, di poche parole e grande sapienza, affettuoso e inconoscibile – ma gli altri sono indecifrabili, per questo li raccontiamo, per restituirli in frammenti che ci sembrano rivelatori. La casa abitata da poltergeist eccentrici, che fanno incursioni notturne, spostano oggetti o li nascondono, fulminano lampadine. Perché, è dato e metafora, non sei mai padrone in casa tua. “Lo sai come è fatto” diceva la madre del padre. Nessuno sa come sono fatti gli altri, come siamo fatti noi. E l’amore non presuppone conoscenza. C’è in Trevi un’autofiction in cui l’io, presente e incalzato, guarda discreto dai bordi della narrazione, interessato agli altri più che a se stesso, ciò che rendeva incantevole ed empatico Due vite e rinnova il miracolo in quest’ultima prova. C’è un narrare divagatorio, quasi saggistico: tanti romanzi in un solo romanzo piuttosto che una narrazione lineare, e va bene così. Un narrare per accadimenti e per oggetti – il “museo” della vita del padre – che si potrebbe accostare a Perec, come accadeva nel felice e anch’esso filiale La traversata della notte di Andrea Canobbio. Non mancano le pagine grottesche – la Degenerata, Paradisa, per me le meno interessanti – e i personaggi totemici, come in altri romanzi di Trevi: ieri Metastasio (Sogni e favole), oggi Carl Gustav Jung. Ricca la galleria dei personaggi di contorno: Ernst Bernhardt, Beppe Fenoglio, Natalia Ginzburg. Mi ha colpito, anche se è cosa marginale, il colloquiale spinto – sfiga, cazzo, coglione – che ogni tanto si affaccia in uno stile alto. Non disturba, non stride, ma si fa notare come uno che va a farsi un bianchino al bar in smoking e scarpe da ginnastica.
Stefan Zweig, Addio a Rilke, Ibis, 2023
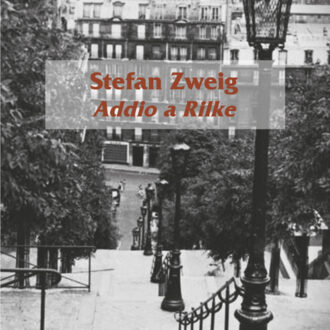
«I rostri dell’oratore non l’hanno conosciuto, è rimasto estraneo al palcoscenico e a ogni lavoro ordinario, la sua immagine non era sul mercato e la sua parola, la sua opinione erano assenti da ogni occasione e controversia del tempo; per questo sono pochi coloro che tra gli uomini hanno conosciuto davvero il suo volto, la sua vita. Spesso si trovava nelle città e anche in questa città, ma qualcosa di misterioso era sempre con lui e lo avvolgeva e nessuna presenza sentiva sua, tanto era schivo e così pieno di un distacco teso nell’ascolto. Entrava piano in ogni stanza, e non si sa se lo facesse per paura di disturbare o di essere disturbato, e il suo stesso conversare era più un buon ascolto che un flusso di parole. Spesso sulle sue labbra riposava un bel sorriso leggero, ma in lui c’erano più difesa e dissimulazione che non amore accogliente. Si provava timore ad andargli vicino, talmente profondo era il silenzio intorno a lui, eppure la sua parola veniva incontro a noi colma di gioia e chiara, pura e fraterna da quel silenzio». Stefan Zweig tiene nel 1927 la commemorazione di Rilke a Monaco, otto mesi dopo la scomparsa del poeta. Amo Zweig, non amo i discorsi ufficiali con la retorica in agguato. Ammirazione devota e retorica vanno a braccetto in questo discorso intriso di sublimismo: il poeta come asceta ed esule, la poesia come sforzo e tensione a superare se stessa, a dire l’indicibile. Tuttavia Zweig offre un abbozzo di interpretazione: la poesia di Rilke come musica agli esordi, scultura nella maturità, “dialogo con l’oltre” nella fase finale. Ammirevole, anche in un testo oratorio, la generosità costante di Zweig di mettersi “al servizio” di scrittori che ammirava, a farsi in disparte, a diventare patrocinatore disinteressato. Il suo Rilke che rifiutava i rostri dell’oratore è tutto il contrario di D’Annunzio, il suo ritrarsi fa pensare al Mario Trevi della Casa del mago, a Gadda che chiedeva all’intervistatore: «Per favore, mi lasci nell’ombra».