Stare al proprio posto, nutrire, curare, cucinare, allevare i figli, vestirsi a tono per ogni occasione: fine. Questa è l’Annie Ernaux dai venti ai trent’anni: che, infrante le catene della propria classe d’origine, apprende nel suo nuovo ruolo sociale a dimenticare sé stessa e le proprie ambizioni perfettamente incastrata, come diventa, per sfinimento, nel servaggio femminile.
Antefatto e seguito de “Il posto”, arriva a quarant’anni dall’uscita francese “La donna gelata”, pubblicato come i precedenti titoli da l’Orma editore.
Arriva a quarant’anni dall’uscita francese – Gallimard lo pubblicò nel 1981 – il terzo lavoro letterario di Annie Ernaux, tradotto per l’Orma dall’ottimo Lorenzo Flabbi. Dico lavoro letterario perché l’autrice, dopo La donna gelata, chiese all’editore di levare dalle copertine dei suoi libri la dicitura “romanzo”. Il capolavoro Il posto era in arrivo, con la tematica del “tradimento” che appare anche qui. Nasceva, quel libro, dall’esigenza di «scrivere riguardo a mio padre, alla sua vita, e a questa distanza che si è creata durante l’adolescenza tra lui e me. Una distanza di classe, ma particolare, che non ha nome. Come dell’amore separato».
Una scrittura acuminata e all’apparenza gelida, antifrastica, che negava per affermare. Una voce tenuta sottotono quasi per paura dell’incrinatura. Un gelo che diventava rabbia trattenuta, rifiuto di dire la miseria e la mancanza d’orizzonti se non esorcizzandola con uno sguardo implacabile.
È restato ragazzo di fattoria fino al militare. Le ore di lavoro non venivano conteggiate. I padroni lesinavano sul vitto. Un giorno, il trancio di carne servito sul piatto di un vecchio mandriano si è messo a ondeggiare lentamente, sotto era pieno di vermi. Era stato oltrepassato il limite del sopportabile. Il vecchio si è alzato, reclamando, che non fossero più trattati come cani. La carne è stata cambiata. Non è La corazzata Potemkin.
Così era la campagna francese agli inizi del ‘900, la stessa che fa da sfondo alla Donna gelata. «Quando leggo Proust o Mauriac, non credo che rievochino il tempo in cui mio padre era bambino. L’ambiente della sua infanzia è il Medioevo». La durezza della vita, il rifiuto dell’idillio, le atroci pagine mielose e bugiarde dei sillabari sulla buona povertà.
«Dalle vacche del mattino a quelle della sera, le piogge d’ottobre, i pesanti sacchi di mele da ribaltare nel torchio, il pollaio pieno di escrementi da spalare, avere caldo e sete. Ma anche la galette des rois, l’almanacco Vermot, le castagne arrosto, Martedì grasso non te ne andare ci metteremo a cucinare, il sidro imbottigliato e le rane fatte esplodere soffiando loro in bocca con una cannuccia. Sarebbe facile scrivere cose del genere. L’eterno ritorno delle stagioni, le gioie semplici, il silenzio dei campi. Mio padre lavorava la terra altrui, non ha visto la bellezza, lo splendore della Madre Terra e altri miti gli sono sfuggiti».
Il minimo risarcimento della vita, appena sopra la mera sopravvivenza: un cambio di vestiti, una gita di domenica, un attimo per tirare il fiato. E la figlia che si allontana come succede quando “si sale” e si cambia di ceto, quando non hai più le stesse esperienze e lo stesso mondo, e non sai spiegare un nuovo ballo, un vestito, un libro, un mobile, una spiaggia, quando ti sembra che a casa tua non capiscano cosa fai per vivere. Chi è stato il primo, in una famiglia povera, a prendere l’ascensore della mobilità sociale, sa bene che il rovescio della medaglia dell’avercela fatta è la solitudine. L’essere al tempo stesso esploratori e apolidi. L’impossibilità di restare, il rimorso per non essere restati. Questo era Il posto, che nel 1983 vinse il Prix Renaudot e mi fece conoscere la normanna Annie Ernaux, classe 1940, scrittrice francese fra le più grandi e amate.
La donna gelata ne è, assieme, antefatto e seguito.
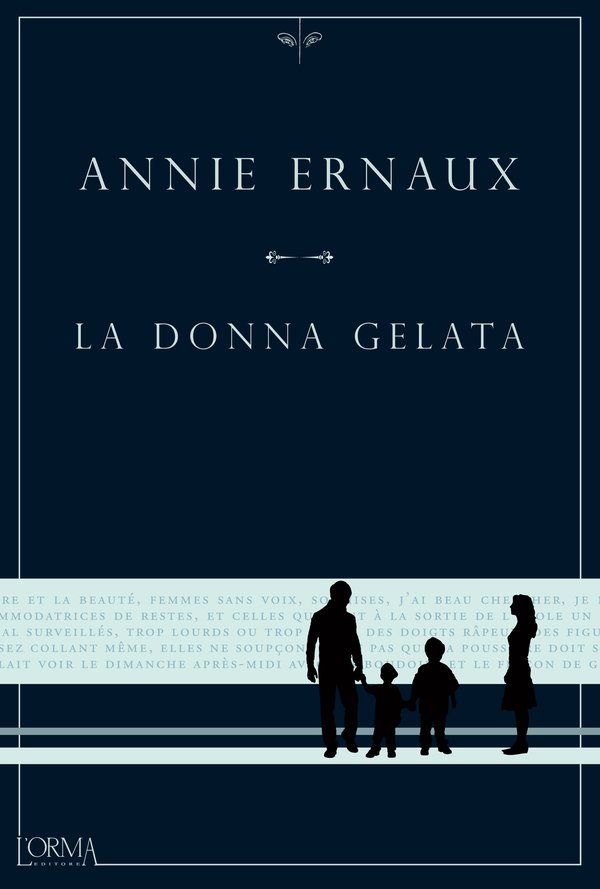
Ha dichiarato di recente Ernaux a FanPage: «Sì, il progetto di quel libro presupponeva che non ci fosse distanza tra personaggio e voce narrante: l’io de Il posto è davvero Annie Ernaux. E l’uomo di cui parlo è davvero mio padre. Non volevo che ci fosse alcun dubbio. Questa decisione ha cambiato radicalmente la mia scrittura, che ha perso quella quella forma di leggerezza ancora presente ne La donna gelata, dove ci sono dei passaggi ironici, in cui mi prendo in giro».
È vero, in La donna gelata l’autrice non è ancora compiutamente “l’etnologa di me stessa” che rivendicherà in seguito come tratto distintivo della propria ininterrotta autobiografia, ma è sulla buona strada. Qui è in scena l’apprendistato, sotto l’influenza di due diversi numi tutelari: la Colette di Sido per il tratteggio della volitiva madre campagnola, la De Beauvoir del Secondo sesso per la scoperta della condizione di servaggio femminile.
L’infanzia e l’adolescenza normanna in una famiglia povera, dalla quale soltanto in seguito l’autrice misurerà la distanza-distacco instaurata dalla sua ascesa sociale (il “tradimento di classe” del Posto), qui è narrata con orgoglio e piena felicità. La madre e le altre donne attorno a lei: fiere, non avvezze a lasciarsi dominare, “donne da esterni” come le definirà l’autrice, che lavorano come gli uomini e hanno diritto di parola, o se lo prendono, perché guadagnano. Donne spicciative ma salde negli affetti: poche coccole e nessuna smanceria, ma un’attenzione concreta ai loro cari. In questo caso alla figlia che “deve realizzarsi” ed “essere indipendente”. Donne troppo prese, come sua madre, dal gestire il bar-drogheria di famiglia, per avere tempo per rifare i letti o spolverare. Il padre tenero e sollecito, che la va a prendere a scuola e accorre preoccupato quando lei si sbuccia un ginocchio, che le insegna a piantare le verdure dell’orto e quelle verdure, la sera, le pela mentre sua moglie è occupata a contare l’incasso.
I modelli sociali della donna che è destinata a diventare attingono al sacro e al profano: l’educazione cattolica che plasma la mortificazione del corpo e inneggia alla beatitudine del sacrificio. L’educazione dei romanzi per signorine e delle riviste femminili che plaude al frivolo: vestirsi nel modo giusto, apparire nel modo giusto per Lui, aspettare Lui. E stare sempre un passo indietro, felice di scomparire. “Uomini, a tavola!” come intonerà giuliva la suocera che all’ordine perentorio del marito – “Un caffè”, e neanche l’ipocrisia formale di chiederlo per favore – risponderà, lieta di obbedire: “Arrivo!”. Pagine da antologia.
Ernaux diventerà quella donna, anche se non lo avrebbe mai creduto, con il matrimonio. Matrimonio d’amore con un coetaneo, tutti e due non laureati e convinti che non avrebbero mai seguito le orme degli altri. Il marito entra subito nel ruolo con la laurea e il primo lavoro: lui fuori (e che a casa sia tutto pronto e in ordine perché lui quando rientra deve rilassarsi), lei a badare al mènage e ai figli, lui che non butta neppure la pattumiera, poco virile (“Mi ci vedi con un grembiule addosso?”) e lei che si fa in quattro.
«Io credo che i pezzetti di cioccolato e di formaggio sbocconcellati di nascosto, le forchettate di pasta direttamente dalla pentola mi abbiano aiutata a non perdere del tutto l’appetito. Piluccare era la mia personale tavola calda, senza piatti né posate a ricordare la cerimonia del cibo, una rivincita su quell’eternità di sbobba da pianificare, comprare, cucinare. Trecentosessantacinque pasti moltiplicati per due, novecento volte la padella, la pentola sul fuoco, migliaia di uova da rompere, di fettine di carne da girare, di cartoni di latte da svuotare. Il lavoro naturale delle donne, tutte le donne. Avere una professione, come lui, presto, non mi salverà dal giogo dei pranzetti. Qual è l’incombenza che un uomo è costretto a sobbarcarsi, tutti i giorni, due volte al giorno, semplicemente in quanto uomo?».
Ernaux dai venti anni ai trent’anni: dopo avere tradito la sua classe, tradisce se stessa e le sue ambizioni. Riesce a laurearsi e diventare insegnante, ma è una conquista contesa alle pappe, ai pasti e all’aspirapolvere. Cedendo quasi sempre, quasi su tutto: perché il contrario del privilegio (maschile, padronale) è la rassegnazione (subalterna, femminile) di chi quel privilegio alla fine lo accetta. Per sfinimento. Per non farsi la nomea della malmostosa, della “cattiva madre” (“Ma non ti senti realizzata con i figli? Come puoi pensare ad altro?”), della donna poco innamorata.
Eccola in agguato, la donna gelata.
«Sono finiti senza che me ne accorgessi, i miei anni d’apprendistato. Dopo arriva l’abitudine. Una somma di intimi rumori d’interno, macinacaffè, pentole, una professoressa sobria, la moglie di un quadro che per uscire si veste Cacharel o Rodier. Una donna gelata. (…) A un passo dal confine, soltanto a un passo. Presto avrò uno di quei volti segnati, patetici, che osservo con orrore dal parrucchiere, quando giacciono riversi, gli occhi chiusi, durante lo shampoo. Quanti anni mancano, al confine delle rughe che non si possono più nascondere, dei cedimenti? Sono già io, quel volto».
Ernaux evaderà dalla prigione divorziando, qualche anno dopo.
«Per tornare me stessa ho smesso di essere gentile con gli uomini (e di perdonarli)».
Facile, per un uomo che legge queste pagine quarant’anni dopo, scansare il peso delle accuse ricordando i progressi fatti (grazie alle donne che ci hanno educato, andrebbe aggiunto). Più difficile, ma anche più onesto, ricordare, e la cronaca ce ne offre occasioni tutti i giorni, che l’antica sopraffazione maschile non è tramontata. Anche per questo la voce di Annie Ernaux è importante. E il suo vissuto personale, narrato come un prodotto sociale, è la storia, che brucia ancora, di donne e uomini.